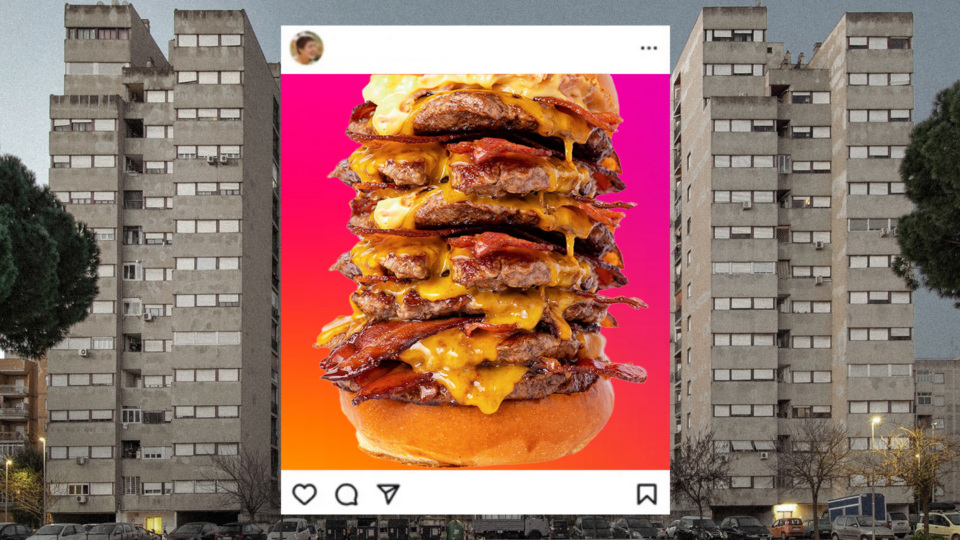Nel corso dei secoli, gli artisti hanno ritratto cucine e tavole imbandite per rappresentare potere, amore, religione e aspirazioni della loro società. Una piccola guida alle nature morte per leggere le immagini oltre ciò che mostrano.
In autunno ho tenuto un corso in università dal nome un po’ ampolloso: “Laboratorio di cultura visuale del cibo”. Nella breve descrizione che mi hanno richiesto, a una sola settimana dall’inizio, ho scritto che avrei insegnato a conoscere “le forme di rappresentazione degli alimenti e del cibo nella produzione artistica antica, moderna e contemporanea”. Insomma, un programma calibrato per un corso di una manciata di ore.
Alla fine di un semestre mi prendo sempre uno o due giorni per ragionare su cosa sono stata in grado di insegnare e cosa no. Questa volta spero soltanto che i contenuti siano stati proporzionali alla fatica che ho fatto nel racimolarli: prendendo treni a orari improbabili, studiando manuali di arte moderna che mai avrei voluto riaprire e, soprattutto, soffrendo come una matta per non potermi più sedere al tavolo numero otto del ristorante di famiglia, in cui ho preso quasi tutte le decisioni importanti della mia vita.
Una di queste è stata quella di non fare il mestiere di mio padre (oste) o di mia madre (cuoca). Quando sei figlio di ristoratori, le strade che hai davanti sono due. Puoi imparare molto presto a tenere in mano un coltello, a sorridere a un cliente quando non ne hai voglia, a muoverti attorno a uno spazio di incontro tra cose e persone. Oppure puoi rifiutare la tua storia e inventarne una nuova. Una con un personaggio che, nel pieno di una battaglia, si toglie l’armatura ed esce di scena. Forse incosciente, forse spaventato, sente che quella battaglia non è la sua. Tuttavia, ciò che prova conta meno del nome con cui sarà ricordato: disertore.
Preparare il corso in università mi ha permesso di fare i conti con la mia diserzione, provando a fondere i presupposti della mia professione (teorica) con quella dei miei genitori (pratica), guardando alla storia dell’alimentazione e della tavola attraverso la lente che preferisco, quella dello storico delle immagini.
Le immagini sono una fonte preziosa, perché tanto quanto i testi con le loro infinite variabili, ci permettono di osservare non soltanto le testimonianze di un passato lontano, ma anche le modalità con cui abbiamo scelto di rappresentare noi stessi. Secondo lo storico Peter Burke, queste sono degli ambigui “testimoni oculari”, capaci di presentare un esplicito valore storico dato dalla restituzione (più o meno figurativa) di un evento e, allo stesso modo, di nascondere al proprio interno delle tracce di qualcosa di più complesso: una simbologia che mostra, a volte senza volerlo, aspetti culturali, psicologici e sociali di un tempo e di uno spazio che non ci appartiene più.
Il tranello dell’immagine è proprio questo. Sembra leggibile, alla portata di tutti, quasi remissiva. Ma è subdola: si trasforma nel corso del tempo, cambia idea e, il più delle volte, racconta un sacco di frottole.

Pieter Aertsen, “La cuoca”, olio su tavola, 1559, Musei di Strada Nuova – Palazzo Bianco, Genova.
La storia delle immagini ci tramanda molte opere in cui l’alimentazione gioca un ruolo diverso da quello del mero nutrimento. Accade per esempio nel genere pittorico che da sempre definisce il nostro rapporto con il mondo delle cose: la natura morta. Il termine, che compare in Europa per la prima volta all’inizio del XVII secolo, rimanda alla rappresentazione di un soggetto inanimato: scrivanie ricolme di libri e oggetti, vasi di fiori, ma anche selvaggina appesa alle pareti, tavole imbandite, dispense da cui zampillano carni e formaggi o canestre di frutta e verdura.
In queste variopinte composizioni, che spaziano dalle colazioni tedesche e fiamminghe di Pieter Aertsen, George Flegel, Pieter Claesz e Clara Peteers al bodegón spagnolo di Juan Sanchez Cotán, Francisco de Zurbaran e Louis Meléndez, l’interesse per la resa del dato naturale non rappresenta soltanto un esercizio per il pittore ma anche un’occasione per esprimere le sue complesse tensioni.

Luis Egidio Meléndez, “Natura morta con pomodori e cetrioli”, 1774, olio su tela, Museo del Prado, Madrid.
Nel corso dell’epoca moderna, difatti, le nature morte si diffondono in tutta la pittura occidentale, raccontando di scambi commerciali in cui il cibo diventa una merce ambita ed esotica, e di un tempo fatto di lunghe e pericolose traversate verso territori inesplorati e di meravigliose scoperte. Prodotti importati dall’America, dall’Africa e dall’Asia arrivano nelle cucine di una borghesia bramosa di mostrare la propria ascesa e, proprio sulle tavole dipinte dagli artisti (che nascondono, non mostrandolo, l’altro lato della storia, fatto di soprusi e violenza) vengono messe in scena cibarie misteriose, sino ad allora sconosciute, come pomodori, patate, mais, zucche e zucchine.

Clara Peteers, “Natura morta con formaggio, carciofo e ciliegie”, 1625, olio su tavola, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles.
Anche in Italia la natura morta prospera da nord a sud, partendo dai quadri del bergamasco Evaristo Baschenis, in cui vicino ai lucenti strumenti musicali a corde si ritrovano mele rosse, cesti di pane e frollini, insieme a polli, anatre e piccoli volatili. E, scendendo in Toscana, con le goderecce opere di Jacopo Chimenti (detto l’Empoli), un pittore fiorentino che restituisce con sfarzo alcuni spaccati delle dispense dell’epoca, costruendo le sue composizioni su una doppia linea orizzontale: una superiore in cui svettano appesi ai ganci tripudi di selvaggina e insaccati, e una inferiore, in cui giacciono sopra la tavola stoviglie e cibi smozzicati come pagnotte, forme di pecorino, frutta secca, tartufo e fiaschi di vino.
O ancora, i quadri del laziale Pier Paolo Bonzi, un paesaggista capace di riprodurre interni di cucina ricolmi di frutta e ortaggi coloratissimi, dove melograni, fichi, cardi, cavolfiori, mele e pere disposti su eleganti alzate in argento e palchetti, appaiono agghindati come frementi ballerini in attesa dell’inizio dello spettacolo. E poi le tavole mediterranee degli allievi di Paolo Porpora, maestro napoletano del genere che forma molti pittori, tra cui Giuseppe Recco e Giovan Battista Ruoppolo, che si dilettano in arzigogolate e variopinte distese fatte di grappoli d’uva matura, meloni cangianti e angurie pronte per essere gustate.

Giuseppe Arcimboldi, “L’ortolano”, 1590-1593, olio su tavola, Museo Civico Ala Ponzone, Cremona.
Accanto alla natura morta, in cui frutta e vegetali acquisiscono anche significati e rimandi metaforici spesso contraddittori (la mela come tentazione, grazia, bellezza e riscatto; uva e vino come allegorie eucaristiche; il cardo come peccato e pene terrene…), il cibo pervade anche alcune scene tipiche della pittura di genere, dal semplice mercato con venditori e bottegai abbigliati con costumi locali, ad altre dal carattere aneddotico che si arrogano il diritto di insegnare allo spettatore quale sia la condotta morale consona; in questi quadri edificanti ambientati negli spazi domestici si ritrovano spesso umili famigliole che mangiano attorno al focolare, dove le donne ricoprono il ruolo esclusivo di madri e mogli intente a nutrire i propri cari, ritratte mentre distribuiscono con benevolenza il cibo direttamente dai pentoloni di rame, talvolta persino imboccando gli altri commensali, o allattando i propri neonati con una calcata espressione di delizia.
Oppure, nella versione opposta che rappresentata i personaggi in spazi sociali moderni, fra i tavoli di osterie e taverne, si osservano i clienti – sempre rigorosamente uomini – intenti a bere e consumare pasti frugali in compagnia di prosperose signore dagli abiti succinti. Anziane ammiccanti o giovani e floride dame del popolo, le donne proposte da queste immagini sono l’altra faccia dell’educazione al buon costume, mostrando lo sfacelo di una carne troppo abbondante, imbevuta nei peccati di gola e lussuria. Una carne che, nelle tele di pittori sfrontati come Vincenzo Campi e Bartolomeo Passerotti, trasuda tutta la fobia dell’uomo per la libertà sessuale del corpo femminile, deformato dall’effetto afrodisiaco ed eccitante di cibi e bevande ingeriti senza alcuna misura.

Jacopo Chimenti (L’Empoli), “Dispensa con botte, selvaggina, carni e vasellami”, 1624, olio su tela, Uffizi, Firenze.
La rappresentazione degli alimenti passa però anche per un’altra scena protagonista nel mondo delle arti: il banchetto. Dipinto e scolpito sin dalle epoche più arcaiche su tombe, sarcofagi, tavole e tele di ogni dimensione, il banchetto nasconde dietro a un’apparente scena di convivialità e nutrimento una trama sociale fitta di tensioni, confidenze e drammi sentimentali. Accade in tutti gli episodi citati nei testi sacri, dalla Bibbia e ai Vangeli, come nelle nozze di Cana, nella cena a Emmaus o nel banchetto di Erode, dipinte da maestri come Lippi, Masolino, Veronese e Caravaggio. E, sopra tutte, nella regina tra le immagini del Nuovo Testamento, in cui viene rappresentato l’archetipo del disertore: l’Ultima cena. Dopo Eva, difatti, Giuda appare come il simbolo supremo dell’abbandono della retta via, colui che ha tradito Gesù e tutta la sua gente e che, proprio durante un pasto, viene finalmente scoperto. I diversi personaggi tesi nei loro gesti, vengono così calati nella fantasia gastronomica dei pittori, attorniati da alimenti che spesso eccedono quelli descritti nelle fonti evangeliche, rivelando i luoghi d’origine degli autori che insieme a pane e vino dipingono tranci di pesce e agnello, formaggio, fichi, castagne e gamberi di fiume.

Vincenzo Campi, “I mangiatori di ricotta”, 1580, olio su tela, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lione.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Cena in Emmaus”, olio su tela, 1601-1602, National Gallery, Londra.
Nell’affresco dipinto da Giotto per la Cappella degli Scrovegni di Padova tra il 1303 e il 1305, però, a un primo sguardo, il cibo appare surclassato dall’ambientazione in cui sono inseriti i personaggi, mettendo in risalto una nuova sensibilità per la prospettiva che inizia lentamente a farsi spazio nella storia della pittura dell’Occidente. Eppure, si può osservare una scelta iconografica precisa di derivazione bizantina, in cui Gesù non spezza il pane per donarlo ai suoi discepoli ma è intento a intingere un boccone nel piatto per poi donarlo a Giuda, annunciando davanti a tutti il volto del tradimento. Nel cenacolo dunque le pietanze, la tavola imbandita e il modo in cui i partecipanti vi siedono attorno, servono non soltanto a immortalare un avvenimento, ma a concretizzarne i valori e le riflessioni sottese, spirituali e umane. Come avviene in tutte le altre rappresentazioni tratte dai testi sacri – dalla caduta della manna dal cielo, alla cena a casa di Simone, al convito a casa di Levi sino alla visita da Marta e Maria – in cui l’atto del mangiare rimanda con chiarezza al nutrimento fisico e mentale e, dall’altro, a qualcosa di simbolico, che puoi guadagnare o aver perduto per sempre.

Giotto, “L’ultima cena”, affresco, 1303-1305, Cappella degli Scrovegni, Padova.
Lungi dall’essere un tema esclusivamente religioso, il convivio – cum vivere, ‘vivere insieme’ – non è neanche una pura occasione mondana, ma un tavolo in cui il cibo, la seduta e i movimenti permessi diventano frequenze di un codice millenario. Uno spazio di trasmissione di messaggi sociali. Massimo Montanari lo spiega bene in merito al mondo antico, dove il banchetto diventa uno strumento “per affermare o negare i valori della vita. Gli aspetti rituali del gesto prendono il sopravvento. A banchetto l’uomo celebra la propria rigenerazione quotidiana ma, facendolo assieme ai suoi simili, impiega quel gesto come veicolo di comunicazione con loro”. E molte volte, senza di loro.
La tavola non è mai un semplice oggetto, è un luogo semantico, in cui appartenenza o estraneità a una comunità si mettono in atto. È uno spazio scenico pieno di ingranaggi volti a innescare i rapporti di forza e le gerarchie di potere, in cui alcuni prendono decisioni che segnano la politica e la cultura di un gruppo di persone, di un villaggio, di un regno, a tratti contribuendo a ridefinire i contorni di un periodo storico. A tavola, difatti, le donne non siedono quasi mai. E quando vi siedono, oltre ad avere uno spazio di azione ristretto, non possono farlo liberamente: hanno sempre un posto assegnato accanto all’uomo che le possiede o che le dovrà possedere.

Judy Chicago, “The Dinner Party”, ceramica, porcellana, tessuto, 1974–79, Brooklyn Museum, New York.
Ma la tavola è anche il luogo in cui queste dinamiche possono essere messe in discussione, violate e tradite. Lo fa in maniera deliberata l’artista femminista Judy Chicago con la sua opera creata tra il 1974 e il 1979: The Dinner Party. Questa monumentale installazione, visibile nella collezione permanente del Brooklyn Museum di New York, riproduce un’immensa tavola triangolare, senza sedie, in cui vi sono trentanove coperti – tredici per lato, come i partecipanti dell’ultima cena – ognuno riservato a una donna esclusa dalla storia.
A ogni posto spettano un piatto, un calice e delle posate in ceramica di fattura artigianale, dipinte con decori colorati come fiori e farfalle (dal chiaro rimando all’organo sessuale femminile) che poggiano su una tovaglietta ricamata con il nome della figura a cui l’artista intende ridare un posto a tavola. Le donne prescelte sono divinità del mondo antico, filosofe, scrittrici, artiste e attiviste, come Kālī, Saffo, Ildegarda von Bingen, Isabella d’Este, Artemisia Gentileschi, sino a Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf e Georgia O’ Keeffe. La tavola poggia su un basamento di piastrelle dedicate ad altri 999 nomi di donne dimenticate, stagliandosi in tutta la sua cercata prepotenza. Un viaggio cronologico nelle omissioni del passato, che vuole riscrivere la storia della cultura occidentale e orientale. Un inquietante mausoleo che interroga senza giri di parole coloro che hanno sempre avuto il potere di scrivere la storia: gli uomini.
“Le immagini sono una fonte preziosa, perché tanto quanto i testi con le loro infinite variabili, ci permettono di osservare non soltanto le testimonianze di un passato lontano, ma anche le modalità con cui abbiamo scelto di rappresentare noi stessi”.
Un altro esempio di opera che sfida più di un sistema è quella ideata dall’artista surrealista Mereth Oppenheim, che nel 1936 concepisce Min gouvernant (La mia governante). In questa, lontano dalla figurazione tanto quanto quella di Chicago, Oppenheim rovescia i piani utilizzando non più una tavola ma un vassoio, sul quale poggia un paio di decolleté bianche. Le scarpe, ribaltate e legate fra loro con dello spago (i cui tacchi sono coronati dalle decorazioni di carta sfrangiata dei giorni di festa) assumono così l’impiattamento tipico di un prelibato arrosto. Insieme al linguaggio, impiegato nel titolo per rimandare a uno dei tanti mestieri della cura ricoperti di norma dalle donne, l’artista gioca così con il ready-made: decontestualizza l’oggetto dal proprio ambiente. Lo scinde dalla sua funzione originaria e gli assegna un significato nuovo.
Inventa, attraverso un’idea, una forma moderna di natura morta che cerca di forzare il pensiero verso un doppio binario. Da un lato, portando lo spettatore a mettere in discussione la rappresentazione figurativa della realtà, che a partire dalle Avanguardie perde terreno in favore di nuove sperimentazioni date dalla riproduzione dell’immagine e dalla potenza del gesto, di un’azione in grado di risemantizzare qualunque cosa. Dall’altro, cercando di esasperare il nostro sguardo, costringendoci a osservare uno dei simboli della femminilità e della sua avvenenza in una chiave onirica e feticista, che rivela la violenza di un’appropriazione che passa sempre e prima di tutto attraverso il visuale.

Meret Oppenheim, “Min gouvernant”, 1936/1967, metallo, scarpe, spago, carta, Moderna Museets, Stoccolma.
Questa appropriazione, sebbene di natura diversa e del tutto legale, è la stessa che rivivo le poche volte che mi capita di tornare a mangiare in quella che un tempo era la mia seconda casa. Il nome del locale – quello di battesimo di mia madre – ai miei occhi ora è soltanto un titolo, un feticcio senza voce. Gli sgabelli, il banco, i lampadari firmati e i calici con le scritte felici stampate sopra mi sembrano strani objet trouvé di cui non capisco il senso. Il tavolo otto non esiste più e le pareti hanno cambiato colore, in realtà in meglio. Al loro interno un gruppo di giovani uomini sperimenta una nuova forma di famiglia e lavoro, inventando un’intimità che ora non mi appartiene e guardo da lontano.
Mentre vado a mangiare da un’altra parte, penso alla mia condizione di disertore. Alla vanagloria di voler andare oltre a questi mestieri che, prima di entrare nel mirabolante mondo del food, facevano paura. Paura per la loro natura umile e per gli effetti gravosi che hanno sul corpo e sulla mente. Paura perché comportano un’esposizione verso l’altro. Paura perché, se togliamo tutte le sovrastrutture che abbiamo inventato, possiamo ancora ricordare quanto questi mestieri ci mettano in contatto con emozioni e azioni ancestrali, che raramente – soprattutto se siamo donne – abbiamo avuto lo spazio di governare: desiderare, nutrire, prendersi cura, godere, servire, fidarsi, esprimere e, a volte, rinunciare.
Inizio a tastare la radice del mio abbandono e dopo un lungo deambulare mi siedo al tavolo di un posto qualunque, con il quale non ho alcun legame affettivo. Provo a costringermi ma non riesco a smettere di fare attenzione a tutto. All’ambiente e a come ci stanno dentro i clienti. Alle luci e ai rumori che si spingono fuori dalla cucina. Agli sguardi tra il personale, al cibo e, naturalmente, alla cura verso le cose e le persone. Una cura verso l’altro che ho imparato molto presto a praticare come se fosse un mestiere, con pochissima parsimonia. Una cura in cui credo e dalla quale insieme rifuggo. Per volontà di emancipazione ma anche, forse, per rivendicare uno spazio di libertà femminile che per esistere deve essere prima di tutto immaginato.
Lontano dal nutrimento incondizionato e, nella mia storia, dai tavoli ai quali le donne per secoli hanno cucinato e servito, senza mai riuscire a sedersi.