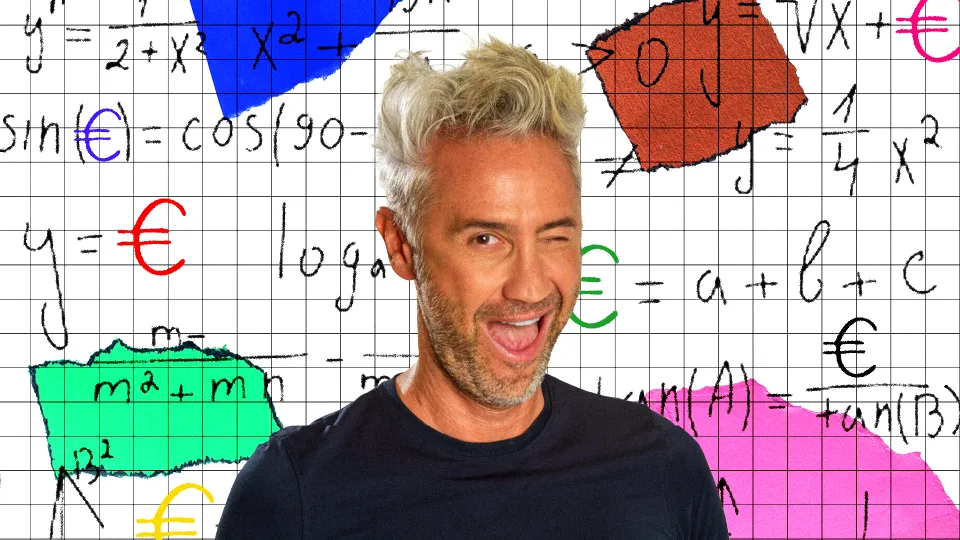Da Homer Simpson a Thomas Bernhard, passando per Arbasino e per i fratelli Coen: cosa dicono i pantaloni di noi e della società.
Vengo dalla tribù degli scampanati, dei pantaloni a zampa d’elefante. Non fu una scelta mia, bensì il destino di una intera generazione. Con gli anni, tuttavia, ci moderammo, per assestarci su un modello classico, con 25 cm circa di risvolto. Ma il consumismo non fu mai il mio forte, prova ne sia che ormai da molti anni non acquistavo un paio di calzoni. Mi spinsi a farlo quando compii gli anni, convinto di poter sbrigare tutto quanto in fretta. Quale non fu la mia sorpresa, invece, nello scoprire che il mondo era cambiato: ormai gli orli esistenti erano solamente intorno ai 20 cm… Alla fine mi arresi e venni via con un paio di pantaloni “a cicca”, ossia strettissimi.
Chi ero, però, io, per andare in giro abbigliato così? Di fatto, mi ero travestito da contemporaneo… Fu in quel momento che mi tornò in mente la puntata dei Simpson raccontatami da un amico, puntata in cui il patriarca Homer cerca ossessivamente i pantaloni blu che ha sempre indossato, ora fuori produzione. La sua ricerca rappresenta, a pensarci bene, un bisogno elementare, ridotto a una funzione base: “uomo → pantaloni. Ben altra, tuttavia, era la fonte nobile delle mie ossessioni vestiarie: niente di meno che il grande Thomas Bernhard, con una sua operina teatrale intitolata Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me.
Deliziosa miscela di intelligenza e sarcasmo, la pièce si offre come un testo anti-naturalista ma realistico, astratto e insieme cronachistico. È cioè un “dramoletto” (questa la definizione dell’autore), uno scarabocchio felicissimo in cui il protagonista impallina l’ambiente del teatro con un particolare accanimento per quello austriaco: “Probabilmente questa Austria è l’unica commedia totale del mondo”. Giocando sullo speciale statuto anagrafico dei suoi eroi, Bernhard mette in scena sé stesso e Peymann, il regista con cui, per sette anni, collaborò al teatro di Bochum. L’azione nasce appunto dall’evocazione di quella stagione irripetibile, e dal successivo trasferimento nell’odiata Vienna.
A scongiurare ogni forma di psicologismo, ecco però, sin dalle prime battute, un singolare fenomeno stilistico. Infatti l’andamento del testo è come risucchiato da vortici, percorso da continue turbolenze linguistiche. A rigore, qui non c’è alcuna storia, ma un’ininterrotta serie di mulinelli e gorghi di un discorso dominato dalla improrogabile necessità di comperare un paio di pantaloni. Si tratta di un procedimento tipico di Bernhard. Come ha osservato Elisabetta Nicolini, quest’artista del disprezzo e dell’esagerazione affida la sua scrittura alla Besessenheit, all’ossessione, all’invasamento, a una martellante iterazione di frasi, spezzoni o singole parole, tanto davanti alla morte, quanto all’interno di un negozio di abbigliamento. Così il suo Claus Peymann finisce per danzare sulla corrente di un dialogo nevrotico e leggero. La commedia, cioè, corrisponde al versante soleggiato di Bernhard, al lato ilare di una poetica irrimediabilmente segnata dalla desolazione. Non per niente, Aldo Gargani ha osservato che l’opera dello scrittore austriaco rappresenta “la più potente e drastica domanda di senso del nostro tempo”. L’affermazione è illuminante, a patto però di ricordare che non ci si trova di fronte a un filosofo, bensì a uno scrittore, a un uomo di teatro, con quel tanto di provocatorio e mistificatorio, dolorante, istrionico, ammaccato, che fa dire a un suo personaggio: “Io lavoro con i miei concetti che ho acquisito mercanteggiandoli con il caos, del tutto per mio conto” – mercanteggiandoli proprio come un paio di calzoni.
Intanto camminavo, tutto bello attillato, perfettamente nascosto in una folla composta da uomini e donne a loro volta attillati. Continuavo a fantasticare sul tema dell’ambiente sartoriale, ed eccomi comparire davanti l’immagine di Alberto Arbasino e di un suo libro intitolato La vita bassa. Pur senza essere sfiorato dalla tragedia, il romanziere italiano affidò a tale doppio senso alcune riflessioni volte a descrivere un abbassamento generale del livello culturale, morale e stilistico della società contemporanea. Il gioco di parole verte su due piani: uno relativo al costume, riferendosi a un taglio di moda negli anni Novanta del secolo scorso e inteso come segno di sciatteria, perdita di eleganza; l’altro di tipo metaforico e culturale, alludendo a un più generale abbassamento del gusto. In breve, conferma ChatGpt, la “vita bassa” è il simbolo di un’epoca che ha deciso di abbassarsi, non solo nei calzoni ma anche nel pensiero.
“Vengo dalla tribù degli scampanati, dei pantaloni a zampa d’elefante. Non fu una scelta mia, bensì il destino di una intera generazione. Con gli anni, tuttavia, ci moderammo, per assestarci su un modello classico, con 25 cm circa di risvolto”.
Ero quasi arrivato a casa mia, quando mi venne in mente, finalmente, il più sensazionale dei precedenti, questa volta di tipo cinematografico. Mi riferisco a Mister Hula Hoop (The Hudsucker Proxy), un film dei fratelli Coen uscito nel 1994 con Paul Newman e Tim Robbins. Andavo in particolare alla scena in cui un sarto di origine italiana esamina i pantaloni troppo corti di un cliente, esclamando: “I pantaloni non sono sbagliati… è il mondo che è troppo grande”, con la variante: “Un buon sarto non allunga i calzoni: abbassa il cliente”. Ma la sequenza più importante era un’altra, ossia quella in cui lo stesso sarto prima propone di eseguire una doppia cucitura, poi, di fronte al rifiuto del cliente, decide di procedere ugualmente anche se a proprie spese. Inutile dire che, più tardi, sarà proprio questo intervento provvidenziale a salvare la vita dell’avventore, gettatosi da un grattacielo e rimasto miracolosamente impigliato con l’abito.
Beh, malgrado il mio risvolto striminzito, ora potevo dirmi decisamente soddisfatto. Eppure, la matrioska delle mie apparizioni (a parte il Majakovskij della Nuvola in calzoni) non aveva ancora finito di riservarmi sorprese, anzi, me ne aspettava una assai più misteriosa delle altre. Dove avevo letto quello scambio di battute? Con chi avevo discusso di quella frase misterica? Non ne avevo più idea. Si trattava comunque di un reperto preziosissimo, in quanto aveva a che fare niente di meno che con ragioni teologiche. Eccolo. Un sarto si rivolge al suo fedele acquirente: “Bene così. Allora, torni tra un mese”. L’altro: ”Un mese? Ma sta scherzando? Dio ha fatto il mondo in una settimana”. Il sarto: “Appunto: guardi cos’ha combinato”. Qui arriviamo davvero al vertice delle possibili interpretazioni. Siamo a una vera e propria gnosi del pantalone, pensavo, mentre con le mie caviglie fasciate, ah!, quanto strettamente fasciate, andavo aprendo il portone di casa.