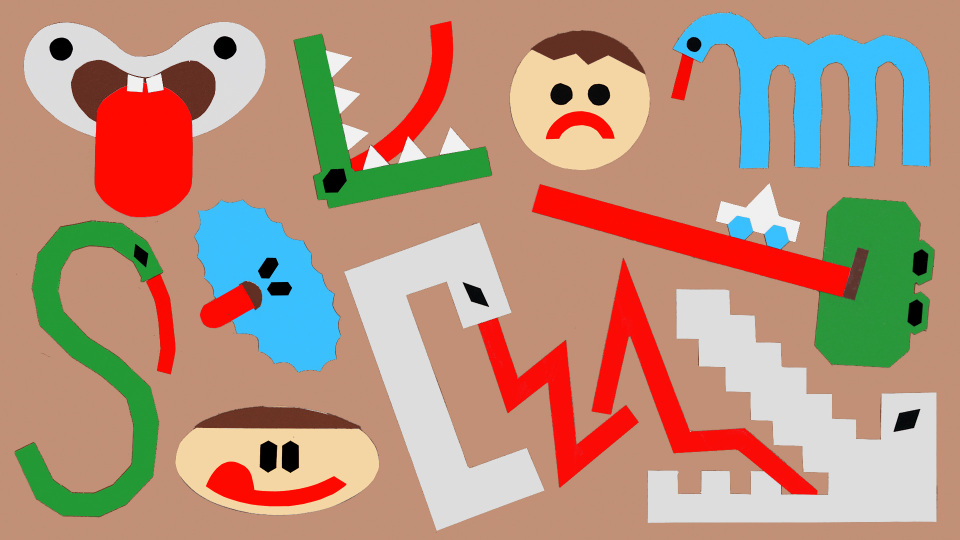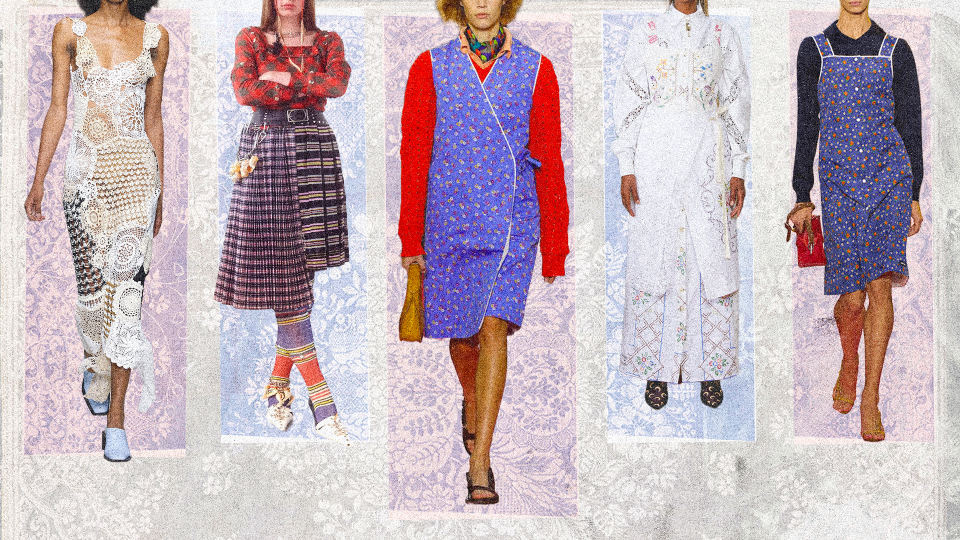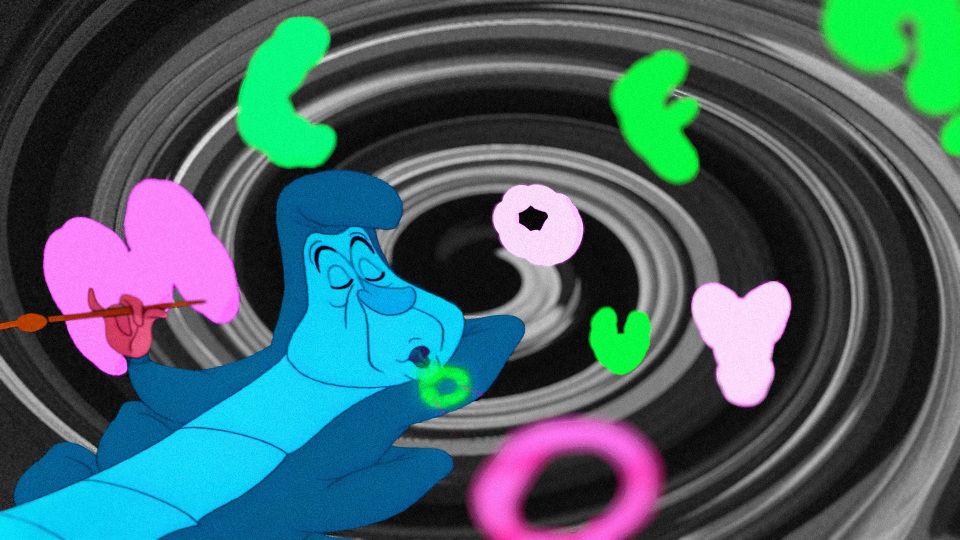Con il nuovo mese inauguriamo anche un nuovo tema: ve lo presentiamo qui.
Leo Spitzer, un importantissimo linguista e critico austriaco attivo nella prima metà del Novecento, nei suoi studi “aveva notato che a ogni emozione che devia dal nostro stato d’animo normale, corrisponde, nel linguaggio, una deviazione dal modo di esprimersi consueto; e viceversa, da un modo linguistico che devia dall’uso normale si inferisce uno stato psichico inconsueto”. Secondo questa idea, insomma, quella particolare espressione linguistica riflette una particolare condizione dello spirito.
Da questa intuizione nasce una disciplina, che prende il nome di stilistica, e guadagna poi una tradizione anche gloriosa. L’idea è che si possa accedere agli stati emotivi di un autore, abbordandoli dalla sua lingua, passando per i suoi tic e il suo stile.
Certo, gli scrittori hanno provato a sconfessare o a respingere un’identità tra il contenuto psichico e gli affioramenti del loro linguaggio, come a scacciare l’idea stessa di essere conosciuti davvero.
Thomas Bernhard, pur essendo un autore molto apprezzato — lo testimoniano i premi a cui ha dedicato un libro — così si esprimeva: “Parlo un linguaggio che io solo capisco, nessun altro, così come ognuno parla soltanto il proprio linguaggio, e quelli che credono di capire sono degli imbecilli oppure dei ciarlatani”.
Eppure ci sono stati critici molto persuasivi che hanno esplorato il nesso tra psiche e linguaggio. Si pensi a Contini che in Gadda ravvisava quanto di risentimento, di passione e di nevrastenia ci fosse dietro al fatto del «pastiche». Quale stato d’animo, cioè, lo spingesse verso scritture così mescidate, scandalose.
Certo, c’entra poi lo specifico di ogni lingua, che possiede le sue caratteristiche proprie come pure le sue percezioni: e sono tutti aspetti che proveremo a sondare in questo monografico autunnale.
In una pagina delle Anime Morte, Gogol paragona un’innumerevole moltitudine di chiese e monasteri, con le loro cupole, le loro guglie, le loro croci, a quello delle lingue. Lo scrittore nota così che, allo stesso modo, ogni popolo ha un proprio linguaggio, nel quale, qualunque cosa esprima, riflette nel modo di esprimerla un lato dell’indole che gli è propria.
Molti, per esempio, hanno giudicato l’italiano una lingua melodiosa, alcuni cantabile; Ezra Pound in un appunto del 1930 annota invece:
“La lingua è qui per servire il pensiero.
Non c’è per conservarla in un museo.
La lingua italiana ha bisogno di carta vetrata”.
C’è poi il modo in cui i parlanti percepiscono la propria lingua. Pasolini, in un importante intervento degli anni ’60, percepiva l’affermarsi di un nuovo italiano derivante dal sottolinguaggio tecnico del Nord industriale. Non troppo diversamente la pensava Calvino, che nel 1964 fa scrivere a un neanche troppo immaginario brigadiere un verbale nell’antilingua, colma di formule burocratiche astruse, che si stava secondo lui affermando.
Questa della tecnicizzazione dell’italiano, per esempio, è una polemica linguistica che durerà a lungo e proseguirà dagli anni ’70 fino agli anni ’90, quando ne subentreranno di altre.
È la ragione che fa pronunciare a Fantozzi una frase inaudita: “l’italiano è una lingua maledetta!”.
E chi meglio di Villaggio ha saputo mettere alla berlina la lingua del ceto impiegatizio con la sua aggettivazione enfatica, i congiuntivi immancabilmente erronei, le affettate formule d’ossequio per i direttori megalaticci.
In proposito, Claudio Magris, uno dei più importanti scrittori viventi, che ha sempre però guardato oltralpe, ha notato che: “L’italiano è la lingua della dilazione e dell’accomodamento con l’insostenibile, buona per divagare e confondere un po’ il destino a furia di chiacchiere”.
E in quanto a chiacchiere, Arbasino è l’autore che forse più di tutti ha saputo fermare sulla pagina quello che definiva il sound del parlato, e cioè il birignao italiano, in una lingua finalmente rapida e briosa. Laddove nei suoi saggi, come aveva fatto già Flaubert tramite Bouvard e Pécuchet, ha provato a stipare il trovarobato linguistico, e gli automatismi più vieti e pigri, come pure le idee ricevute che alimentano il chiacchiericcio mediatico, i “discorzi” che lo scrittore perfidamente scriveva con la z, il brusio.
Ecco, su Lucy proveremo a raccontare come è cambiata la nostra lingua e quali ragioni sociali la guidano, quali magari la influenzano.
Tenteremo di ipotizzare dove si sta dirigendo e quali aspetti pare invece avere abbandonato. Lo faremo perché ci riguarda tutti e perché è un punto d’ingresso privilegiato per comprendere il mondo in cui viviamo.
Uno dei più importanti filosofi contemporanei, Lévinas, ha detto che “Il linguaggio non si riferisce alla generalità dei concetti ma getta le basi di un possesso comune”.
Approfondiremo dunque il suo rapporto con la tecnologia e internet, il suo nesso col potere e il sesso, l’uso che ne fanno appunto gli scrittori e poeti, gli artisti, il ruolo della lingua nelle nostre relazioni, insomma i molti umori di cui si nutre il modo in cui parliamo o scriviamo.