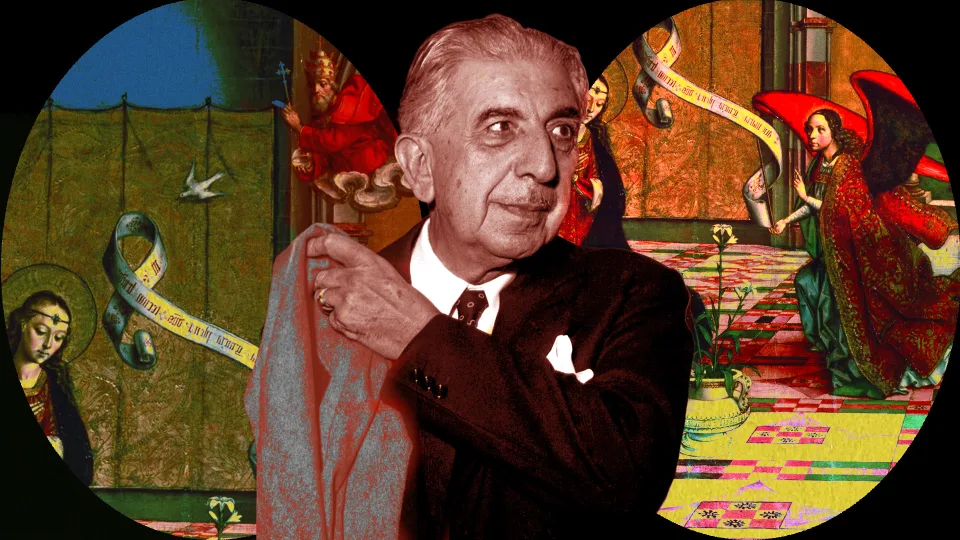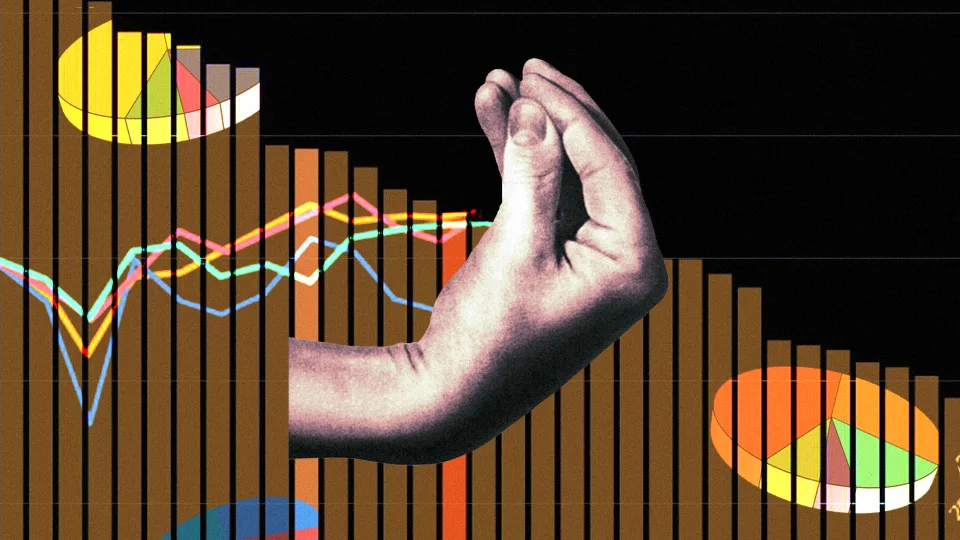Per Abscondita è da poco stato pubblicato un saggio finora inedito di uno dei più grandi storici dell’arte di sempre. È l’occasione per riscoprire lo stile di un intellettuale che, facendo sua la lezione di Proust, ha ideato un'intera maniera (insieme influente e personalissima) di scrivere.
Famosamente, e secondo inclinazioni sintomatiche, Roberto Longhi, in un saggio di grande risonanza servito da apertura nel 1950 per il numero d’avvio di «Paragone» (bimestrale diretto assieme alla moglie Anna Banti, già autrice del celebre romanzo Artemisia), si trovò a citare, fra le matrici del suo mestiere, la Recherche proustiana, in un passo che compete con le altre, molte referenze letterarie incluse in quel contributo di maturità, dalla Firenze del Duecento alla critica impressionista.
Storico dell’arte di fama ormai leggendaria, padre nobile di un folto e prestigiosissimo plotone di autori, destinati a segnare indelebilmente l’idea stessa di letteratura nell’Italia post-bellica (da Attilio Bertolucci a Pier Paolo Pasolini, da Giogio Bassani a Giovanni Testori e alla generazione ‘giovane’ di Alberto Arbasino), Longhi sentiva l’esigenza di esplicare il proprio metodo – che gli allievi descrivevano spesso come “stregonesco” per le strabilianti intuizioni, viatico di riconoscimenti inattesi e impreviste riscoperte – partendo da fondamenti, in un certo senso, didattici, nel nutrire il profilo otto-novecentesco del connoisseur di un nobile pedigree, di una tradizione alta; di valutare, quindi, le qualità dell’“occhio”, trasportandole in una dimensione “scientifica”, arricchendo di un contesto specifico ogni puntuale attribuzione.
Una vera e propria attitudine pedagogica, capace di segnare indelebilmente la fase estrema del suo lavoro – la terza, ricorrendo alla sequenza proposta dall’amico e sodale Gianfranco Contini, che sulla base dello stile vi individuava il momento “classico” di un’ispirazione organica (passata prima dall’ “espressionismo”, poi dal “manierismo” e giunta infine al tempo dell’intellegibilità comunicativa, in dialogo pure coi linguaggi del documentario e con l’architettura cristallina delle grandi mostre ‘popolari’).
Al termine del suo Proposte per una critica d’arte – presentate l’anno prima in forma di conferenza al XXI Congresso veneziano del PEN Club – Longhi citava lo scrittore, in relazione al suo capolavoro compiuto ma non ancora tradotto integralmente in Italia sebbene un interesse crescente stesse da tempo montando, anche al sud delle Alpi, attorno a quell’epica mondana (la fatica, colossale quanto necessaria, era infatti in corso d’opera per Einaudi, grazie al contributo di intellettuali come Natalia Ginzburg, Franco Fortini e Giorgio Caproni). Si tratta di un brano disteso, che così conclude, questionando la metodologia e i fini da perseguire nel rispondere alle interrogazioni mosse da un’opera d’arte, con la mente all’efficace produzione critica di fine Ottocento:
“Risorge [in quel tempo] la ricerca dell’ambiente? Può darsi, ma non sarà più nel senso grossolanamente deterministico e parziale dei tempi di Ippolito Taine. Gli artisti crescevano allora (diceva il Cocteau) come buone cipolle da un determinato suolo, buono e favorevole anch’esso. Ma se si ripercorre da allora il progresso nell’intender quasi ad infinitum la trama dei rapporti, si trova che anche qui il maggior merito dell’arricchimento spetta soprattutto ai prosatori o poeti (non importa come chiamarli). Per un esempio: la costruzione quasi molecolare del destino terrestre del pittore Eltsir nel poema (o romanzo storico) di Proust può servire di eccellente modello al critico (dunque allo storico) dell’arte per meglio intrecciare ad infinitum le cosiddette biografie spirituali dei suoi protagonisti, in una vera e propria ‘recherche du temps perdu’. E chi dice che quell’esempio non abbia già fruttificato?”
Le dense pagine del saggio antepongono al precedente virtuoso offerto dallo scrittore francese (nel prediligere, comunque, fra gli snodi della Recherche, la vita del pittore Eltsir alla morte ridicola dello scrittore Bergotte, per troppa bellezza, di fronte a un capolavoro di Vermeer) l’ermeneutica in versi di un Baudelaire o di un Valéry, profeti non meno necessari per il discorso sulle arti della modernità: è allora immaginabile che il riferimento sornione al “genere” dell’opera proustiana – poema? romanzo storico? – fosse pensato dall’autore come una strizzata d’occhio all’uditorio italiano d’immediato dopoguerra, nutrito da un necessario ritorno alla “realtà” e da una sensiblerie vorace d’imprese sostanziose, di evidenze tonificanti, di vincoli incarnati nei meccanismi resistenti di un tempo, di una società.
L’opus magnum di Proust si sarebbe così costituito da ponte indispensabile fra epoche successive, riscattandosi dai limiti costretti dell’estetismo grazie alla potenza dell’affresco sociale. E non è certo un caso che, di lì a un anno, proprio Longhi – lo sottolineava nel 1980 Giovanni Previtali, allievo fedele e interprete acuto – avrebbe popolato le tele di Caravaggio di un immaginario cinematografico da neorealismo trionfante: fra le pagine del catalogo per la mostra milanese da lui stesso curata – la prima grande retrospettiva sul genio secentesco, sbocco spettacolare delle sue ricerche pioniere – avrebbe cioè riconosciuto clienti d’osterie trasteverine nei fanciulli ricciuti, pigri del Merisi o ciociarelle piangenti, sedotte e abbandonate, nelle ragazze perdute, in lacrime nel coin spoglio d’una povera stanza oppure disperate ai piedi d’un catafalco improvvisato.
Che l’operazione retorica suggerita dalle Proposte, rispetto alla “funzione Proust” e al suo valore per la storia dell’arte, fosse un aggiornamento sardonico del Longhi sul nuovo se stesso uscito dalla guerra e dal difficile tempo bolognese, quello dell’insegnamento presso l’ateneo cittadino (conclusosi con coraggio nel ’43, al drammatico instaurarsi della Repubblica di Salò), lo dimostra un contributo sin qui ignoto, scoperto nel ricco archivio della fondazione che porta il suo nome (e che ha sede a Firenze, in via Benedetto Fortini, nella villa severa in cui visse con la moglie fino alla morte nel giugno 1970). In corpo a un saggio ponderoso, dedicato alla figura del pittore Pedro Berruguete – fra gli antesignani per la diffusione di un linguaggio prospettico nei regni spagnoli a cavallo di Quattro e Cinquecento – lo storico si rifà proprio al magistero della Recherche: e trattandosi di uno scritto databile alla metà degli anni Venti (secondo quanto discusso nella prefazione che lo introduce per il volumetto da poco stampato nella serie “Carte d’artista”, proposta dalla casa editrice Abscondita), si offre come un’anticipazione di non poco conto per questo tipo di rimando, oltre che di un secondo, importante richiamo nell’ambito di un discreto citazionismo riferito al romanziere parigino.
Il testo nel suo insieme va, d’altronde, considerato una fatica parallela rispetto al grande cantiere del Piero della Francesca, la monografia che avrebbe consacrato – in maniera definitiva e con esiti imprevedibili, in termini d’impatto e d’influenza – l’autorevole cultura di Longhi, uscendo nell’estate del 1927 sotto all’etichetta dei Valori Plastici di Mario Broglio. In tal senso il saggio getta dunque luce, in maniera assai eloquente, su una stagione – faconda e feconda – del suo impegno intellettuale, aiutando, in qualche misura, a chiarire i moventi di quell’altro, più gravoso cantiere, che si dovette avviare attorno al ‘26 consumandosi in un fuoco di grande tensione creativa e coronando indagini inauguratesi nel decennio precedente (sulle pagine della rivista “L’Arte”, con l’articolo Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana).
Nell’investigazione serratissima in cui si risolve lo studio su Berruguete – sul cui destino finale non siamo, ad oggi, meglio informati (un libro? Un lungo articolo?) – la nomea di Proust si carica d’altronde di un peso risolutivo. Longhi, infatti, la utilizza per spiegare in che modo, durante la sua prima visita al Museo del Prado (nel giro di un periplo continentale, avveratosi all’inizio degli anni Venti per la generosità del mercante Alessandro Contini-Bonacossi), si fosse convinto di riconoscere la mano dell’artista – autore di una serie di pannelli, provenienti dal convento domenicano di Santo Tomás di Ávila – in quella dell’ancora anonimo pittore di alcuni ritratti d’Uomini illustri montati un tempo nello studiolo di Federico da Montefeltro, voluto dal duca nel suo palazzo d’Urbino. Lo scrittore allude quindi, in maniera del tutto imprevista, ai nuclei forti della poetica proustiana, concedendosi brani di lirica intensità: e se la sua proposta avrebbe avuto eco nelle ricerche di molti colleghi, fra Italia e Spagna (imponendo al dibattito uno dei più intriganti interrogativi per la pittura europea del Quattrocento), è proprio questa lezione segreta – complice la consegna del saggio a un cassetto della propria scrivania di poligrafo indefesso – a essersi persa nella pieghe di un confronto, dal quale Longhi stesso avrebbe escluso le punte maggiormente polemiche.
Così il contributo sul castigliano individua l’importanza della Recherche, nel descrivere il modo in cui l’occhio del conoscitore intreccia relazioni fra un’opera e l’altra, scorgendo in esse la medesima paternità ma, soprattutto, collocandone le evidenze figurative in un quadro ampio di rapporti e assonanze. Di fronte ai retablos incontrati al Prado – quasi una pietra d’inciampo, per la cultura visiva longhiana – l’autore illustra l’articolato processo d’impaginazione di un album mentale, che, d’un tratto, lo aveva portato a sovrapporre Madrid a Urbino, a far coincidere le aule scure di una fortezza conventuale col raccoglimento squisito della cella umanistica; a condensare insomma – nella linea continua d’un percorso rettificato – le rotte divaganti di un pittore girovago:
“la mia memoria visuale stranamente lavorava sulle forme rapportando non solo certi particolari apparenti […], ma ricreandosi per via di connessioni mnemoniche, a definir le quali occorrerebbe stemperare per pagine molte una topografia di vicoli mnemonici, come quella che potrebbe ricostituirci un Proust, ricreandosi dico un ambiente dove gli angoli dell’architettura, il lustro o il rugginoso dei fondi, una certa umiltà casigliana richiamavano per molti sensi l’innominato pittore della Corte urbinate. S’intende ch’io non sarei stato così sciocco per avanzare da quelle sole affinità, presentite ma troppo sprofondate nei sotterranei della memoria per poterle trarre alla luce con perizia sufficientemente dimostrativa, la certezza di avere scoperto il pittore dello Studio d’Urbino. È bensì vero che le identità formali e le più autentiche scoperte di veri nella storia dell’arte, ci appajono – sotto la forma apparente di dissimiglianze – quando la nostra mente sia ormai abituata a vivere nei panni dell’artista, così bene e perfettamente come il servitore unicamente riservato all’ufficio di incignare i vestiti del padrone, è poi in grado di riconoscerli in qualunque stato ridotti, fosse anche in carta da involgere; ma purtroppo il metodo appariscente e banalissimo del Morelli ancora generalmente prevale e ci ha per troppo tempo trattenuti dall’approfondire questo metodo che è tuttavia l’unico che ogni vero critico usi, anche senza dichiararne coscienza.”
Già attorno al 1925 e con una durezza estranea a più tarde riflessioni Longhi cercava dunque di affrancare l’expertise del conoscitore da soluzioni enigmistiche, attratte da un certo positivismo scientista e connesse indissolubilmente, per via generativa, alle opinioni ottocentesche di Giovanni Morelli (il primo a trasformare “in metodo” il riconoscimento di una “mano” al lavoro sull’opera, attraverso fitte comparazioni fra dettagli minimi e ricorrenti, di figura in figura, di scorcio in scorcio); approfondiva, al contrario, il lavoro di confronto, necessario all’indagine storico-artistica, con uno scavo nei giacimenti memoriali di ciascun osservatore, seguendo echi ampi, equiparando sistemi culturali.
Nel far questo emancipava pure Proust dalle letture squisitamente letterarie – e in buona parte ‘contenutistiche’ – che ne avevano caratterizzato la prima ricezione italiana, da Lucio D’Ambra a Emilio Cecchi, mentre la Recherche era in corso di stampa (Le temps retrouvé sarebbe uscito per la Nouvelle Revue Française solo nel 1927). È chiaro infatti che, nel commentare il nucleo forte di quell’epopea ancora incompiuta, il contributo su Berruguete si dimostrava informato della stretta connessione che il pensierodel francese intratteneva con le idee del filosofo Henri Bergson, preferendo i “vicoli mnemonici” ai percorsi non meno tortuosi – ma tanto più brillanti – tracciati nelle pagine sui salotti Guermantes o Verdurin: spostava così l’attenzione dal “quadro” sociale all’ispirazione prima dello scrittore, a quel sentimento del tempo contratto, non lineare, fuso in gangli indissolubili di ricordi e presente che proprio Bergson, nato nel 1859, stava consegnando al Novecento, complici assieme le teorie esordienti della scienza psicologica e una certa brumosa impressionabilità fin-de-siècle.
Un simile aggiornamento veniva a Longhi dall’esperienza de «La Voce», settimanale che gli era servito da palestra negli anni di gioventù e sulle cui pagine il critico Giuseppe Prezzolini aveva offerto una precoce “vulgata” del pensiero del filosofo, autore per l’appunto di saggi importanti, da Essais sur les données immédiates de la conscience a Matière et mémoire.
Tuttavia, nel parlare di Proust, è chiaro come a queste date Longhi preferisse sottolineare le accensioni illogiche di un discorso – per così dire – poetico rispetto alle congiunzioni prosastiche del romanzo; e, nell’assunzione dello scrittore a modello ermeneutico ne prediligesse la capacità di descrivere, senza censure ragionevoli, “les intermittences du coeur”, con le loro dislocazioni improvvise e le longeve permanenze d’affetti, piuttosto che la riconosciuta maestria nel domare a parole le leggi spietate di una selvaggia giungla sociale.
In tale prospettiva, la laica medianità della Recherche poteva allora – e innanzitutto – servire a trascendere i limiti rigidi di luogo e tempo, che, in storia dell’arte, si traducevano nei dogmi di una concezione “stirpica” o “razzistica” (per usare aggettivi esplicitamente avversati da Longhi, proprio nel saggio su Berruguete), chiusa in griglie concettose di etichette e definizioni. La vicenda di uno stile individuale, studiato e ben compreso, riusciva al contrario a risolversi in chiave trascendente, piuttosto che in affermazione identitaria, se prosciolta da dettami aprioristici e riconsegnata all’amore fedele di un occhio dotto. Non a caso, l’esempio del pittore castigliano, trasferitosi oltremare per ragioni insondabili, serviva all’uopo, vero e proprio manifesto di metodo, tanto quanto la cosmopolita corte di Urbino, retta dal colto Montefeltro ma aperta a contributi disparati, presentava l’humus consono per condurre un simile esperimento: ed è non meno significativo che, negli anni seguenti alla carneficina della Prima Guerra Mondiale, il testo proponesse una soluzione – in chiave tutta formale – alla polare dicotomia dell’asse Nord-Sud, diviso fra astrazione intellettualizzata all’italiana e minuzioso scandaglio settentrionale, con l’aggiungere alla casistica quattrocentesca i nomi eccentrici di maestri spagnoli o francesi per aprire inediti scenari di civiltà rinascimentale (e non solo).
Ancora di più, il rimando a Proust e alla sua fluida meccanica memoriale, serviva a infondere linfa nuova nella scrittura accademica e specialistica, attingendo alle risorse dell’esperienza vissuta, non solo in termini d’indagine scopica e di allenamento dello sguardo, quanto piuttosto per approntare repertori utili a ricostruire, in parole e sulla pagina, un rapporto originale (ma comunicabile) con le immagini concrete della storia dell’arte. Un modo per liberarsi, da un lato, dell’impervia speculazione per categorie della scuola viennese e tedesca (da Alois Riegl a Heinrich Wolfflin), dall’altra per far piazza pulita degli sdilinquimenti decadenti di un D’Annunzio e – in fondo – anche di un giovane Bernard Berenson.
Come, cioè, se Longhi, nel valutare le risultanze della Recherche, cercasse in fondo figure diverse che, libere dai dettami della retorica, superassero le equivalenze fruste della metafora o dell’analogia. Per una stessa ragione, ci sembra, Contini avrebbe suggerito che il suo metodo compartisse l’intenzionalità programmatica di uno degli strumenti della lirica moderna, e cioè il correlativo oggettivo, teorizzato nel ’19 da un testo celebre di T. S. Eliot (il saggio Hamlet and his Problems) e prontamente accolto fra le voci sensibili della poesia italiana, da Montale a seguire. Per Eliot, infatti,
“the only way of expressing emotion in the form of art is by finding an objective correlative; in other words, a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion; such that when the external facts, which must terminate in sensory experience, are given, the emotion is immediately evoked.”
In tal senso la prosa di Longhi trascende la pratica classica dell’ekphrasis, ovvero della descrizione per parole di un’opera, facendo semmai dell’incontro con essa un esercizio palpitante; ed è, con la stessa finalità, che la sua pagina trasforma l’enfasi lisa dell’estasi estetica in un “fatto” sensibile, unico ‘veicolo’, nel labirinto lucido del discorso, per la presenza espressiva di un quadro o di una scultura. Fra le sue parole, si accumulano lemmi specialistici, aggettivi d’invenzione, effigi consistenti, reminiscenze icastiche, reperti di cultura alta e bassa, attinti similmente da bagagli condivisi: un armamentario che sostanzia la frase, offrendosi da porta d’accesso tanto all’intendimento quanto all’emozione del lettore, affrancato dalla promessa di un gergo da iniziati. Per tornare, in via esemplare, al saggio su Berruguete; così lo storico vi racconta le tavole del castigliano, abili ad armonizzare la prospettiva all’italiana e il naturalismo settentrionale, ricorrendo a un’immagine icastica, per spiegare concretamente l’ardua similitudine: “Come in un cristallo di jalite si veggono nitidamente incluse festuche o insetti, o altre quisquilie naturalistiche ma la durezza della rocca che le circonda non ci permette di toccarle e diremo per assurdo una forma nuova e inavvicinabile della loro squisita percettibilità, così ci appaiono misteriosamente informate nelle opere [di Berruguet] le finezze e le intimità del Nord e in modo così perfetto da farci credere che questo solo fosse il modo di risolvere le smanie e miscuità naturalistiche dell’età gotica”.
È sotto una luce siffatta che il bifronte “realismo” proustiano, sospeso fra effusione ed analisi, assume coerenza, nel longevo mestiere dello storico dell’arte, congiungendo le citazioni del ’25 e del ’50, solo all’apparenza contraddittorie; e d’altronde, proprio nel saggio su «Paragone» il rimando alla Recherche è fatto precedere da uno dei più intensi programmi vergati dall’autore circa le finalità della propria professione.
Longhi, infatti, quasi in chiusa di quel contributo, chiarisce il senso del suo impegno, evidenziandone la valenza metodologica, quasi a rivendicare per la sua storia dell’arte una funzione vitale, prima ancora che critica:
“È dunque il senso dell’apertura di rapporto che dà necessità alla risposta critica. Risposta che non involge soltanto il nesso tra opera e opere, ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione e quant’altro occorra. Qui è il fondo sodo di un nuovo antiromanticismo illuminato, semantico, tenebrante, analitico, empirico o quel che volete, purché non voglia svagare. L’opera d’arte è una liberazione, ma perché è una lacerazione di tessuti propri ed alieni. Strappandosi, non sale in cielo, resta nel mondo. Tutto, perciò si può cercare in essa purché sia l’opera ad avvertirci che bisogna ancora trovarlo, perché ancora qualcosa manca al suo pieno intendimento”.