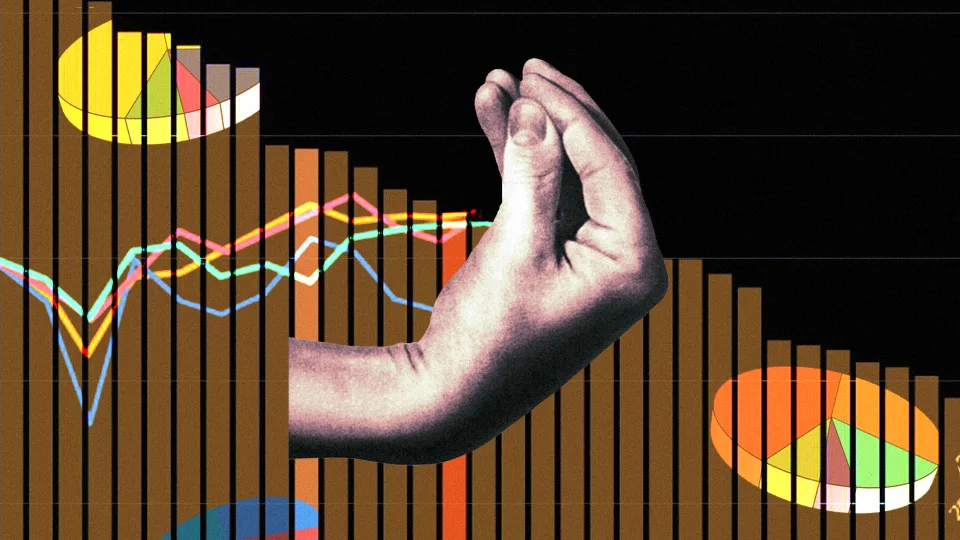ChatGPT può provocare in alcuni – come all’autore del pezzo – una peculiare forma di malinconia, che nasce dalla sensazione di avere ormai cervelli obsoleti, e di essere destinati a diventare più stupidi, meno svelti delle macchine. In una parola, di essere neuro-inferiori.
È passato un anno da quando ho iniziato a servirmi di ChatGPT. Grazie alla macchina in questo arco di tempo ho fatto un sacco di belle scoperte. Per esempio che esistono analogie tra le vecchie coreografie di Heather Parisi e i balletti virali su TikTok. Mi è bastato abbozzare un’ipotesi e la macchina mi ha subito sfornato un elenco di corrispondenze. Le coreografie di Heather Parisi sono semplici e replicabili, proprio come i balletti di TikTok, ha detto l’AI. In entrambi i casi, inoltre, sono importanti l’uso del viso, delle braccia, del busto e l’inquadratura frontale. In un’altra occasione l’AI mi ha aiutato a ricostruire un ricordo. Riguardava un vecchio spot. Tutto ciò che era rimasto nella mia memoria era molto sfocato e aveva a che fare con una scena dove si vedevano le finestre di una casa che venivano spalancate di colpo. Nient’altro. Risposta dell’AI: potrebbe essere lo spot di un profumo del 1990. Un profumo Chanel. Me lo ha comunicato con una prudenza e una cortesia che spesso mancano negli esseri umani. “Sì”, le ho scritto. Era quello lo spot.
Eppure, nonostante queste piacevoli epifanie, a lungo andare la compagnia dell’AI mi ha provocato una curiosa forma di malinconia e di tristezza. Ne parlo e ne scrivo, anche per fare un test e capire se esiste qualche lettore o lettrice a cui è capitato di provare qualcosa del genere. È una malinconia e una tristezza che non avevo mai sperimentato, così pervadente che un giorno è riuscita a farmi tornare in mente una persona conosciuta nel secolo scorso.
Avevo più o meno quindici anni quando incontrai per la prima volta un certo Michele. Michele, nome di fantasia, era poco più grande di me e frequentava la mia stessa scuola. Aveva carisma ed era temuto per la sua precoce intelligenza. Alto, fisico asciutto, testa in asse, come tirata da un filo verso l’alto, torace aperto, occhi scuri e pungenti, ma soprattutto, ecco la qualità che soggiogava tutti, dotato di una parlantina micidiale. Era un killer nell’arte del botta e risposta. Una specie di giovane Vittorio Sgarbi che al contrario dei suoi coetanei aveva già vinto la battaglia contro il Werther annidato nel petto di ogni adolescente. Aveva la risposta pronta e un’esposizione chiara e geometrica.
Michele padroneggiava l’ars dicendi, l’arte del dire. Era un retore con i fiocchi, capace di elocutio e dispositio. Vale a dire che quando apriva bocca sapeva condire il discorso con paroloni, stile, immaginazione, portando sempre esempi a supporto della sua tesi; usava con naturalezza iperboli e paradossi. Sembrava avere letto più libri di tutti noi messi insieme. Noi dovevamo ancora capire come ingranare le marce, lui invece era già al volante di una Ferrari. Era un atleta della parola e un intellettuale in erba, anche se forse somigliava più ai nuovi sofisti da talk show che spopolavano sulle reti Rai e sulle reti Fininvest. L’intelligenza svelta di Michele mi faceva sentire inadeguato.
Nella sua classe c’era un altro tizio che incuteva timore, ma per un’altra ragione: diceva di essere nazista, a ricreazione faceva il saluto romano, aveva una risata e un paio di occhi sporgenti da pazzo e ho ancora nelle orecchie il suo “Heil Hitler” gridato nei corridoi. Una volta aveva invitato un compagno di classe a studiare a casa sua e lo aveva rinchiuso per un’ora dentro una stanza blindata, che il padre imprenditore aveva fatto costruire in un sotterraneo. Ma questa è un’altra storia. Michele, a differenza del nazista, non era pazzo. O forse sì, un po’ pazzo e sadico lo era anche lui.
Il ricordo di Michele, che poi da grande è diventato un ottimo scrittore, è sbucato fuori da chissà quale cratere della mente, mentre scrivevo e riflettevo su una sensazione che non provavo, per l’appunto, dai tempi del liceo. In realtà, a pensarci bene, ciò che provo oggi, a partire dal mio apprendistato con l’Intelligenza Artificiale, è un grumo di percezioni inedite, da prendere e mettere sotto il vetro del microscopio. È una tristezza inedita, un presagio di fallimento, di smacco; deriva dall’emergente sensazione di essere ogni giorno più inadeguato, imperfetto, difettato, fuori corso, direi sempre più carente per il modo stesso in cui la natura mi ha progettato, soprattutto per ciò che concerne la mente, il connettoma, il complesso dei processi cognitivi e tutto lo sterminato apparato reticolare formato da quasi novanta miliardi di neuroni, da dendriti, sinapsi e neurotrasmettitori, che grazie a un sistema regolato da segnali chimico-elettrici rendono possibile in me il linguaggio e la coscienza.
Questa consapevolezza ha iniziato a prendere forma mentre usavo ChatGPT. Mano a mano che le facevo domande e le risposte apparivano sullo schermo, cominciavo a confrontarmi con una forma pioniera di malinconia. Provo a darle un nome: complesso di neuro-inferiorità. Nei confronti di Michele potevo provare – ma eravamo ancora nel secolo scorso – timore e soggezione intellettuale, ma non un complesso di neuro-inferiorità, cioè non pensavo di soffrire di uno svantaggio neurale, costitutivo e strutturale.
Lorenzo Perilli, filologo e storico del pensiero scientifico antico, nel libro Coscienza artificiale parla di περίττωμα (períttoma), concetto che Aristotele usa per indicare un “residuo privo di funzione e significato, quasi una sorta di errore della natura”. Diventare uno scarto, un περίττωμα, è un possibile destino dell’essere umano, spazzato via come un alberello dall’alluvione tecnologica? Sempre nel libro di Perilli il lettore incontra una vignetta dove due robot sono a spasso in un museo. Davanti a un grosso cervello umano conservato in una teca, uno dei due dice all’altro: “Ecco il processore originale”.
Oggi, quando devo affrontare una conversazione ed esporre le mie idee, da qualche parte dentro di me si leva una vocina che non avevo mai udito, una vocina ferma e pacata. La vocina mi ricorda che ChatGPT sa organizzare meglio di me il discorso che sto per fare. ChatGPT, dice la vocina, è più veloce, più accurata, più affidabile. È di gran lunga più capace di elucutio e dispositio. Io sbaglierò date e nomi, ChatGPT no. O quasi. A breve non sbaglierà più. Se dovrò ricordare la data di un evento storico, è probabile che la mia memoria sarà imprecisa. Mi servirà un certo intervallo di tempo per ricordare il titolo di un libro o il nome di un attore. Dovrò spremere i neuroni e non è detto che riuscirò nello scopo. Avrò delle esitazioni, farò delle pause. ChatGPT, no. Perderò il filo del discorso, farò molti “ehm” e “mmm”. Anche perché, a dirla tutta, il mio encefalo sta invecchiando a una velocità preoccupante. È come il cervello dei due alcolisti veneti del film Le città di pianura, quando iniziano un discorso e poi non si ricordano più da dove erano partiti. E forse non è solo il mio cervello che sta invecchiando a una velocità sospetta. Quanti sono, tra gli amici che frequento, quelli che convivono con i toni grigi di una frequente foschia mentale? Parecchi. Quante sono, tra le conversazioni che mi capita di avere abitualmente, quelle inframmezzate da incisi come “Ora non mi viene mente”, “Non mi ricordo” e “Come si chiama Tizio e come si chiama Caio”? Tante.
Una volta, seduti a pranzo in un bar, un amico mi ha dato un consiglio che sembrava rubato al filosofo umanista Marsilio Ficino: quando hai un vuoto di memoria, mi disse, prova a fare un giro completo intorno a un palazzo e mentre cammini, prova a ricordare, a recuperare l’informazione che stai cercando. Ha funzionato. ChatGPT, però, risolve lo stesso compito in un lampo, in pochi secondi, dentro i quali si celano minuscole operazioni svolte nell’arco di picosecondi. Il cervello umano non può competere. A molti di noi sarà capitato di pensare, di questi tempi, che più le macchine diventano intelligenti, più l’uomo diventa stupido.
“Mano a mano che le facevo domande e le risposte apparivano sullo schermo, cominciavo a confrontarmi con una forma pioniera di malinconia. Provo a darle un nome: complesso di neuro-inferiorità”.
All’angoscia di perdere il lavoro, si somma la paura di non avere più un posto sicuro nel mondo e nella storia. È il timore di non essere più importanti. Di non contare più nulla. Di tramutarci in schiavi fruitori di contenuti-poltiglia generati dalle macchine. Questa è la paura che mi prende quando a Milano entro in uno dei tanti negozietti d’informatica in Chinatown e, nella penombra dei retrobottega, intravedo certi ragazzini seduti su delle seggioline, inghiottiti dallo schermo di un tablet. La stessa cosa mi capita nelle piazze e nei bar di provincia: dove un tempo vedevo gruppi di rosei vecchietti giocare a carte, ora vedo tanti pensionati impoveriti, seduti per conto loro in silenzio, a scrollare sui rispettivi telefoni. Più i luoghi sono poveri e abbandonati, più la tecnologia si avventa vampiresca sulla solitudine e la fragilità.
Vorrei aggiungere un aneddoto personale e raccontare il momento in cui il mio complesso di neuro-inferiorità si è acuito. È successo un giorno in cui YouTube mi ha proposto un video-saggio di circa un’ora, scritto evidentemente con un sistema d’Intelligenza Artificiale. Riguardava un tema molto particolare: il mistero della longevità dei mobili medievali. Perché i mobili fabbricati nel medioevo erano eccezionalmente solidi e duraturi? Per rispondere, la voce narrante artificiale aveva spaziato, con disinvoltura e impressionante precisione terminologica, fra campi diversi del sapere: storia della falegnameria e dell’ebanisteria, dendrologia, cronodendrologia, scienza dei materiali, storia del Medioevo, sociologia storica e antropologia del Medioevo.
Ero ipnotizzato come una gallina, ma pure affascinato. Le virtù della quercia baltica e le foreste primarie, la densità del durame, la quantità di umidità nel legname verde appena tagliato, il drenaggio della linfa, le tensioni interne al legno, le spaccature, l’essicazione in forno, la stagionatura a fumo, l’effetto dei tannini sulle finiture applicate, i metodi di segatura, il taglio di quarto e il taglio tangenziale, il piano radiale, la carpenteria di base, le giunzioni di precisione, i cunei interbloccanti, la costruzione a telaio e pannello praticata secoli fa nella regione della Borgogna, l’umidità e il microclima all’interno delle cattedrali, la secchezza invernale del legno e l’umidità estiva, etc. etc.
Un tesoro di conoscenze così variegate ed esatte, su un argomento tanto specifico, è il frutto di una vita intera di studi. È il tipo di sapere che per originalità e vastità appartiene agli eruditi. Eppure è stata una macchina, anche se istruita da un prompt scritto da un umano, ad aver assemblato un testo ricco e accurato, certo, ma fin troppo limpido, terso, lustro, come se fosse stato forgiato in un regno di fiaba dove vige un eterno mezzogiorno. Un’analisi di lucentezza inquietante. Per il matematico Paolo Zellini si tratta di “una veridicità di stampo divino”.
Il tecno-ottimista (o addirittura “tecno-entusiasta”) spesso pecca di superbia. Le sue tesi, a dire il vero, oggi sono penalizzate dal successo di figure sinistre come Elon Musk e Peter Thiel, cosa che costringe il tecno-ottimista in buona fede e democratico a prendere le distanze e ad aggiungere glosse e chiarimenti al proprio discorso. Tra gli argomenti usati dai tecno-ottimisti, però, ce n’è almeno uno che non funziona: se, come sostiene il tecno-ottimista, molte rivoluzioni tecnologiche sono state accompagnate da allarmi apocalittici che si sono poi rivelati infondati, anche grazie alle capacità di adattamento dell’essere umano, questo non vuol dire che ogni rivoluzione tecnologica sia di per sé “buona” o propizia.
Questo genere di argomento è stato un puntello importante dell’ideologia che ha sostenuto l’accelerazione tecnologica degli ultimi trent’anni. Per fortuna parti sempre più ampie di opinione pubblica cominciano a notare la fallacia del ragionamento. Un esempio: la casa editrice Einaudi ha da poco pubblicato Sangue nelle macchine. Le origini della ribellione contro la tecnologia di Brian Merchant. Racconta la vicenda del luddismo in una chiave inedita: non una banda di reazionari ottusamente avversa a ogni forma di progresso, ma un movimento di artigiani e operai che in Inghilterra, al principio della rivoluzione industriale, si oppose alla violenza delle macchine e del capitale diretta contro l’essere umano (e contro l’infanzia in particolare). Per la rivista «Wired» si tratta del libro più importante in circolazione per comprendere gli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Il neo-luddista e il tecno-pessimista dal canto loro si trovano nella posizione scomoda, poco seducente e apparentemente non costruttiva di chi aziona il freno e dice “no”, col rischio di passare per il nostalgico che intralcia il treno del progresso.
La retorica antica è un testo di Roland Barthes che ho ripescato dalla libreria mentre scrivevo questo articolo. Volevo andarmi a rivedere che cosa sono l’elocutio, la dispositio, l’inventio, la disputatio e la declamatio, in modo da descrivere meglio l’ars dicendi di Michele, la mia vecchia conoscenza dei tempi del liceo, e la prodigiosa abilità di scrittura dell’Intelligenza Artificiale. Un paragrafo in particolare del libro di Barthes mi ha emozionato per la sua attualità senza tempo. Barthes si sofferma su Marco Fabio Quintiliano, maestro di retorica vissuto nel I secolo Dopo Cristo. Quintiliano, scrive Barthes, vuole dare un consiglio a chi scrive, in modo da metterlo sulla buona strada e conseguire una “firma facilitas”, cioè una “salda facilità”, ovvero sicurezza e disinvoltura nello scrivere. Poi Quintiliano nota un problema: il pensiero è veloce, ma la mano è lenta. Lo sanno bene gli scrittori surrealisti, aggiunge Barthes, i quali vorrebbero portare sulla pagina tutte le immagini che gli appaiono nella mente. Ma per Quintiliano e Barthes “[…] la lentezza della mano è benefica”. La scrittura, insomma, per essere, non può separarsi dalla mano dello scrittore, non può rinunciare ad avere un corpo.