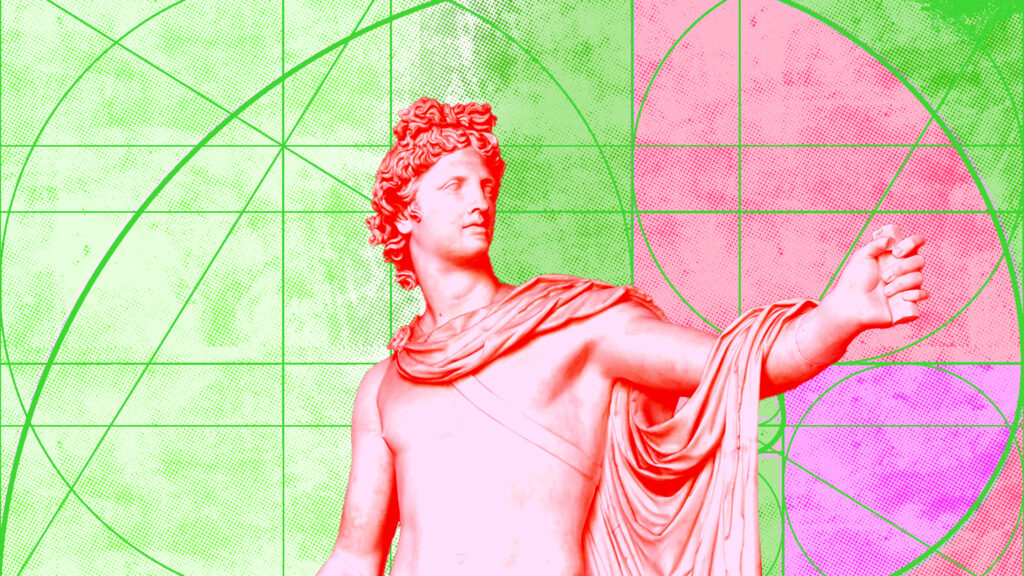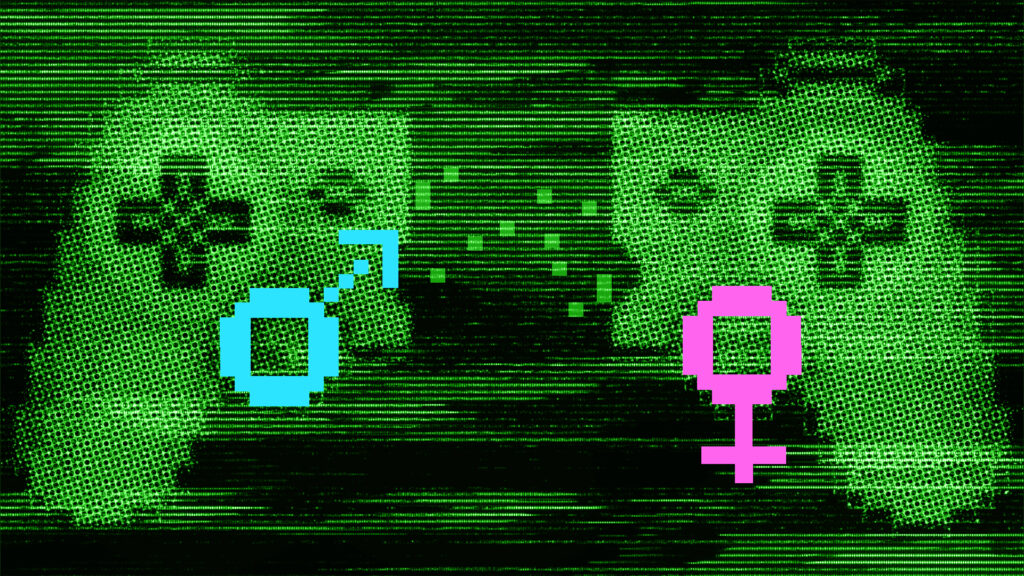Irene Soave
Al lavoro siamo tutti donne

21 Marzo 2024
Escluse, vilipese, emarginate, a rischio, le donne che lavorano simboleggiano una condizione che oggi sembra riguardare tutti.
Irene Soave
Irene Soave e giornalista al «Corriere della Sera», dove si occupa di esteri, attualità e cultura. Il suo ultimo libro è Lo statuto delle lavoratrici (Bompiani, 2024).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati