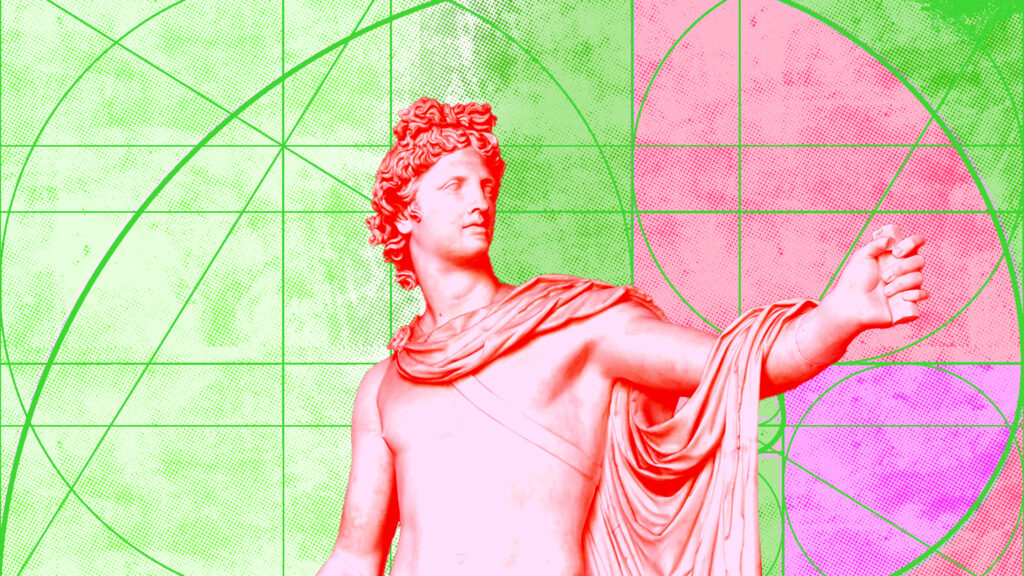Matteo Lupetti
La fine di internet è cominciata col Gamergate
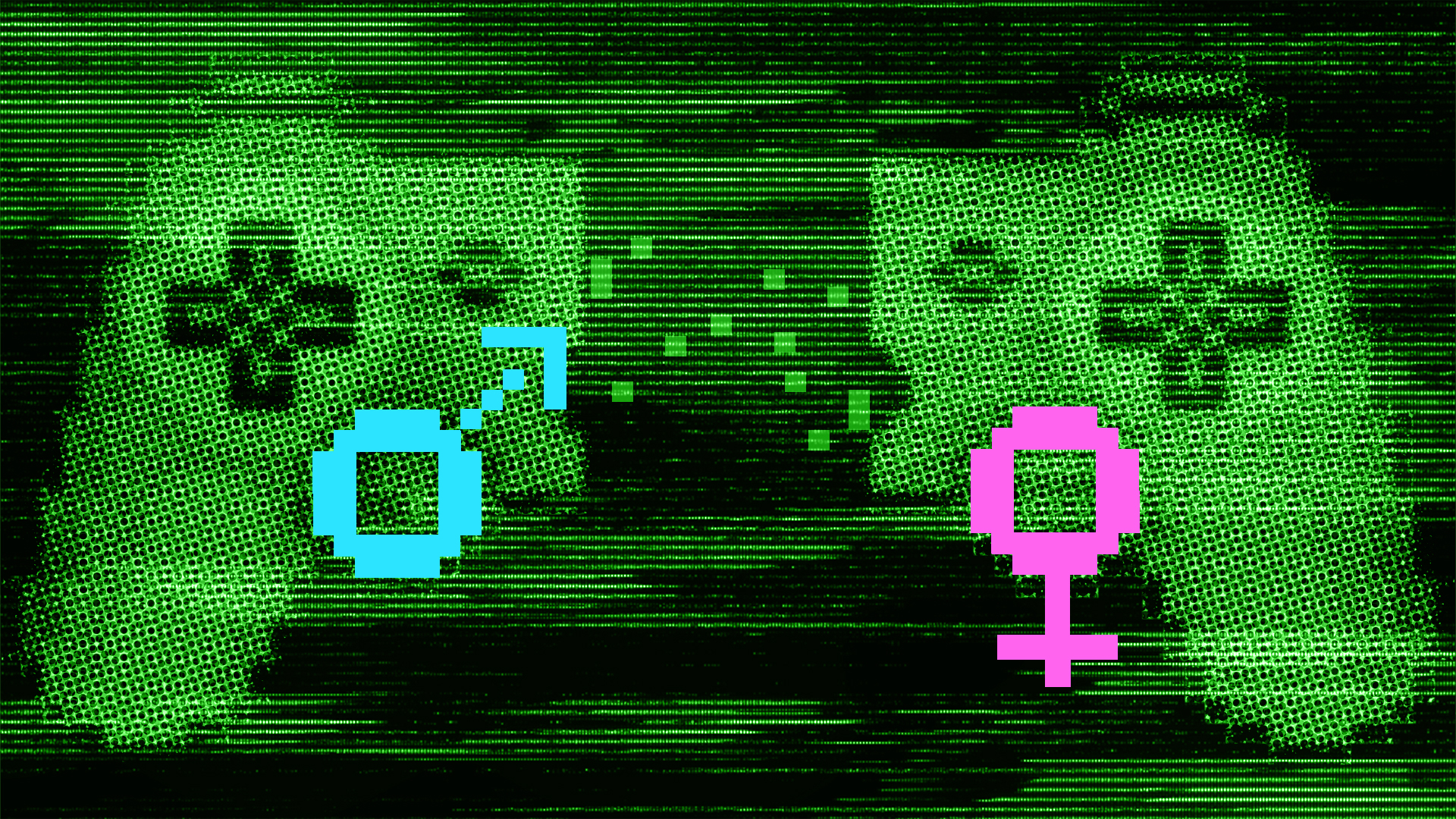
15 Marzo 2024
Online, siamo ormai abituati al peggio, tra insulti, violenze, hater.
Dieci anni fa però non era così, almeno fino allo scoppio del Gamergate, eclatante caso di molestie nei confronti di alcune sviluppatrici di videogiochi. Non è un caso, forse, che tutto sia nato dalla rabbia di un uomo lasciato.
Matteo Lupetti
Matteo Lupetti è fumettista e critico. Collabora con diverse testate scrivendo soprattutto di fumetti e videogiochi.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati