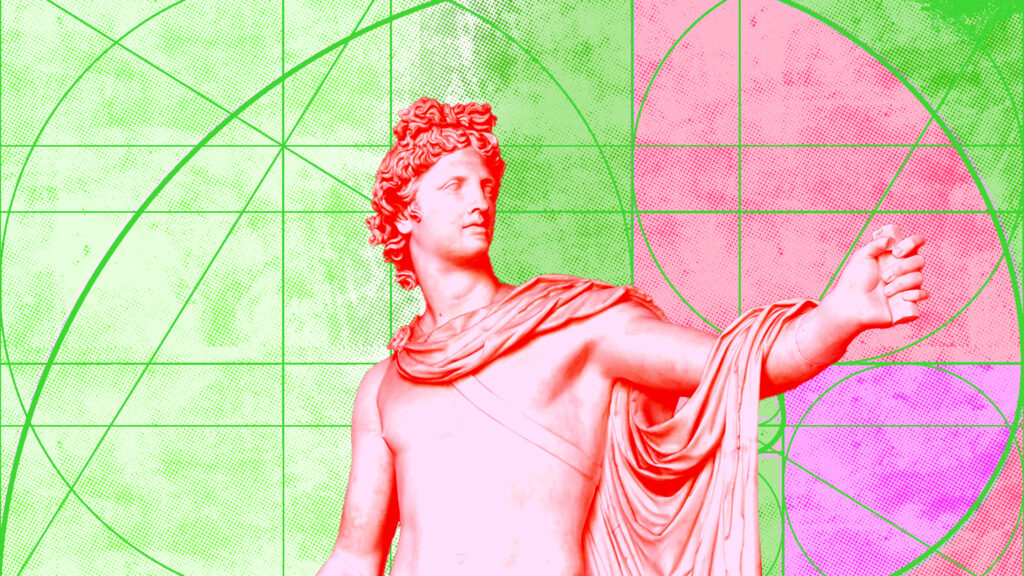Alessandra Carati
Chi è davvero Rosa Bazzi?

14 Marzo 2024
Tutti abbiamo cristallizzate nella mente alcune immagini di Rosa Bazzi, condannata assieme al marito Olindo per la strage di Erba. Ma chi è davvero Rosa Bazzi? Tra fantasie sconnesse, vulnerabilità feroce e conversazioni fuori dallo spazio e dal tempo, chi l'ha incontrata in carcere è rimasto impigliato nella sua psiche inafferrabile, senza che il desiderio di comprenderla fosse scalfito dalla sua frammentazione: un profilo di Rosa Bazzi delineato da chi ha cercato di conoscerla.
Alessandra Carati
Alessandra Carati è scrittrice, editor, sceneggiatrice. Il suo ultimo libro è Rosy (Mondadori, 2024).
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati