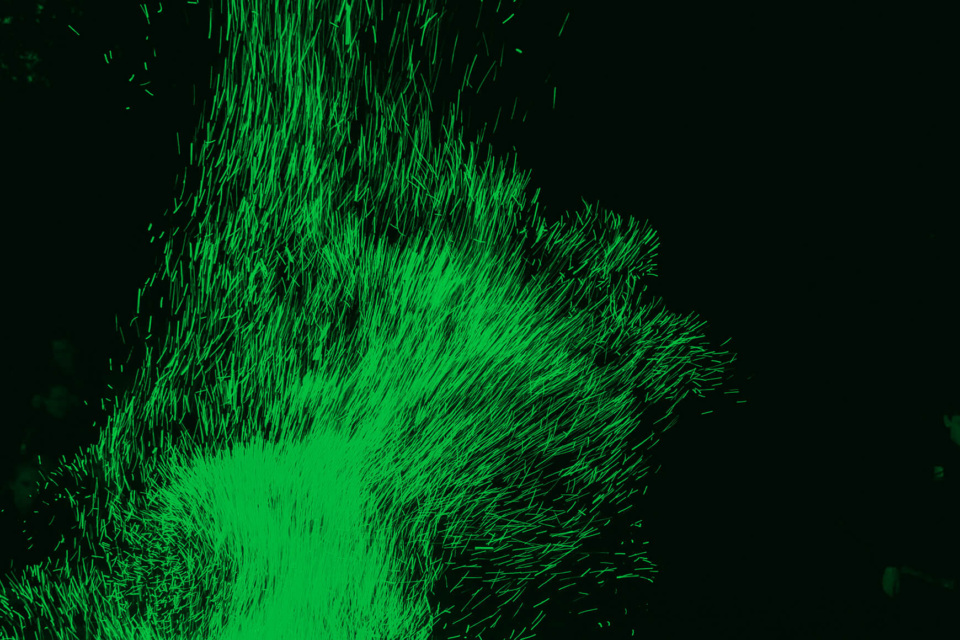Ai tempi di Stalin, Tskhaltubo era una località termale molto frequentata e prestigiosa. Dopo la guerra georgiano-abcasa è diventata rifugio per molti profughi. Oggi che i suoi sanatori sono abbandonati e fatiscenti, la città prova a ripartire pensando prima di tutto a lavoro, economia e al benessere dei suoi abitanti.
Il successo improvviso di un luogo è spesso anche il risultato di qualcosa di vago e inspiegabile che, per comodità, potremmo chiamare “caso”. A Tskhaltubo il caso coincide con un semplice dato geografico: la piccola città della Georgia occidentale è costruita su una sorgente termale sulfurea (ricca di minerali, in particolare di radon-carbonato) che ha una temperatura naturale tra i 33 e i 35 °C; l’acqua di Tskhaltubo reca benefici al sistema cardiovascolare ed endocrino, aiuta a lenire l’artrite e i reumatismi. È un elemento importante per la zona, al punto che si riflette nel suo nome, che deriva dalla radice tskhali, la parola georgiana per acqua. Se il caso ha voluto che la sorgente termale sorgesse proprio lì e non altrove, è la determinazione della classe dirigente georgiana durante l’Unione Sovietica, e in particolare durante lo stalinismo, ad averne decretato il successo, rendendo Tskhaltubo uno dei principali centri di balneoterapia di tutta l’URSS. Tanto che al suo apice, negli anni Settanta, decine di migliaia di cittadini si recavano ogni anno nella città termale da tutta l’Unione Sovietica per spendere le sessioni di riposo e recupero dal lavoro volute dallo Stato. Tskhaltubo arriva ad avere un ruolo fondamentale e perfino salvifico nella vita dei cittadini sovietici durante i duri anni della guerra e del dopoguerra: “A salvarmi sono stati i fanghi curativi di Tskhaltubo. Mi ha salvata il desiderio di vivere. Vivere, vivere, tutto qui,” si legge nella testimonianza di una combattente clandestina raccolta da Svetlana Aleksievič in La Guerra Non Ha Un Volto di Donna (1985).
Le terapie erano obbligatorie, gratuite e prescritte una volta all’anno per una settimana tramite i putëvki, buoni emessi dallo Stato, a tutti i cittadini dell’URSS, dai contadini ai generali dell’esercito. La rigidità delle divisioni sociali restava però ferrea e si rifletteva nell’organizzazione dei sanatori, molti dei quali sono ancora visitabili oggi. Nel periodo di massimo splendore c’erano 22 immense strutture, tutte di cemento e in perfetto stile Classicismo socialista. Ciascuna di queste strutture era dedicata a una classe sociale o ceto: quella per i militari, per gli operai del settore metallurgico, per i geologi, per le madri con bimbi piccoli e così via, fino alla Dacia privata di Stalin. Oltre a essere un luogo pensato per il riposo, in cui la permanenza era scandita in maniera precisa e meticolosa, Tskhaltubo era anche un ritrovo fondamentale per socializzare, per incontrare persone con cui si condividevano stile di vita, lavoro, abitudini, ma che provenivano da ogni angolo dell’immenso territorio dell’Unione Sovietica.
Oggi dell’abbondanza di un tempo – di mezzi, di vita, scambi e persone – rimane solo l’assenza, l’eco di ciò che deve essere stato, insieme ai mosaici scrostati e agli enormi lampadari pericolanti, ancora appesi nei saloni dei sanatori abbandonati. Camminando per le stanze vuote, calpestando quello che resta dei ricchi pavimenti di legno, o guardando attraverso i buchi delle finestre senza più vetri, verrebbe da dire che Tskhaltubo è una città ferma nel tempo. In realtà non è proprio così. Sarebbe più corretto dire che Tskhaltubo, nel corso della sua storia recente, sia rimasta bloccata più volte, in momenti diversi del Novecento. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e la successiva indipendenza della Georgia – già nel 1991 – i sanatori vennero abbandonati una prima volta, forse proprio per prendere le distanze dall’eredità sovietica con cui il paese fatica ancora oggi a fare pace, o forse più semplicemente perché era venuta a mancare l’infrastruttura logistica necessaria a tenerli in funzione.

I sanatori però non sono rimasti abbandonati a lungo. Nel 1992 scoppia la guerra in Abkhazia, regione separatista a nord del paese che si estende tra la Russia e il Mar Nero. La prima fase della guerra dura fino al 1993, anche se la Georgia lo considera ancora un conflitto congelato e non riconosce – così come la maggioranza della comunità internazionale – i confini abkhazi. Il conflitto in Abkhazia ha prodotto più di 250.000 sfollati di etnia georgiana. decine di migliaiahanno trovato rifugio proprio a Tskhaltubo, non lontana dal confine e con strutture abbandonate grandi abbastanza per ospitare gli sfollati. Quella della perdita dell’integrità territoriale è una ferita ancora aperta per molti georgiani e il dibattito su Abkhazia e Ossezia del Sud – altra regione separatista – è sempre al centro del discorso pubblico. Tskhaltuboè diventata un simbolo della guerra, così come gli sfollati che la abitano.
Guram Odisharia è un intellettuale, scrittore e poeta tradotto in tutto il mondo. È georgiano e ha vissuto da vicino la guerra in Abkhazia. Da quell’esperienza sono nati molti dei suoi scritti, come Il Passo dei perseguitati o Tornare a Sokhumi. Nel 2023 è stato pubblicato per la prima volta in Italiano il suo Il Gatto del presidente, in un unico volume insieme a La sponda della notte dell’autore abkhazo Daur Nachkebia. È quasi il tramonto quando ci sediamo sotto una pergola nel suo giardino, in un piccolo villaggio a nord di Tbilisi. Mentre la moglie ci porta un delizioso succo fatto con i frutti e fiori del giardino, Guram mi racconta la loro storia. Il giardino, i roseti, le piante curatissime hanno un che di idillico, ma questa che ora è casa loro non lo è sempre stata , e la vita un tempo non era così serena: “Mio padre era un militare, si occupava di formazione, per questo lo trasferivano di continuo da un posto all’altro. Prima che io nascessi, l’hanno mandato a Sokhumi, in Abkhazia” – quando ancora faceva parte della Georgia. Così il giovane Odisharia cresce in Unione Sovietica, tra il mare e gli aranceti di Sukhumi: “Sukhumi era un porto, una città di mare, aperta, bellissima. Ricordo ancora quando arrivavano le navi dall’Occidente, il contrabbando dei Jeans e dei primi dischi rock in vinile, anche se ufficialmente era proibito avere a che fare con gli occidentali che arrivavano sulle navi. Sukhumi era una porta sul resto del mondo”.

Poi scoppia la guerra. A quel punto, nel 1992, Odisharia è già un uomo sposato, ha compiuto quarant’anni. Quando ne parla il sorriso con cui mi ha accolta si spegne, il tono si fa pacato, il ritmo più lento di chi sceglie con attenzione immagini e parole: “Alcuni la chiamano Guerra Russo-Georgiana, altri Conflitto armato tra Georgia e Abkhazia, alcuni dicono che in realtà sia stata una guerra tra Stati Uniti e Russia, ma per abkhazi e georgiani è stata semplicemente una tragedia. Prima del 1992 avevo conosciuto la guerra solo attraverso libri e film, era una guerra lontana nel tempo – la Seconda guerra mondiale, finita prima che nascessi – e nello spazio, in un’Europa che non avevo mai visto. Ora vedevo quelle immagini nelle strade della mia città”. Lui sceglie di restare, ma lo fa a suo modo: “Armi e violenza non hanno mai fatto parte della mia filosofia di vita, non ho mai combattuto, ma sono rimasto a Sukhumi per tutti i tredici mesi e tredici giorni della guerra, ho visto tutti gli edifici, i paesaggi, la natura che avevano ispirato le mie poesie distrutti, ho visto la gente morire sulla spiaggia, portata via dalle onde del mio amato mare”.
Subito dopo la fine della guerra, come decine di migliaia di altri georgiani, Odisharia attraversa le montagne che separano Abkhazia e Georgia per scappare: “In più di 150.000 persone abbiamo percorso quei 250 chilometri a piedi tra le montagne per arrivare a Zugdidi, la città georgiana più vicina. Centinaia di persone sono morte durante il viaggio, intrapreso con la sola speranza di diventare sfollati interni nel proprio paese”. Anche per chi ce la fa, gli anni successivi non sono facili: “È stata più dura per le famiglie che vivevano lì da generazioni: la cosa più dolorosa è stata dover abbandonare i propri morti, sapendo che probabilmente non avrebbero mai più potuto visitare le loro tombe. Per loro è stato più difficile anche adattarsi qui”. Per alcuni, racconta Odisharia, non avere nulla e doversi ricostruire una vita da capo è stata una necessità che molti sono riusciti a trasformare in risorsa, “perché l’unica opzione era sopravvivere. Nel mio caso è stata la letteratura a salvarmi, ho potuto continuare a scrivere e usare la mia esperienza per raccontare, questo ha reso tutto più facile”. Da quel momento Odisharia dedica infatti la sua vita a usare la letteratura come un ponte per mantenere le relazioni tra le popolazioni del Caucaso separate dalla guerra: si deve a lui, per esempio, la prima raccolta di racconti mai pubblicata che contenga opere di autori georgiani, abkhazi, osseti, armeni e azeri. Molti altri sfollati non hanno la stessa fortuna, e si trovano abbandonati, senza una casa, un lavoro, un appoggio. Chi non ha prospettive, trova rifugio a Tskhaltubo.


Entrando nelle piccole stanze che una volta ospitavano i cittadini dell’URSS in villeggiatura e che oggi a distanza di pochi anni sono rifugi improvvisati, si vedono ancora i segni di quella migrazione. Una giacca dimenticata, una foto di famiglia appesa al muro, una lettera, libri, giornali, giocattoli sparsi per terra. E poi i segni delle piccole cose che danno dignità anche nell’esilio: una carta da parati economica ma colorata per rendere più allegro e familiare lo spazio, o una tenda ricavata da vecchie camicie lise cucita con cura.


Oggi, dopo più di vent’anni, la maggior parte degli sfollati ha trovato sistemazioni alternative “anche se la maggior parte dei programmi di ricollocamento del governo e delle ONG si sono conclusi solo nel 2018,” mi spiega Meri Bitsadze, strategic development manager di Charity Humanitarian Centre “Abkhazeti” (CHCA). Per quasi tre decenni queste piccole stanzette, ognuna col suo bagno – in cui si trovano ancora figurine di calciatori o pin up appiccicate ai muri – sono state casa per migliaia di sfollati. Nei sanatori vive ancora qualche decina di persone, ma per lo più sono vuoti. Come accade in altri luoghi con storie simili, il dolore e le tracce di chi è passato di qua si sono trasformati in attrazione turistica e così Tskhaltubo è stata per anni una delle mete predilette del “Dark Tourism” post-sovietico.
Le architetture sono di indubbio fascino. Certo, i muri sono scrostati, ma i colori pastello dell’intonaco sono ancora visibili. Qualche pavimento è collassato, ma gli altissimi archi neoclassici dei porticati reggono ancora. I monumentali mosaici, saloni, giardini e auditorium, anche se in rovina, trasmettono ancora il decoroso lusso del socialismo reale. Tskhaltubo ha un potenziale che attende solo di essere valorizzato. E le istituzioni georgiane ne sono consapevoli: nel 2020 il Ministero dell’Infrastruttura e dello Sviluppo Regionale ha indetto un concorso internazionale per la riqualificazione della città, vinto dallo studio di architettura veronese Ardielli Fornasa Associati. “La prima cosa che abbiamo suggerito con il nostro lavoro,” spiega Marco Ardielli, socio e co-fondatore dello studio, “è che Tskhaltubo doveva prima di tutto tornare a essere una città”. Da un lato, continua Paola Fornasa, “l’obiettivo del governo era quello di dare un valore ai singoli immobili per poterli mettere sul mercato”. Dall’altro, come chi si occupa di urbanistica e masterplan ben sa, ristrutturare gli edifici per poterli vendere non basta: “si era passati da un posto dove vivevano più di 12.000 persone, che avevano tutte un lavoro, una macchina, una casa, a Tskhaltubo come è oggi, dove vivono 2.000 persone, quasi tutte molto povere e senza un impiego. Dal nostro punto di vista la prima cosa da fare era tornare a investire in servizi per la comunità, anche per rilanciare il turismo: chi viaggia non ha certo voglia di visitare un luogo dove chi vive è abbandonato a sé stesso”. Il primo obiettivo nella pianificazione era quindi quello di “definire una città che abbia vita propria, anche con il turismo, soprattutto con il turismo, ma non soltanto”.
Attualmente Tskhaltubo si sviluppa a partire da un grande parco deserto nel centro della città, attorno al quale si distribuiscono, secondo uno schema circolare, i grandi sanatori, “le cui facciate imponenti sono pensate per essere scenografiche, ma spesso non corrispondono a una pari grandezza degli edifici”. Solo oltre i sanatori si trovano le abitazioni dei residenti, per la maggior parte semplici edifici di cemento o baracche in legno e metallo. Gli esercizi commerciali e i servizi sono quasi inesistenti. Quella attuale è una città che letteralmente ruota attorno ai sanatori: “il primo punto del nostro piano è far tornare Tskhaltubo vivibile prima di tutto per i suoi abitanti, che hanno subito troppo a lungo le trasformazioni negative che hanno coinvolto la città”. Normalmente, per rivitalizzare luoghi come questo si sceglie di attirare il turismo, nella speranza che questo generi una reazione positiva sulla popolazione e faccia crescere l’economia locale; ma è un meccanismo che quasi mai funziona. La prima cosa da fare è un investimento sul futuro urbano e sociale della città; solo dopo si può pensare al turismo”. Il parco, per esempio, secondo il piano degli architetti dovrebbe tornare a essere a disposizione delle persone che abitano la città. I corsi d’acqua dovrebbero tornare ad avere un ruolo centrale. Si tratta quindi di “ridisegnare il centro storico e una parte delle case popolari, da gestire con l’aiuto dello Stato o con la collaborazione di organizzazioni internazionali, che operano qui grazie a fondi stanziati da progetti europei e statunitensi.
“Un tema non risolto è quello dell’economia della città, che al momento non esiste. Una volta abbandonate le terme, si è creato una crisi economica che è poi diventata un problema sociale,” spiega Ardielli. E poi sono arrivati i profughi. . Per questo, il fattore economico è stato centrale nel disegnare il piano di sviluppo della nuova Tskhaltubo, partendo proprio dalle condizioni socioeconomiche della popolazione che, in opposizione alla narrativa pop legata alle ghost town, “semplicemente chiede un futuro”. Anche la pianificazione delle abitazioni ha seguito questa logica, spiega Fornasa: “abbiamo pensato a case economiche e da sviluppare in più fasi, in modo che anche la popolazione a bassissimo reddito possa riuscire ad acquistarle, popolando così il centro della città”.
Anche se il piano è stato consegnato, i lavori non sono ancora iniziati: Tskhaltubo resta sospesa tra la sua eredità e una visione ancora da realizzarsi. Qualche albergo è stato venduto e recintato – con grande rammarico dei dark tourist – ma nessun edificio ancora stato ristrutturato. Per ora, il processo di privatizzazione sembra solo un tentativo di raccogliere investimenti. I grandi saloni restano vuoti, nel silenzio dell’attesa. Negli anni, piante e perfino alberi ci sono cresciuti in mezzo. Nutriti dalla stessa acqua che potrebbe tornare a curare la città e i suoi abitanti.