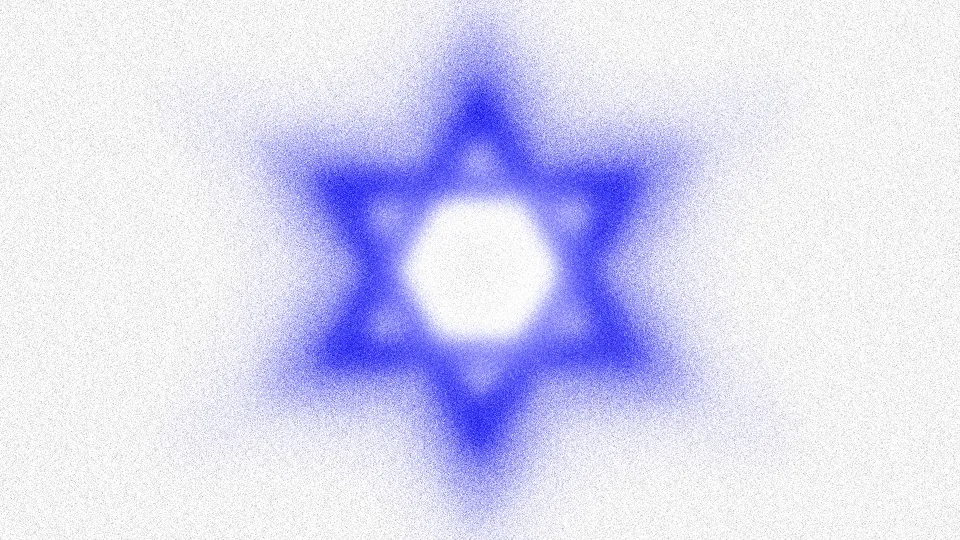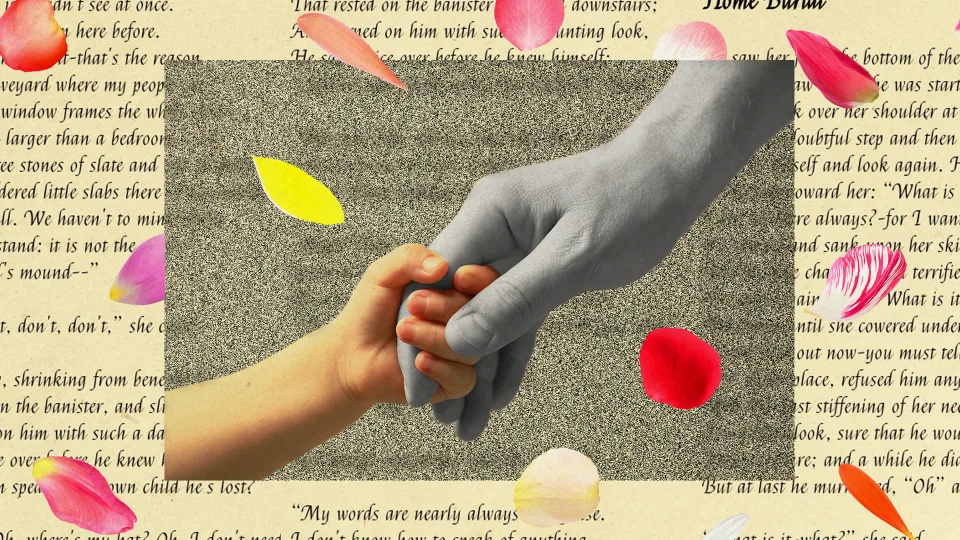L’ultimo film del regista statunitense, ispirato a "Vineland" di Thomas Pynchon, sta convincendo buona parte di pubblico e critica. La pellicola, con un cast di prim’ordine, è diversa e insieme affine ai suoi precedenti. A guidarlo, come sempre, sta un’ambizione formale che pare confermarne la statura come uno dei registi più interessanti degli ultimi decenni.
Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another, in lingua originale) non è solo il titolo di uno dei film più belli di questa stagione, ma anche una formula che perfettamente si attaglia a descrivere il tragitto del suo regista.
Del resto, negli ultimi anni, forse nessun autore come Paul Thomas Anderson ha dato prova di saper padroneggiare, in sequenza, generi e atmosfere tra loro diversissimi.
Dopo gli inizi corali nel solco del suo maestro Robert Altman, le commedie romantiche e assurdiste e una fase invece di compostezza classica (con The Master e Il petroliere, in particolare) che ha sospinto più di qualcuno ad avvicinare il suo talento registico, specie per il controllo dell’immagine, a quello di Stanley Kubrick, PTA sembra oggi aver impresso un passo diverso al suo cinema.
Sin dagli esordi i suoi film sono attraversati da personaggi svagati ma determinati, che si incontrano e scontrano, che si trovano e si perdono: (l’impacciatissimo Adam Sandler e Emily Watson in Ubriaco d’amore, i personaggi del biblico Magnolia, ad esempio); in questo suo ultimo lavoro, i movimenti tra loro sono ora accelerati e la macchina da presa, dopo una fase di indugi e primi piani, preferisce piuttosto documentare le collisioni a distanza, imponendo un ritmo sempre più indiavolato.
Le rincorse sospirose di Licorice Pizza, dove i gli sfrenati Gary e Alana si cercano lungo le strade della San Fernando Valley, idealmente proseguono dunque anche in quest’ultima pellicola che PTA ha ammesso di aver scritto per saziare il desiderio, squisitamente estetico, di filmare inseguimenti negli spazi sterminati del deserto americano.
Il regista ci riesce mettendo stavolta in scena il legame di un padre e di una figlia e, insieme quello di un’intera generazione di militanti radicali che, braccati dal braccio armato della polizia, provano a resistere fuggendo senza requie in un’America molto vicina all’attuale e dove però, non c’è neppure il tempo di nascondersi.
Possiamo dirlo da subito: Anderson ci è parso ancora una volta all’altezza delle proprie ambizioni formali e, anzi, appena riemersi dalla sala, si è profilata netta in noi l’idea che l’autore californiano sia oggi tra i pochi in grado di restituire l’appagante sensazione di una messa in scena millimetricamente allineata ai suoi propositi.
Di più: a questo pensiero è subentrato un dubbio ulteriore lievitato dalla meraviglia: se vi sia cioè una battaglia in cui Anderson non possa riuscire, visto il quanto di controllata entropia che amministra in questo film.
Difficoltà a cui poi andranno aggiunti i molti livelli che stratificano la sceneggiatura di questa sua ultima opera, che sta però inopinatamente raggiungendo un pubblico sempre più composito grazie a un passaparola verosimilmente amplificato dal supporto di un marketing massivo.
Si diceva, allora, di alcune costanti che guidano la multivoca opera andersoniana. Tra le tante, lo è in questo caso anche la scelta di muovere il soggetto a partire da un romanzo di Thomas Pynchon, autore – secondo la vulgata – di difficile rappresentazione per eccellenza.
Eppure, l’impresa di adattare Pynchon era riuscita ad Anderson già nel 2014 con Vizio di forma. A colpire in quel caso era proprio il rigore filologico con cui PTA aveva saputo restituire, immergendoli in una fotografia fumosa, i dialoghi surreali e i personaggi psichedelichi del libro – aspetti questi che, anche i meno scettici tra gli aficionados, reputavano credibili solo nel ristretto perimetro del romanzo.
In questo film, però, la battaglia è diversa e (almeno per certi versi) forse ancora più pynchoniana (lo scrittore, da par sua sta tra l’altro, per pubblicare un nuovo libro in uscita tra pochi giorni).
Anderson si serve in verità assai liberamente di Vineland, attingendovi alcuni protagonisti ma accantonandone altri, serbandone il gusto per l’onomastica parodica senza troppo insistere; il regista fa soprattutto sua poi l’idea decisiva (si pensi pure a L’incanto del lotto 49) che a legare le persone sia il riconoscersi attorno a una grammatica insieme cifrata e affettuosa (perché fatta di riferimenti condivisi), di fatto impenetrabile dall’esterno. Non per questo, d’altronde, anche tra chi vi partecipa da dentro, resta minore la quota d’incomprensione o angosciata paranoia.
“Sin dagli esordi i suoi film sono attraversati da personaggi svagati ma determinati, che si incontrano e scontrano, che si trovano e si perdono. In questo suo ultimo lavoro, i movimenti tra loro sono ora accelerati e la macchina da presa, dopo una fase di indugi e primi piani, preferisce piuttosto documentare le collisioni a distanza, imponendo un ritmo sempre più indiavolato”.
Anderson si libera quindi dal piglio digressivo di Pynchon e mette in fila un intreccio lineare (un solo lungo flashforward di 16 anni incerniera il film) che nel romanzo procede invece per salti, analogie o assecondando le memorie zigzaganti, spesso persino allucinate dalla nostalgia, dei suoi diversi protagonisti.
Il regista si disfa poi delle insistita satira della televisione americana che secondo alcuni (David Foster Wallace, per esempio) zavorrava quel romanzo al punto da renderlo, tanto è costantemente innervato da riferimenti a show statunitensi, un oggetto di decriptazione ulteriore per il pubblico italiano – e ciò malgrado il generoso apparato di note della traduzione in commercio e la nutrita schiera di iniziati-esegeti che lo scrittore ha saputo guadagnarsi anche da noi.
Certe delizie restano perciò nel libro: per quanto ci riguarda, e fermandoci su alcune: le pagine mirabili in cui uno psicologo disserta intorno alla sottile differenza tra soggetti defenestrativi o transfenestrativi, le trame disarticolate che ritardano la narrazione raggiando in direzioni sempre impreviste, le sigle poi con cui Pynchon inchioda certi tic giovanili nelle sue lunghe tirate descrittive con tono assieme dolce ed erudito (gli attacchi esempio di “OAC, ovvero Ossessione Adolescente per i Capelli”), o anche solo l’elenco caotico di attività commerciali (locali sognanti come il Bodhi Dharma Pizza Temple) e band che lo scrittore si diverte, volta a volta, a inventare o inventariare (gruppi dai nomi inusitati come i Fascist Toejam, “300 watt di apocalisse sonora”, per dire).
Eppure, nonostante un approccio affatto selettivo al romanzo, lo spirito resta tutto sommato intatto nel segno marcato della frenesia. Gli inseguimenti cartooneschi (Pynchon paragona fin dalle prime pagine l’eterna rincorsa tra polizia e reduci hippie alle gag di Gatto Silvestro e Titti), certo, così come l’umorismo paranoide sempre perfettamente in grado di calibrare il sottile nesso tra ridicolo e pericolo – miscela, s’intuisce, non sempre semplice da dosare sulla scena.
Ma insieme a questo, sta in quest’opera uno degli aspetti che più si apprezza oggi dei libri di Pynchon (oltre alla quantità cospicua di trovate spesso cerebrali da cui si viene travolti), quello della connivenza tra potere e desiderio che fa sì che nei suoi libri convergano (o siano tra loro attratte) figure all’apparenza inconciliabili.
Si ricorderà, in proposito, la memorabile Shasta di Vizio di Forma, capace di trascorrere pomeriggi romantici in compagnia dello scalcinato Doc Sportello, mentre è blandita dal tenore lussuoso dello scomparso magnate Mickey.
E non è un caso, forse, che questo sia il film più immediatamente politico di PTA. D’altronde lo è sin da subito e nella scelta, che è anche scarto ulteriore, di proiettare un romanzo ambientato negli anni Ottanta in un’attualità indeterminata (ci sono i telefoni, ma non i social), con gli irresistibili reduci-hippie di Pynchon diventati nel frattempo rivoluzionari contemporanei – va da sé, quindi, che alla repressione della destra reaganiana subentri invece lo squadrismo dei militari trumpisti.
Come Anderson ci ha abituato a vedere, il film inizia con una vulnerante sequenza di scene mirate a tratteggiare un’atmosfera in funzione di prologo. La camera segue il suaccennato gruppo di militanti, i French 75, che coordina un’offensiva politica per sabotare un carcere militare al confine tra Messico e Stati Uniti dove sono detenuti centinaia di migranti ritenuti irregolari.
La concitazione che proveremo durante l’intera visione ci è suggerita sin dall’abbrivio dalla colonna sonora di Greenwood che, insistendo, grave sui tasti mantiene lo spettatore in uno stato di perenne allerta anche nelle fasi all’apparenza più placide o meno forsennate del film.
Al comando dell’operazione, almeno per manifesto protagonismo, sta Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), attivista oltranzista quanto carismatica perfettamente a suo agio nel dominare il rischio, che in lei innesca appetiti erotici (non sarà la sola ad avvertire desideri obliqui).
Anderson resta su di lei mentre sullo schermo, con goffa lentezza le si sovrappone il suo compagno Pat Calhoun, personaggio interpretato da DiCaprio che ansima, perennemente in ritardo, in direzione dei suoi compagni.
E sempre lo troveremo a rincorrere col passo anchilosato la rivoluzione: è l’aggiornamento del tipico eroe pynchoniano, che aveva del resto salato il sangue al Drugo de Il Grande Lebowski, ma più di quello sembra covare in sé una critica al suo endemico torpore.
Il suo apporto al gruppo, dovuto alle sue conoscenze in ambito tecnologico, consiste nel fornire l’esplosivo necessario alle detonazioni. Per questo tratto specifico è davvero un trasparente ritratto di Pynchon il quale, lo ripercorre un partecipato articolo di Giacomo Ferrara dedicato all’autore, prima di divenire scrittore ha lavorato per la Boeing, industria che in negli anni di guerra fredda fabbricava missili. E infatti, è indizio di quelli notevoli, in più d’una scena lo sentiamo scopertamente chiamare col nome di battaglia di Rocket Man, ‘l’uomo dei missili’.
Come in precedenza parecchi personaggi di Pynchon, Pat si mostra presto inetto alla causa rivoluzionaria: arranca, tituba, fatica. In una scena lo osserviamo mentre ascolta arreso la madre di Perfidia rimproverargli che non è la persona giusta per lei, perché troppo vulnerabile per stare al fianco di una rivoluzionaria, il cui sangue freddo discende da una gloriosa stirpe di guerrigliere. La loro incompatibilità è quasi un fatto di passo.
In un’altra sequenza è lui stesso ad ammettere, al colmo d’ogni sconforto, di essersi distratto, ovvero di aver abbassato la guardia, mentre la situazione, a causa di una recrudescenza dell’oppressione fascista, è ormai deflagrata senza che potesse accorgersene.
Mentre in uno dei rarissimi scambi dialettici prolungati del film, lo ascoltiamo, alterato e polemico, sincerarsi con un’insegnante che nel suo lavoro si impegni a impartire la versione giusta della Storia, quella cioè secondo cui Benjamin Franklin è uno schiavista. Pat in effetti è stato brutalmente stroncato nel suo tentativo di imporre la sua idea del mondo, è un uomo visibilmente traumatizzato, ma il regista non ci trattiene le sue mancanze.
La critica Manhola Dargis sul «New York Times» ha definito il personaggio interpretato da DiCaprio “un uomo estremamente inconsapevole che si sente spinto ad agire contro l’oppressione solo quando questa lo tocca personalmente”
Proprio in ragione di queste immagini tutt’altro che autoindulgenti dei suoi protagonisti non sempre conveniamo con chi giudica superato il film dal punto di vista visivo nel suo tentativo, subito sorpassato dall’assurdo del tempo, di proporre un racconto sopra le righe della violenza oggi imperante negli Stati Uniti, e soprattutto al confine col Messico.
Si tratta di un discorso valido piuttosto per film come Don’t Look Up che giocano l’intera posta sull’anticipare la realtà enfatizzandone gli aspetti più patentemente superficiali, spesso con tratto affatto grossolano. Opere assai efficaci nell’immediato che abbozzano la nemmeno troppo avveniristica caricatura di Jeff Bezos e che vengono però poi inesorabilmente liquidate dal presente, specie se il suo protagonista-avversario (ancora DiCaprio) prende parte, fuori da panni attoriali, al matrimonio dell’imprenditore miliardario che per giorni occupa i rotocalchi, come pure la laguna di Venezia. Non è questo però un film che scommette l’intera sua efficacia nella satira marcata della realtà.
Certo umorismo discendente dal tanto aborrito postmoderno è stato poi un’arma talvolta troppo compiacente, spesso spuntata, anzi assorbita e agilmente riconvertita dalla destra post-ironica, che ha saputo sorpassare ogni sua rappresentazione farsesca, ma non è questo il caso di Una battaglia dopo l’altra.
Siamo viceversa di fronte a un film che, al netto degli afflati satirici orientati, è tutt’altro che tenue nei confronti dei propri protagonisti: e molto dello stato di palpitante angoscia che ininterrotto si avverte durante le quasi tre ore di visione deriva anche dalla messa in scena di un’impossibilità di una vera reazione da ogni parte (anche di quella dello spettatore).
Come ha scritto Lorenzo Rossi nella bella recensione al film apparsa su «Cineforum», Anderson nella scrittura è poi oltremodo sorvegliato nel fuggire ogni appiglio a un presente troppo rassicurante collocando il film in “uno spazio-tempo sfuggente, indefinibile e proprio per questo sospeso, instabile e quasi perturbante”. Insomma la quiete non è uno stato d’animo consentito: e anche per questa ragione, s’inferisce, la cittadina santuario di Vineland, qui ribattezzata Baktan Cross, non è il nido tutto sommato accogliente, teporoso, diversamente popolato del romanzo.
Durante il tentativo di sabotaggio del centro, Perfidia umilia il colonnello Lockjaw, un convincentissimo Sean Penn che dopo i molti ruoli metrosexual riesce qui a rendere con efficacia i tratti più respingenti che s’immaginano appartenere a un militare represso sul piano sessuale e protervamente fascista: la scena in cui lo osserviamo specchiarsi, il volto truce, e umettare un pettine un attimo prima di passarlo sul suo ciuffo, è un momento epifanico da perfetto cinema dei Coen. Ma Penn aveva già dimostrato la sua istintiva sintonia col regista dalla manciata di minuti di Licorice pizza in cui aveva intrepretato un notevolissimo William Holden, “l’uomo più ubriaco del mondo” giustappunto seduto al tavolino di un bar.
In un frangente dell’azione, e siamo davvero ai primissimi minuti del film, Perfidia per umiliare Lockjaw lo sfida ad avere un’erezione a comando mentre, intanto, gli punta contro una pistola coi pantaloni del soldato che, all’istante, si gonfiano assumendo turgori priapeschi.
È Pynchon in purezza: i suoi lettori riconosceranno le erezioni del protagonista de L’arcobaleno della gravità che preconizzano l’esatto punto di impatto dei missili su Londra – con l’irrigidirsi del suo pene che, trasparente parodia del fallocentrismo bellico, si fa dunque tutt’uno con un’arma di distruzione di massa. E in fondo questo eros tipicamente militaresco non è poi così diverso dalla furente parodia, sempre in punta di psicanalisi, che dei pruriti fascisti ha fatto Gadda nel suo Eros e Priapo.
Il militare, titillato da Perfidia, viene in quel momento trafitto da una (sado)masochistica ossessione per lei e decide di perseguitarla così da ottenere, tramite ricatto, la possibilità di possederla. Ma è davvero eccitato da lei? si tratta cioè di un caso di feticizzazione razziale da manuale o è invece esaltato anche dalla pistola che Perfidia impugna? La sua reazione a una battuta circa l’eccessiva aderenza della sua maglietta lascerà qualche dubbio, la marcetta compassata con cui lo vedremo procedere dopo un loro incontro decisamente meno.
In uno dei suoi voyeuristici pedinamenti, il colonnello la coglie sola e indifesa, nel corso di un tentativo d’innesco d’un ordigno. Perfidia sembra cedere alle avances, specie perché il compromesso le permette di proseguire la propria attività politica. Pochi fotogrammi dopo la osserviamo gravida imbracciare un mitra e sparare nel vuoto (al grido di “come Tony Montana!”) in una delle istantanee più potenti del film.
La situazione però precipita quando, ancora nel corso di una rapina in banca, Perfidia, in un nervoso montare, assassina un agente. La tenaglia degli apparati si stringe allora sul gruppo, Anderson è perfetto nel girare dall’alto e poi tutt’attorno l’asfittica manovra che li avvolge: pregevole è qui poi il realismo dell’inseguimento con le macchine dei cittadini che, ignari, avanzano lente nella routine mentre le auto della polizia e i fuggiaschi sfrecciano in serpentina.
Perfidia è catturata. La donna patteggia per evitare il carcere e in cambio della protezione testimoni in una deprimente casa in lamiera spersa in un’anonima provincia americana (squallido e grigio lusso a cui presto rinuncerà a sua volta fuggendo) fornisce all’FBI i nomi dei suoi compagni, atto che le varrà la sempiterna etichetta di “infame”.
Alcuni degli attivisti vengono intanto impunemente massacrati dagli apparati, altri riescono invece a nascondersi mediante identità fittizie con cui continuare in frange via via sempre più sparpagliate e inconseguenti.
Il prologo termina così sulla fuga disperata di Pat in auto, con la macchina da presa che dal suo volto stralunato si assesta su quello del piccolo e incosciente essere umano che è adagiato nell’abitacolo: la neonata figlia Charlene, personaggio a cui Greenwood dedica, forse non per caso, il tema musicale più sentito del film.
16 anni dopo ritroviamo Pat a Baktan Cross, ma ora si chiama Bob Ferguson. Cosa è successo nel frattempo? La figlia, ribattezzata Willa, è addestrata alle arti marziali, va bene a scuola, ha un suo giro di amici che il padre fatica a comprendere e apparentemente non possiede un cellulare proprio per via delle paturnie paterne.
Pat di contro sembra un uomo alla deriva, trascurato e ormai in stato confusionale, appannato com’è dall’alcol e dagli abusi di sostanze: alla televisione guarda stordito La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, magari per rincantucciarsi nel remoto passato di una rivoluzione riuscita.
Tra tutti gli inseguimenti, quello tra generazioni è il più commovente del film: d’altra parte sin dal suo esordo Sydney, e forse più marcatamente ancora ne Il petroliere e in The Master, Anderson ha dimostrato una sensibilità spiccata per il racconto delle relazioni (in tutti i sensi) filiali.
Si ricordino anche solo alle accudenti premure che, in Boogie Nights, Julianne Moore riserva al giovane e superdotato Christopher Walberg e alla troppo poco citata RolllerGirl (Heather Graham) che in una scena di disperante solitudine (le due stanno sniffando insieme cocaina a una festa) la chiama appunto “mamma”.
Anche quella tra Bob e Willa è la relazione che guida la sceneggiatura ma, a differenza dei precedenti film di Anderson, dove era l’ammirazione totalizzante dei figli (o degli allievi) ad animare legami che poi si evolvevano secondo riassestamenti di potere spesso morbosi, qui i ruoli sono in partenza più equilibrati.
Anzi, la ragazza-ninja, decisamente più del suo ansioso papà, è perfettamente in grado di badare a sé stessa. Il suo affetto per lui è sincero e tutto sommato taciuto. A ben guardare la dinamica tra loro non è poi così diversa da quella che Bob aveva già esperito con la madre dell’adolescente – infatti finirà per rincorrere anche lei.
Magistrale, in proposito, è il modo in cui il regista gestisce una scena topica (non è la sola) dei film americani: quella in cui la figlia deve andare al proverbiale ballo di scuola.
DiCaprio è qui abilissimo, forse più convincente nel resto del film dove invero non concede picchi, nel tenere insieme un registro che salda la serenità ostentata con l’ansia per la figlia che gli proviene, però, non dalla natura rituale dell’evento, bensì dal suo intrinseco, verrebbe da dire isterico, senso di accerchiamento.
E d’altra parte la situazione è solo all’apparenza quieta. Nei bagni della scuola uno speciale apparecchio a pile del gruppo rivoluzionario, che il padre ha dato in dotazione alla figlia, suona: l’imperativo, in casi del genere, è quello di affidarsi senza indugi alla persona che nei paraggi possiede lo stesso oggetto in allarme (nel libro di Pynchon si trattava di un più improbabile biglietto da visita in grado di emettere jingle).
Dopo attimi di panico, così fa Willa che, soccorsa da un’ex compagna del padre, viene scortata in un convento fidato. La polizia, dopo tutto questo tempo, è ancora sulle loro tracce e Lockjaw in particolare ha più di una ragione per continuare a braccarli: sta infatti tentando di scalare un bizzarro ordine a metà tra un esclusivo club massonico e il Ku Klux Klan: lo scopriamo così, in una sorta di piramidale disvelamento, essere una pedina tutto sommato minuscola al cospetto del più alto ordine che lo sovradetermina.
Inizia un inseguimento quasi d’animazione: Lockjaw bracca Willa che a sua volta è cercata da Bob: uno dopo l’altro, appunto. A loro si aggiungono varie figure da cartone animato tra cui spicca un sicario voluto dalla congrega i cui membri hanno nel frattempo scoperto della segreta relazione tra Lockjaw e Perfidia, ed è dunque stato inviato a “pulire” ogni possibile compromissione meticcia con la loro grottesca missione.
Nonostante l’indubbia assurdità a partite dal nome (I pionieri del Natale) il gruppo risulta assai più temibile e sinistro di altre rappresentazioni innocue che, in particolare il cinema negli anni, ci ha offerto di questo genere congreghe: si pensi, per fare un solo spassoso esempio, alla scena dei cappucci in Django Unchained dove il dilettantismo dei membri dell’ordine, legittimamente trattati da Tarantino come una banda di stolti pressoché improvvisati e derivativi, rischia per un momento di far accantonare la matrice dei loro intenti.
Come quella anche scene in cui Bob tenta di rintracciare il punto di ritrovo dove stanno proteggendo la figlia sono esilaranti. A protezione del convento stanno infatti una serie parole chiave che l’uomo ha sciattamente dimenticato o forse mai memorizzato davvero. Si tratta di un linguaggio che ormai s’è perso negli anni: credenze che per Pat possono risultare ormai vacue o, peggio, orfane di senso: formule insomma di un manuale da troppo tempo non aperto.
L’esasperazione con cui l’uomo assertivamente richiede l’indirizzo dov’è custodita Willa e la seraficità meccanica con cui all’altro capo gli viene richiesto “Che ore sono?” senz’altro divertono per il culmine paradossale e la divergenza di toni ma difficilmente s’immagina una rappresentazione più tragicamente riuscita dello scontro tra due diverse generazioni di attivisti che sono dalla stessa parte e, al contempo, non sono in grado di comprendersi (“Si vede che non hai mai avuto figli!”). Altro non è che l’ennesimo inseguimento del film: la loro conversazione più che un atto di soccorso tra compagni fa pensare all’esito distopico di una telefonata a un call center.
A soccorrere Bob nella ricerca della figlia per volere di un karma benevolo subentra il sensei Sergio St. Carlos, magnificamente interpretato da Benicio Del Toro (l’attore portoricano sembra nella parte anche nelle conferenze di promozione) che, assieme a Sean Penn, ci offre forse il ruolo più memorabile del film
Eclettico maestro di un dojo, protettore di una comunità di rifugiati ispanici che vive nascosta nel suo soffitto, fautore di una spiritualità vagamente buddista e new age parecchio abborracciata ma persuasiva, nutrita com’è di mantra (“Respira l’Oceano, respira l’Oceano”) si tratta forse della sola figura in grado di attenuare il panico di Bob (perlopiù porgendogli birre).
“Certo umorismo discendente dal postmoderno è stato poi un’arma talvolta troppo compiacente, spesso spuntata, anzi assorbita e agilmente riconvertita dalla destra post-ironica, che ha saputo sorpassare ogni sua rappresentazione farsesca, ma non è questo il caso di Una battaglia dopo l’altra”.
Ma soprattutto, lo ha acutamente rilevato in una sollecitante disamina su Fb Paolo Simonetti, uno dei maggiori esperti di Pynchon in Italia: “Nel sensei rivive il grande insegnamento pynchoniano: KEEP COOL BUT CARE. Dotato di un aplomb formidabile – Hemingway la chiamerebbe ‘grazia sotto pressione’ – Benicio del Toro offre la vera – e unica – alternativa positiva a questo mondo marcio, fatto di violenza (da tutte e due le parti), idiozia, irresponsabilità, debolezza ed egoismo”. E facciamo nostra anche un’altra intuizione dello studioso sulla positività del personaggio: il sensei non è a suo agio con le armi, che tiene riposte e inutilizzate.
Per un tratto di strada, tra i più slapstick e godibili del film, il Maestro scorta e protegge Bob, ma le loro vie devono divaricarsi. Ed è sulla scia di un’infilata di ripetuti rovesci di fronte, tradimenti o incomprensioni mai prevedibili che Anderson gira, obbedendo alla ragione che lo aveva in origine indotto a scrivere questo film, una sequenza che si faticherà a scordare nei prossimi anni.
A ben guardare, qualcosa di analogo, anche se solo di vagamente sovrapponibile, il regista già lo aveva sperimentato in Licorice Pizza con la lunga retromarcia del camion, Alana Haim alla guida, e dietro una torma di adolescenti, che nel buio lentamente precipitavano giù dalle pendici delle colline di Los Angeles.
In questa il cineasta si sporge però decisamente oltre: e ci riesce con l’intuizione di una focale stretta attraverso cui filma una rincorsa a tre che è uno strabiliante saliscendi alla William Friedkin su e poi giù per le doline del deserto della Central Valley.
Momenti in cui il cinema, per dire così, è ricondotto alla sua origine spettacolare: in sala infatti il respiro pare tagliarsi ed è difficile resistere alla vertigine mentre le macchine s’inabissano e poi riaffiorano assecondando l’andamento sinusoidale della strada col calore che, all’orizzonte, fa vibrare l’aria liquida fermata dalla pellicola (i pregi del VistaVision, si dirà).
Come ha acutamente notato Mario Sesti all’atto di elogiare la perizia tecnica di Anderson, in questa sequenza per la highway “sembra che lo spazio si dilati insieme al tempo, come nella relatività”. La forma aderisce dunque perfettamente alla trama, e si fa stile: non si ravvisa infatti nessun compiacimento lezioso in una scena che semplicemente lascia increduli e che, in mano ad autori appena meno avvertiti o scaltri nella scrittura, poteva agilmente scivolare in un esercizio di troppa maniera.
“Proprio come i giovani amanti di ‘Licorice Pizza’, padre e figlia sembrano infine ritrovarsi: e i due si (ri)conoscono anche grazie a un codice che entrambi hanno riscoperto legarli durante il viaggio”.
Proprio come i giovani amanti di Licorice Pizza, padre e figlia sembrano infine ritrovarsi: e i due si (ri)conoscono anche grazie a un codice che entrambi hanno riscoperto legarli durante il viaggio. La camera ora apparentemente sembra placarsi: abborda i protagonisti per la prima volta da vicino e li spia dentro un intreccio d’affetto tutto loro, una tregua preparata da due ore di fuga.
Ma non dura più d’un momento: Willa, aderendo al suo viaggio dell’eroe, ha attraversato la sua origine, si è riconciliata con i desideri di una madre che credeva eroina e ha scoperto traditrice, ed appare già pronta al nuovo inseguimento: quello della sua eredità politica.
La perenne narcosi di Pat, che invece resta inebetito sul divano ad armeggiare col telefono proibito, non le appartiene – è forse questo un odierno adattamento della dipendenza da televisione che Pynchon satireggiava in Vineland, persino profetizzando dei centri di disintossicazione dagli schermi? L’approdo a un nuova tranquillità? O un più semplice e silente passaggio di testimone? Non è il solo interrogativo che il film lascia insoluto in un finale più hollywoodiano del resto.
Quanto a noi, non possiamo non dirci certi almeno d’una consapevolezza: quella d’essere fortunati nel poter partecipare al percorso di PTA, un regista che non smette di evolversi e di abbacinarci tanto più che, a visione conclusa, si è subito punti dalla tentazione di rientrare. O di vagheggiare sulla sua prossima battaglia. E poi su quella ancora dopo, ossia l’altra.