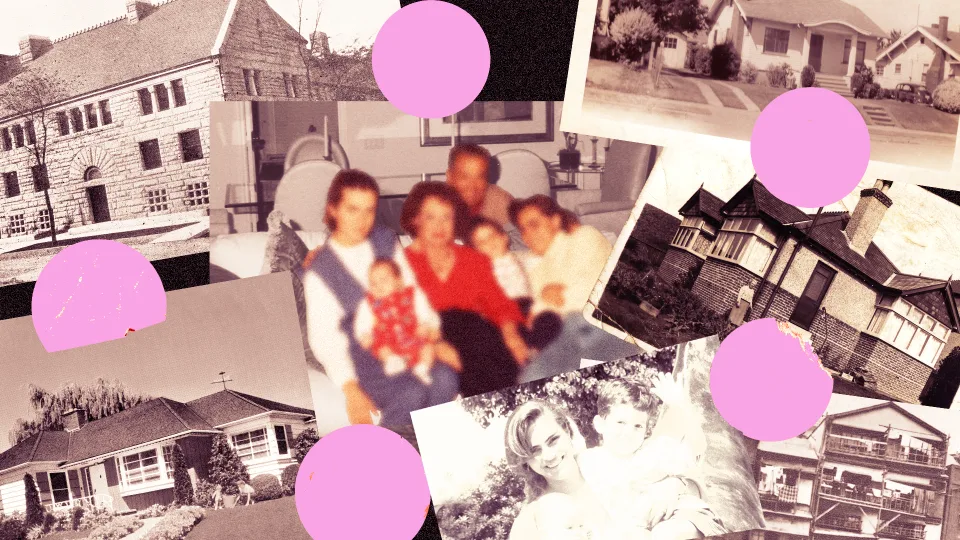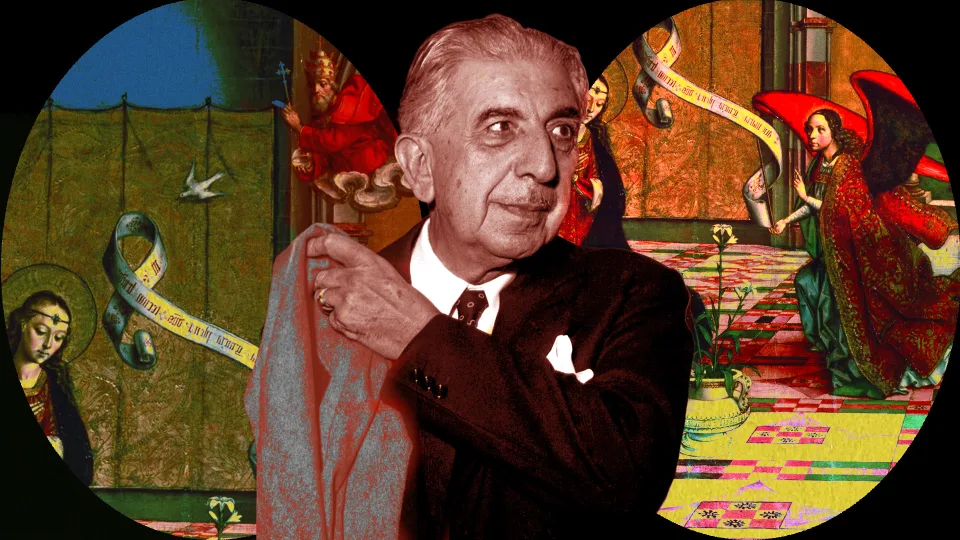La storia della coppia Trevallion-Birmingham e dei loro figli ha appassionato l'opinione pubblica solleticando paure, idealizzazioni e proiezioni che tutti coltiviamo e che si intrecciano con il senso delle istituzioni, dei servizi sociali e del diritto individuale. Ma cosa rimane una volta che la retorica – drammatica o romantica che sia – si dissipa?
A Palmoli in provincia di Chieti Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, una coppia anglo-australiana, vivono con i tre figli in un piccolo casolare isolato nei boschi. I bambini, una di otto anni e due gemelli di sei, vengono educati dai genitori. Dopo un episodio di intossicazione da funghi lo scorso settembre che li ha costretti a recarsi in pronto soccorso, le autorità hanno iniziato ad approfondire la loro situazione. Il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha poi deciso di allontanare i bambini dalla casa, collocandoli in una comunità protetta, sostenendo che l’isolamento e le condizioni dell’abitazione fossero potenzialmente un rischio per il loro benessere fisico, psicologico e sociale. Tramite il loro avvocato, i genitori hanno annunciato ricorso e contestato la ricostruzione del tribunale, dichiarando che i figli stanno bene, sono seguiti e non vivono in condizioni di abbandono o di isolamento.
La decisione del Tribunale dei Minori ha provocato reazioni molto forti: la giudice che ha firmato il provvedimento è stata oggetto di minacce, il sindaco e molti abitanti di Palmoli hanno difeso la famiglia, ritenendo che conducesse semplicemente uno stile di vita alternativo ma non pericoloso, e online sono state lanciate petizioni che hanno raccolto migliaia di firme. Arianna Fioravanti, direttrice della rivista «Gli altri animali», ha indetto una manifestazione nazionale per il prossimo 6 dicembre davanti al ministero delle Pari Opportunità per “difendere la libertà di educazione”.
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato così la vicenda: “Mi sembra una scelta vergognosa, assurda, pericolosa per la salute dei bambini [allontanarli dai genitori nda]. Abbiamo già chiesto come Lega chiarimenti al ministro della Giustizia. Farò di tutto, se serve anche andando sul posto per riportare a casa quei bambini”. In attesa della riforma della giustizia, questa vicenda è diventata anche un perfetto cavallo di battaglia elettorale.
Quella di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è una storia piccola, locale, privata che tuttavia solleva questioni enormi che interessano tutti: si va dal libero arbitrio ai confini dell’individualismo, dalla genitorialità alternativa alla necessità di una rivoluzione personale, anticonsumistica e ecologica. Impossibile per questa storia non diventare oggetto di discussioni forsennate. Ognuno ha un’opinione netta e ognuno ci proietta le sue paure, insoddisfazioni, desideri, aspirazioni. Chi non ha voglia di cambiare stile di vita? Chi non ha vagheggiato ogni tanto di lasciare il lavoro e vivere a contatto con la natura? Questa è una vicenda che turba l’opinione pubblica anche e soprattutto perché ci mette davanti a uno specchio: i nostri figli o gli amici dei nostri figli sono davvero più felici dei bambini del bosco? I nostri figli che vanno a scuola e hanno una “socialità strutturata” (come viene auspicato dalle carte del Tribunale dei minori) hanno davvero relazioni soddisfacenti o stanno per lo più a casa con il cellulare in mano? Vivere nella natura non sarà meglio per loro che vivere in città inquinate? E noi siamo più felici della coppia nel bosco?
Ci sono tanti piani in questa storia. Uno concreto, legato alle condizioni abitative. Uno legale, uno sociale che riguarda soprattutto i servizi e le cure mediche, uno politico-strumentale, e ovviamente uno psichico e proiettivo, che forse è quello più interessante.
Il giornalista di Radio3 Graziano Graziani ha scritto in un post su Facebook che la vicenda della famiglia “ci ricorda che, allo stato attuale delle cose, chi è fuori norma, quindi fuori standard, è guardato con sospetto.” (E ancora di più lo è se fa parte di una minoranza come nel caso dei rom. Numerosi sono i casi di bambini tolti alle madri rom, con motivazioni quasi sempre legate a condizioni abitative ritenute non idonee; tuttavia sono casi che fanno meno notizia di questa vicenda dove i protagonisti sono bianchi e anglosassoni).
Sulle condizioni abitative mi sento coinvolta in prima persona: io stessa ho fatto esperienza di standard abitativi non esattamente standardizzati. Per dieci anni ho vissuto nella campagna umbra in una casa colonica senza riscaldamento, con il mio compagno di allora e nostra figlia piccola. Casa peraltro assai più isolata del “rudere” della coppia anglo-australiana. Ho vissuto anche per lunghi periodi a bordo di una barca a vela, sia in mare che nei cantieri (con la barca sollevata su un invaso d’acciaio, quindi senza sanitari utilizzabili all’interno dell’imbarcazione). Siamo sopravvissuti tutti. La bambina a circa due anni ha messo il ditino sulla stufa a legna, si è bruciata, ha pianto molto e da allora ha capito che non doveva più farlo. Ha imparato molto presto ad arrampicarsi sugli alberi, a nuotare, si è in effetti ammalata pochissimo. Vivere con l’essenziale – per scelta – può essere educativo, può essere faticoso, ma non uccide nessuno. “Uccidono più ragazzini le case surriscaldate che le barche, piccole o grandi che siano”, scriveva Jack London in The joy of small boat sailing nel 1912, spiegando ai suoi lettori per quale motivo aveva scelto di fare il giro del mondo invece di starsene comodamente a casa. L’anticonsumismo che s’impara vivendo non tanto in mezzo alla natura ma in modo spartano – cosa che può avvenire anche in una città – è senza dubbio istruttivo di per sé. (Detto ciò, non illudiamoci che crescere i figli in maniera radicale e anticonsumista implichi avere dei figli che abbiano per forza introiettato quei valori. Mia figlia oggi ha 15 anni e il suo sogno è vivere a New York e al momento ha espresso il desiderio di comprare dei costosissimi stivali Ugg grazie al Black Friday).
Tornando alla vicenda: al di là degli standard abitativi ci sono quelli sanitari, più delicati e controversi. Nella casa dove la famiglia viveva erano stati tolti deliberatamente i servizi sanitari, oltre che l’elettricità e l’acqua corrente: quest’ultima per evitare il contatto con le microplastiche contenute nell’acqua. Leggere che questi bambini, ricoverati all’ospedale per intossicazione, rifiutavano di mettere il sondino perché secondo i loro genitori non sarebbero dovuti entrare a contatto con nessun tipo di plastica inquieta. Oltretutto c’è un evidente paradosso. Si è contro il sistema, ma solo in certi casi: il servizio sanitario nazionale va bene se ti salva dall’intossicazione alimentare, ma lo si rifiuta se si tratta di vaccini o cure pediatriche – la coppia è novax.
E qui arriviamo alla questione centrale, quella della relazione tra pari e dell’isolamento. Le carte del Tribunale dei Minori parlano di “deprivazione di interazione tra pari”. La mancanza di socialità o di socialità variegata (che comporta frequentare non solo di famiglie con uguali valori e scelte di vita) implica secondo il Tribunale scarsa “capacità critica”, “difficoltà nella gestione del conflitto” e ostacola “lo sviluppo delle competenze sociali, emotive e cognitive essenziali, rendendo più difficile l’adattamento del bambino sia nel sistema educativo che nella società in generale”.
La vicenda dal punto di vista legale è ben riassunta da «Pagella politica» ma è chiarissimo dalle carte che il problema è il diritto alla relazione negato e non, come si legge in molti commenti sui social e sui giornali, il diritto all’istruzione (anche se i genitori non hanno mai fornito la documentazione valida per l’istruzione parentale e quindi attaccabili anche da questo punto di vista).
Un dato che mi è sembrato significativo è quello della lingua. Nell’ultima udienza del 28 ottobre i bambini sono stati ascoltati con la madre presente perché non parlano bene l’italiano. Nati e cresciuti in Italia, i figli della coppia faticano a interagire con chiunque al di fuori della famiglia. E la presenza della madre non ha consentito di garantire libertà e spontaneità nelle dichiarazioni dei bambini. Sappiamo tutti quanto velocemente i bambini imparano una lingua straniera: sembra un po’ strano e molto grave che questi non avessero imparato l’italiano. Se conoscete famiglie che hanno figli bilingue avrete notato che i bambini tendono dimenticare e a non volere parlare la loro lingua madre, ma fanno di tutto per integrarsi e parlare la lingua del posto in cui vivono. Ancor più strano: i genitori dicono di parlare cinque lingue.
Conosco una donna che è stata pioniera dall’educazione parentale in Italia. Oggi i tre figli di Etain Addey, nature writer inglese ma umbra d’adozione, sono tutti laureati e integrati nella società, parlano perfettamente italiano (e inglese). Addey, contadina per scelta e ecologista, ha educato i figli a casa e ha raccontato la sua esperienza in un libro peraltro scritto in un italiano magnifico, Acque profonde (Fiori Gialli). Anni fa mi disse: “Se non si è d’accordo con la società di consumismo e guerra permanente, è molto strano mandare i propri figli a fare gli apprendisti! È chiaro che questa società ha anche dei valori positivi, ma il miscuglio di valori positivi e politiche reali aggressive crea confusione negli adulti, figuriamoci nei giovani. Non è che per fare questa scelta un genitore debba per forza avere uno stile di vita radicale, ma certo che l’indipendenza del ritorno alla terra crea un contesto fertile per i ragazzi”.
Populismo “emozionale” o ipocrisia dello stato?
Si tratta di capire dunque il confine tra un certo populismo “emozionale” – la retorica della famiglia unita, l’idealizzazione della scelta radicale e utopista – e i reali bisogni dei bambini. Che non sempre sono quelli dei genitori. Ma soprattutto: siamo certi che per i bambini e le bambine sia salutare vivere sempre con i genitori? Se vivere “nella natura” è nella stragrande maggioranza dei casi salutare, ho dei dubbi che la chiusura asfittica e la presenza costante del padre e della madre che diventano modello unico di riferimento, insegnanti, mentori, amici lo sia più di tanto. La pandemia avrebbe dovuto insegnarci qualcosa su questo.
Lo sdegno che ha sollevato questa storia va ovviamente anche a toccare alcune ferite aperte del nostro Paese: la metà dei bambini italiani frequentano scuole che cadono letteralmente a pezzi, per cui è un po’ un controsenso invocare la sicurezza in questo caso. Abbiamo anche un problema di sicurezza sul lavoro enorme, come può un Tribunale preoccuparsi così tanto di questa famiglia che vive “alla ricerca della bellezza”?
E veniamo infine alla questione più spinosa, quella dei servizi sociali. È facile e in parte giusto empatizzare con dei genitori a cui hanno tolto dei figli (madre e bambini vivono nella stessa struttura ma separati, mentre il padre è rimasto solo): sicuramente è una soluzione difficile da accettare e che forse poteva essere evitata. Ma oggi mi pare che gli assistenti sociali siano la categoria più bistrattata (secondi, forse, solo ai giornalisti).
Alcune prese di posizioni anche da parte della nostra classe politica hanno ricordato la storia del caso Bibbiano in Emilia-Romagna, e tutto ha l’aria di un generale attacco ai servizi sociali “nemici dei bambini e delle famiglie”. In Piemonte la giunta regionale ha tolto molti fondi ai servizi sociali. Esiste persino un’associazione, Bikers Against Children Abuse, che interviene e dà sostegno alla giunta regionale contro gli allontanamenti decisi dal Tribunale dei minori.
La psicoterapeuta Costanza Jesurum ha scritto in difesa dei servizi sociali: “Quando valutiamo faccende del genere il pensiero va a un immaginario provvedimento che faccia stare tutti bene, o un’assenza di provvedimento che sembri lasci stare tutti abbastanza bene. Invece quello con cui si ha spesso a che fare sono: contesti dove ci sono vari motivi di grave malessere che possono avere delle isole di funzionamento e di risorsa – che però da sole non riescono a contrastare le aree di malessere”. Per poi esprimere il suo “scetticismo di fronte a molti dei casi in cui i figli vengono tolti ai genitori. Mi faccio davvero tante domande. Ma devo dire che la risposta è di volta in volta non molto facile”.
C’è infine un’ultima questione, quella finanziaria. Catherine, la madre dei bambini, sul suo sito vende “letture energetiche”. La lettura energetica è quando “ti do una lettura di dove potresti trovarti nella vita e quali passi avanti la tua Anima e le tue Guide Spirituali vogliono che tu compia. La Guarigione Energetica può avvenire durante tutta la Lettura così come possono emergere vite passate per chiarire le crescite presenti, le relazioni karmiche e la guarigione”. Costo 200 euro.
Tutto questo mi ha fatto pensare a quella lunga linea che collega il mondo della spiritualità alternativa a uno spiccato attaccamento al denaro e una certa opaca avidità. È dai tempi di Osho e dello scandalo finanziario della comunità di Rajneeshpuram raccontata in Wild Wild Country fino agli scandali di Scientology che l’universo new age presenta dei punti ciechi nella gestione delle finanze. Sapere che gli stessi genitori della famiglia del bosco, gli stessi che hanno esposto i loro tre figli portandoli in tv alla trasmissione Le iene, abbiano dichiarato di accettare cure pediatriche per i loro figli solo a fronte di un pagamento di 50mila euro per bambino fa riflettere e aggiunge un elemento controverso a questa storia che della favola ha davvero ben poco.
Come ha scritto Djarah Kan questa storia è stata trasformata dai media e dall’opinione pubblica in una fiaba consolatoria che cancella la complessità dei fatti e la vulnerabilità dei bambini coinvolti. “Ripetere che i bambini sono felici felici felicissimi in un luogo immerso nel verde lontano dal bullismo dalle droghe e dalla violenza funziona come lenitivo contro i dolori di una società di adulti frustrati bloccati in periferie e metropoli tossiche. E in questa caccia all’idillio bucolico svanisce qualsiasi tentativo di ragionamento basato sui fatti e non sulla ricostruzione di questi ultimi ad uso e consumo del pubblico”.
Non sono certa che la vicenda diventi per forza o sempre il contenitore di un malessere sociale più ampio come scrive Djarah Kan, ma di certo un caso delicato come questo è diventato uno specchio deformante delle nostre mancanze e per alcuni il simbolo identitario che alimenta la sfiducia nelle istituzioni e la nostalgia per una purezza utopica.
È di ieri, mercoledì 26 novembre, la notizia secondo cui l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia, ha rimesso il proprio mandato. Sostiene di non poter continuare a rappresentare i suoi assistiti per ragioni deontologiche. La coppia Trevallion-Birmingham pare non essere disposta a scendere a compromessi per ottenere il ricongiungimento: avrebbero rifiutato la ristrutturazione della loro abitazione a titolo gratuito, il trasferimento in un’abitazione poco distante, l’aiuto di una psicoterapeuta che li assistesse in tribunale.