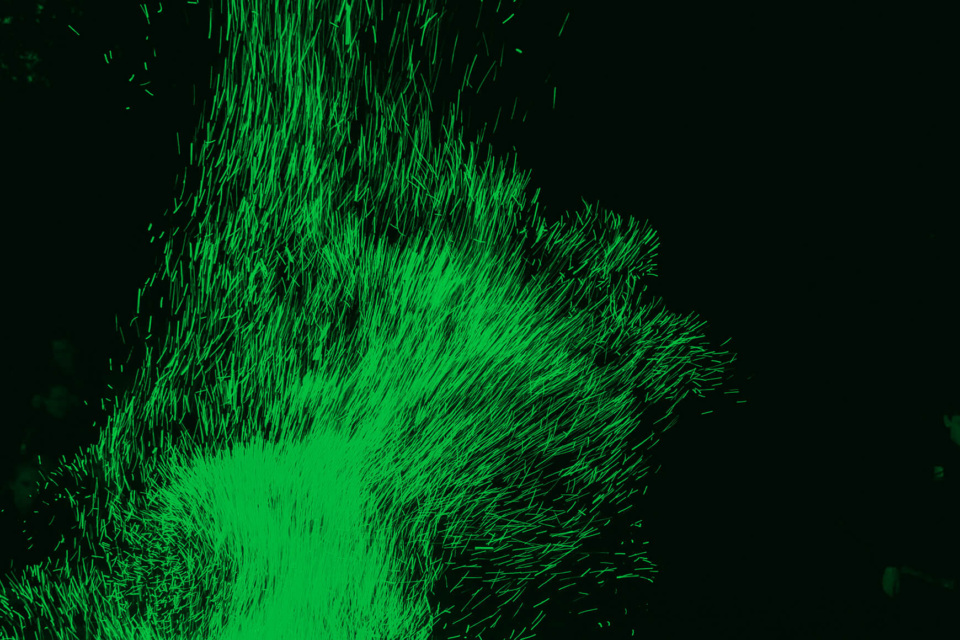Il nuovo e atteso film di Josh Safdie, ispirato alla vita del giocatore di ping pong Marty Reisman, mette in scena un personaggio senza scrupoli dentro una trama frenetica animata da continui colpi di scena. A emozionare di più, proprio per questo, sono però le sequenze del film in cui il ritmo, anche solo per un momento, si arresta.
A ben pensarci era fatale che uno sport scattoso come il ping pong incontrasse prima o poi le parabole in tutti i sensi schizzate dei protagonisti di Josh Safdie, ½ dei Safdie brothers, al suo primo lavoro alla regia in solitaria con Marty Supreme dopo il successo in coppia con Uncut Gems.
La separazione occasionale dal fratello Benny, che ha girato invece il per molti aspetti diversissimo The Smashing Machine, ha fatto quindi intuire al pubblico, come pure ora accade con il cinema dei Coen (duo che forse non ha beneficiato della scissione) quali elementi ciascuno dei fratelli ha disciolto nel cinema dell’altro.
Di certo, a differenziare le due pellicole sta il passo. The Smashing Machine ha spesso quello posato del documentario, laddove Marty Supreme all’apparenza inscena un’ascesa sportiva vulnerante che, di volta in volta, assume la concitazione da gangsta movie o il nervosismo febbrile del noir: generi da cui attinge consapevolmente gli stereotipi per farli propri al doppio della velocità.
La saldatura perfetta tra le due anime era avvenuta forse già all’esordio col lungometraggio Daddy Longlegs dove le corse palpitanti di un padre buffo ma degenere erano in realtà il ritratto oscillante e in Super 8 di un uomo allo sbando.
Lo stesso, seppure retrocedendo al 1952, si potrebbe dire di questa inquieta vicenda. Il film si apre proprio con una fecondazione a seguito di un amplesso furtivo che, in un’analogia per violenza simile alla celeberrima transizione da osso ad astronave dell’odissea kubrickiana, assimila un ovulo a una pallina da ping pong.
Siamo negli anni Cinquanta in una New York povera e riemersa guasta dalla guerra. Safdie – per mezzo di lunghi carrelli o piani sequenza – ce ne mostra palazzoni bruniti, mariti in canottiera (wife-beater, in slang), scale antincendio che paiono tolte dalle vignette di Will Eisner e botteghe prese dalle stampe di Norman Rockwell.
Al centro della storia sta Marty Mauser, giovane ebreo determinato a ogni costo a diventare famoso nel ping pong, e magari anche a stipulare un contratto con Dio per riuscire nel suo intento. La vicenda è solo in parte ispirata a quella dell’icona del tennistavolo statunitense Marty Reisman, e chissà se è un caso la scelta di Safdie di dare al suo protagonista il cognome di un fucile a ripetizione.
Difficile poi resistere alla tentazione di sovrapporre la medesima ambizione a Timothée Chalamet nella proverbiale corsa per l’Oscar con l’interpretazione di un’opera tutta incentrata sulla propria verve attoriale e di cui pure figura tra i produttori.
E del resto l’ambizione di Marty ha qualcosa di visionario: l’azzardo di scommettere, cioè, su una nicchia che negli Usa, al tempo, è ancora presa poco sul serio (“davvero il ping pong è uno sport?” gli sentiamo velenosamente chiedere in uno dei tanti scambi del film).
Siamo infatti in una fase storica in cui i giocatori professionisti non vengono neppure riconosciuti dai principianti allo stesso tavolo, gli atleti della nazionale statunitense sono stipati in camerate di quart’ordine, gli sportivi, oltretutto, devono pagarsi in proprio i voli intercontinentali per le trasferte. Dal canto suo, Marty affina le proprie capacità, non spessissimo a dire il vero, in un buio sottoscala molto più simile a una bisca che alle palestre iperilluminate al led di oggi.

È, questo (assieme a certe zoomate convergenti sulle arene), uno degli aspetti che più avvicina la pellicola a The Smashing Machine, un film dove si capisce bene come il Giappone, proprio come qui accade per il tennis tavolo, avesse intuito per tempo e prima degli avversari mondiali la potenzialità intrattenitrice (oggi a tutti evidente e resa anzi show business) delle arti marziali.
Marty, malgrado indossi con savoir faire completi a righe e ostenti suite al Ritz che in realtà non può permettersi, proviene poi da una famiglia povera. Vive in una casa dissestata con una madre (interpretata da Fran Drescher) che cerca disperatamente l’attenzione di un figlio che, però, non contempla altri che sé stesso (buffo che a interpretarla sia un’attrice anche famosa per “La Tata”).
La stessa relazione, al fondo, il giovane intrattiene con l’amante Rachel Mizler, una ragazza incastrata in un matrimonio infelice, colpevole, secondo il ragazzo, di non possedere “una vera missione” nella vita.
Più che l’effettiva passione per il ping pong, ad animare Marty c’è in effetti il desiderio che le persone assistano finalmente al suo talento, o meglio, gli interessa essere visto, forse adorato. (Molto si dirà, in proposito, delle corse frenetiche che fendono il film senza requie, ma le traiettorie più significative sono forse quelle che Safdie, tramite una messa in scena a tratti millimetrica seppure nella concitazione, riesce a concertare tra gli sguardi.) E sotto questo aspetto, più di altri film analoghi come Whiplash dove un talento fulgido è al servizio di un’ossessione: il film è interessante proprio per la brutalità con cui Safdie mette a fuoco i contorni reali dei desideri del protagonista, specie quando questi decisamente trascendono lo sport e si fanno esibizionismo.
Per aderire alle sue mire Marty appare in effetti pronto a tutto: e per giunta è bravissimo sia a vendere che a svendersi.
Non è casuale, a riguardo, la scelta controintuitiva di una colonna sonora tutta giocata su suoni o hit di un decennio come gli anni Ottanta (tornano in più momenti i “Tears for Fears”): una frizione che permette a Safdie di ricreare il proprio tempo dentro agli anni Cinquanta e di trovare, così, una temperatura di fusione tanto unica quanto frenetica.
Il regista in un’intervista ha ammesso essere stato questo il punto di scaturigine dell’opera ancora prima della stesura del soggetto col solito Ronald Bronstein, assieme ad alcuni filmati sulla preistoria del ping pong da cui si sentiva magneticamente attratto. Un mondo che, prima di mettere in scena, il regista ha abitato sperimentando la new wave come sottofondo inedito di partite vintage.
“Più che l’effettiva passione per il ping pong, ad animare Marty c’è in effetti il desiderio che le persone assistano finalmente al suo talento, o meglio, gli interessa essere visto, forse adorato”.
Marty, nell’attesa certa di divenire grande, per sbarcare il lunario lavora malvolentieri nel negozio di scarpe dello zio (eppure è il più bravo coi clienti) ed ha persino convinto, col carisma affabulatorio che gli è proprio, un’intera famiglia a investire sul brevetto di una pallina arancione a suo nome: il tutto, vale la pena ricordarlo, in un Paese che non sa neppure bene in cosa il ping pong consista.
Lo stesso gli riesce da sportivo. Mauser manipola gli incontri in cui ha già vinto per mandare il pubblico in visibilio con colpi coreografati ad arte per il gusto dello spettacolo e così fa con i giornalisti a cui offre un passato falso a favore di titolo con tanto di battute calibrate con calcolo e ben al di là del provocatorio (“Farò con Kletzki quello che non ha fatto Auschwitz”. Salvo aggiungere: “Posso dirlo perché anche io sono ebreo”. E con sovrappiù di vezzi da editor: “Questa mettila sotto la foto”).
Quando però il mondo non è allineato al suo disegno, quasi fosse un atto dovuto, Marty sprofonda nella disperazione cosmica di un bambino capriccioso. Timothée Chalamet è fenomenale in questi frangenti a restituircene il volto sgomento con la mascella incastrata come dentro un ingranaggio.
E d’altra parte sono inceppi che durano poco più di un momento e che servono solo da abbrivio alla farsa successiva (Mauser, con i suoi baffi e i rayban clubmaster è prima una maschera, poi un atleta. Il trucco a cui Chalamet è sottoposto, punteggiato di accorgimenti orientati come il monociglio e la pelle butterata, contribuiscono ad acuire gli spigoli di questo pervicace teppista).

Notevole, poi, è soprattutto lo scontro culturale che va in scena nelle competizioni mondiali. Quello tra la compostezza serafica degli atleti nipponici e le smanie teatrali degli statunitensi. Marty, da questo punto di vista, è davvero un antenato di John McEnroe che, non per caso, trovava il suo contraltare ideale in un tennista all’apparenza algido come Borg.
Entrambi per vincere hanno bisogno di creare il caos attorno a loro, di contornarsi di nemici, di ridursi allo stremo: lo aveva colto bene in un documentario sul tennista girato da Julie Faraut che, per dilatazione esasperata dei tempi di inquadratura, era invece all’opposto di questo film. Ed entrambi gli atleti, poi, sono allo stesso tempo mossi da un inconsolabile quanto spudoratamente esibito desiderio di trovarsi al centro dell’agone.
Anche questo conflitto tra Oriente e Occidente, a ben guardare, già emergeva, non senza esiti grotteschi, in una delle scene più belle di The Smashing Machine: quella in cui un minuto giornalista giapponese riusciva, per via d’una sola domanda ben assestata, a polverizzare la granitica autostima di The Rock – assieme a tutta la sua certezza incrollabile di vincere il match.
Nel corso della trasferta a Londra per i mondiali – dove Marty perde in maniera bruciante con il giapponese Endo – il protagonista abborda Rockwell, facoltoso imprenditore di cui Martin ha in precedenza sedotto la moglie, ex diva del cinema ormai in disarmo interpretata da Gwyneth Paltrow (un personaggio che, come gli altri femminili di questo film, meritava forse maggiore attenzione in fase di scrittura).
Martin fiuta nel miliardario la possibilità per lui di ottenere lo sponsor ma quando Rockwell si convince a finanziare un reenactment della finale in Giappone, certo per aprirsi al fiorente mercato asiatico, il magnate gli fa presente che dovrà però inscenare una sconfitta ulteriore col neocampione, così da accontentare il pubblico di casa.
L’atleta è quindi punto nel vivo e la sua replica all’istante compromette il sodalizio: “Fai i soldi con il Paese che ha ucciso tuo figlio”. È quella con l’imprenditore, molto più che col campione giapponese, la vera rivalità del film. La partita decisiva non si gioca al tavolo da ping pong.
In questa natura bifida, più di tutto, consiste l’interesse del personaggio: l’incapacità quasi cronica di Marty di avere rapporti autentici è il suo difetto intrinseco e, allo stesso tempo, la ragione che lo condanna alla solitudine è proprio la schiettezza cruda con cui avanza le sue pretese.
La sua, di fatto, è un’epopea rovesciata e Safdie, per più di due ore di film, ci fa stare in compagnia con un essere umano poco meno che detestabile, privo di scrupoli, in grado di concepire rapporti al più strumentali con le persone che lo contornano. Dalla sua condizione Mauser ha ereditato l’incapacità costitutiva di ogni compromesso borghese.
Sempre per ragioni alimentari, Marty parte con Kletzki (uno dei pochi amici nel circuito) in tour mondiale in apertura degli Harlem Globetrotters prestandosi a mesti “numeri da circo” (in uno di questi lo vediamo, vestito di raso, scambiare a ping pong con una foca tra le risa umilianti dei cestisti). È il turning point che gli fa capire come tutto debba cambiare.
Al ritorno, nonostante una relazione compromessa con la madre, Marty le porta in dono un pezzetto di Piramide sottratta durante una trasferta a Il Cairo: “le abbiamo costruite noi”, le dice, un attimo prima di rintanarsi in camera, una stanzetta spoglia adornata solo da alcuni trofei. Una frase solo all’apparenza in linea con l’arroganza del personaggio e in cui paiono riverberarsi i noti versi da Brecht dedicati al proletariato cancellato dalla storia: “Dopotutto, i faraoni non costruirono le piramidi da soli, no?”.
Una battuta, che nel prosieguo del film, viene ulteriormente illuminata nello scontro con Rockwell, che nel momento di massimo alterco con Marty, si autodefinisce “un vampiro che esiste dal 1601”. Un vampiro, precisa il miliardario, che sopravvive da duecento anni poiché ha continuato a prosperare “succhiando sangue” laddove le vittime della Storia sono rimaste inermi.
Da qui in poi la trama subisce, se mai fosse possibile, un’accelerata ulteriore. Com’è tipico del cinema dei fratelli Safdie l’espediente per imprimere l’incremento di velocità al racconto (si ricorderanno i due giorni di Good Time, titolo ossimorico se ve n’è uno) è la fretta ansiosa causata da una quest per cui il tempo non è mai abbastanza. Dalla pista principale, poi, ne raggiano altre che fanno dimenticare, per più di un momento, le ragioni iniziali per cui si è cominciato a correre: in questo il cinema dei Safdie ricorda, in qualche misura, i modi di frammentare i generi della Nouvelle Vague.
Naufragato l’accordo con Rockwell, Marty deve procacciarsi i soldi per riuscire a partecipare ai prossimi mondiali a Tokyo (oltretutto è stato multato per la sua condotta dalla Federazione Usa) e gli effetti di ogni rimbalzo si fanno via via sempre più imprevedibili.
Se le corse di Marty tagliano il film in orizzontale, la trama fa invece avanzare il protagonista in discesa verticale, e cioè ad avere a che fare con: un bifolco armato del New Jersey, un marito tradito, una torma di ragazzi decisi a picchiarlo, gangster ebrei (un convincente Abel Ferrara col viso però scabro dell’italoamericano) e un amico tassista (Wally), interpretato da un bravissimo Tyler the Creator, del resto già tempratosi nei videoclip coi suoi molteplici alter-ego, in un cameo à la Jarmusch cui i Safdie ci avevano abituati (si ricorderà quello di The Weeknd in Uncut Gems).
È questa una capacità di Safdie che già si era intuita nel film precedente con i gioiellieri della Diamond street e non smette di stupire: il dischiudere un mondo sconosciuto che, seppure intravisto per un attimo, ci appare percorribile solo a ritmi frenetici.

Proprio in coppia con Tyler, Chalamet ha una delle sequenze più belle del film: l’estasi condivisa per una truffa riuscita con i due amici che, dopo aver contato satolli i soldi guadagnati, conducono a mano il taxi in panne per fare il pieno di benzina. La camera ce li mostra al colmo dell’euforia in un’alternanza di campo in cui fanno a gara di felicità saltando nonostante l’ingombro dell’auto.
L’altra, da questa completamente diversa, appartiene a Kletzki. L’atleta ebreo polacco – nel mezzo di una cena al Ritz di Londra – racconta di quando, durante gli anni a Birkenau, si cosparse il corpo di miele (tratto da un alveare trovato fortuitamente in un bosco) per offrirne il nutrimento ai suoi compagni di prigionia: la scena ci fa vedere il petto di Kletzki che viene leccato famelicamente da più uomini in penombra, a cui lui si immola come un martire.
La riuscita plastica di questo aneddoto surreale che viene messo in scena in contemporanea col racconto (operazione tutt’altro che semplice) dimostra il talento icastico di Safdie stavolta alle prese con un momento che più che sull’effetto sorpresa dell’ennesimo rivolgimento rapinoso, scommette, invece, sulla forza dell’immagine.
“‘Marty Supreme’ all’apparenza inscena un’ascesa sportiva vulnerante che, di volta in volta, assume la concitazione da gangsta movie o il nervosismo febbrile del noir: generi da cui attinge consapevolmente gli stereotipi per farli propri al doppio della velocità”.
E d’altronde i momenti più intensi della pellicola, come se lo spasmo perpetuo servisse in fondo all’estasi del rilascio, avvengono proprio quando il ritmo, dopo aver battuto senza pausa, inaspettatamente si arresta prima del culmine: quasi un respiro dopo l’apnea soffocante.
L’inquadratura più rilevante dell’opera – ha dichiarato Safdie – è quella per lui in cui in un momento di raccordo narrativo Marty sta tornando da una trasferta e lo vediamo curvo e assorto scrutare un punto indistinto oltre il finestrino. È una delle rare sequenze in cui questo teppista sprezzante, questo scaltro furetto che abbiamo spiato sgusciare da una porta all’altra senza freni morali o riguardi per il prossimo – ci confessa il cineasta – culla forse il timore di “non potercela fare”.
Il talento di Safdie, come accade forse non per caso a certi artisti nell’elettronica, è consistito soprattutto in questo: nel riuscire, cioè, a concertare una cornice di ritmo perpetuo che nel turbinio delle sponde, rende più rilevanti i momenti morti, enfatizzandone la potenza e, dunque, arricchendo il senso. Davvero un crescendo di tensione perpetua che, nel momento del rilascio, commuove quasi senza che si abbia il tempo per accorgersene – e spesso per il sentimento di sconsolata solitudine che ingenera in chi vi assiste.
Così come a contare, nel finale anticlimatico del film, più dei punti dove convulsamente schizza la pallina, è quando la sfera, a differenza di ciò che paventava il nemico-Rockwell, infine si ferma. E diventa altro.