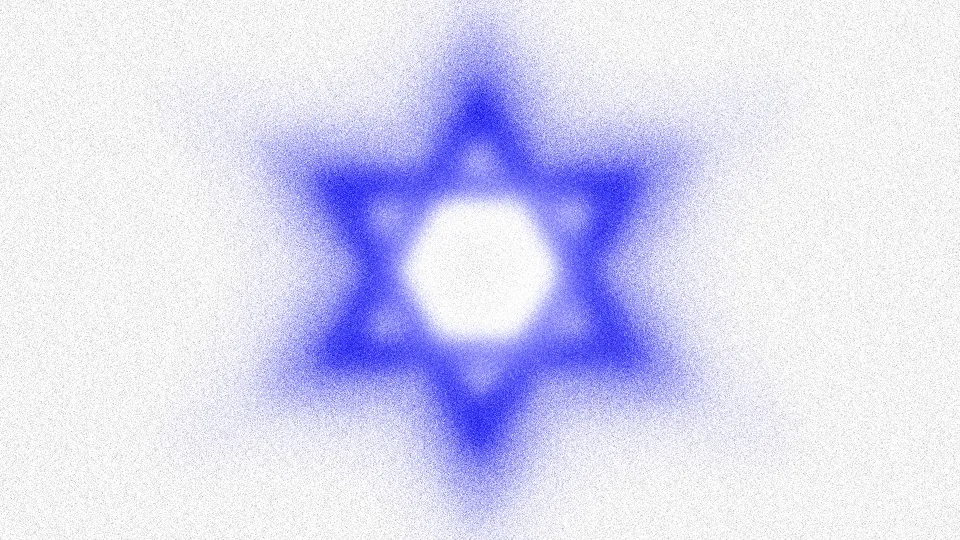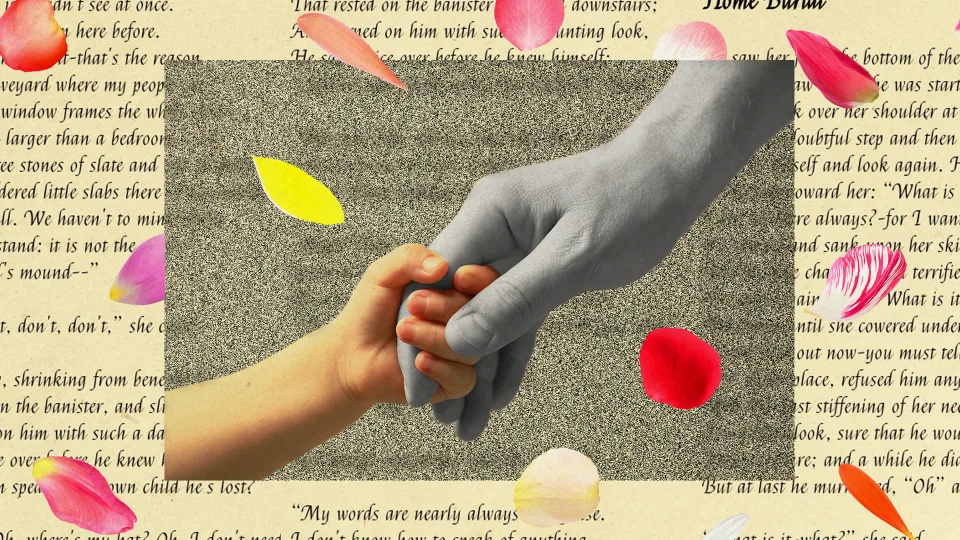L’amore per gli archivi, l’importanza delle inchieste, il mandato sociale dell’arte che non deve essere mai fine a se stessa. E l’incontro con Goffredo Fofi, “la più grande fortuna della mia vita”. Un dialogo con il regista di "Duse", in questi giorni al cinema.
A un certo punto di Duse, il bel film di Pietro Marcello in questi giorni al cinema, c’è una scena che riassume efficacemente il rapporto viscerale ma caotico, sempre un po’ improvvisato, diciamo infantile, che hanno gli italiani con l’arte. La compagnia di Eleonora Duse è a cena, a festeggiare una prima molto applaudita, quando arriva, ammutolendo tutti, Sarah Bernhardt, che era nel pubblico. In quel momento storico (siamo tra il 1917 e l’inizio degli anni Venti), Duse e Bernhardt sono da tempo le più grandi attrici d’Europa, forse del mondo: se l’una è chiamata “la divina”, l’altra è “la voce d’oro” (e, spesso, “la divina” pure lei: c’è da dire che “la divina” è un soprannome molto banale). Insomma, in questa scena le due divine, l’italiana e la francese, si parlano, si annusano, si fanno reciproci complimenti, finché Bernhardt sgancia la bomba: lo spettacolo non è male, di sicuro ben recitato, ma vecchio, poco engagé. Come fa Eleonora Duse, si chiede Bernhardt, a non rendersi conto della propria influenza, del proprio potere mediatico?; come può non voler fare qualcosa per l’Italia, attraverso il teatro?
Gli altri ci restano male, borbottano, qualcuno si indigna. Duse, invece, ci riflette per qualche giorno e poi dice: “Sarah ha ragione”. Così accantona lo spettacolo che la compagnia sta già mettendo in scena, con successo, e annuncia di voler puntare su qualcosa di sperimentale, più politico, più giovane, più “urgente”; proprio come fa Bernhardt, proprio come fanno i francesi. Il risultato sarà un disastro: fischiato dal pubblico, stroncato dalla critica, deriso dietro le quinte. Ne uscirà indenne soltanto lei, la divina Duse, ancora una volta dimostratasi più luminosa di tutto ciò che la circonda (ovvero, per estensione: l’Italia, gli italiani).
Dopo aver visto il film alla Mostra del Cinema di Venezia, dov’era in concorso per il Leone d’Oro, ho ripensato a lungo a questa scena, o meglio a questa serie di scene, chiedendomi cosa mi avesse ricordato. La risposta, arrivata solo adesso, è Boris, la serie: come Boris, il pasticcio innescato da Sarah Bernhardt in Duse sembra voler ricordare che l’Italia è il Paese delle cose fatte di pancia e mai di testa, soprattutto quando si parla di cultura. È così? Il nostro amore per l’arte è davvero tanto ingenuo, confuso, masochistico? E se sì, perché oggi questa ingenuità sembra essersi radicalizzata?
È la prima domanda che ho posto a Pietro Marcello durante la nostra chiacchierata, sul rumorosissimo terrazzo di un hotel di Milano. “Forse dipende da quanto è diventata centrale l’individualità”, mi ha risposto.
Cioè?
Dopo la Costituente c’è stato, per un po’, un clima di grandi speranze, quindi di grande dialogo. Poi ha iniziato a contare sempre di più il singolo, e questo per l’arte è un problema.
Perché?
Innanzitutto, perché l’artista non è mai una figura cristallina, non puoi mai vederlo per intero: ha tanti chiaroscuri, tante fragilità. E quindi, se parla solo di sé, la sua arte sarà sempre un po’ incompleta.
E poi?
E poi perché manca lo sguardo sugli altri. Si può raccontare il proprio mondo interiore, oppure affacciarsi alla finestra e descrivere ciò che si vede. Sono due strade legittime, ma io preferisco la seconda: guardare il mondo e interpretarlo, cercando di tenere a freno il più possibile il narcisismo. In tutto quello che facciamo finiamo per raccontare noi stessi, o almeno qualcosa di noi, ed è normale, ma bisogna saperlo fare con equilibrio.
E se gli altri sono artisti, come nel caso di Eleonora Duse? Come avete fatto a costruire non solo la storia, ma anche il carisma di un’attrice di cui si è perso quasi tutto, persino il modo di recitare?
È che io non credo nel biopic. Quindi non ho mai pensato di poter dire “la Duse era così”. Potevo solo provare a ricrearne lo spirito. Di lei restano lettere, libri, un film girato quando era già anziana, alcune fotografie… C’era anche una registrazione di Edison, ma è andata perduta. E poi c’è quello che sormonta i documenti e i reperti, cioè la sua fama, la sua reputazione. Eleonora Duse è un mito che nel tempo ha assunto forme diverse. Ha influenzato profondamente il teatro moderno: Strasberg, Stanislavskij e altri la consideravano un modello. Senza contare che era una donna in un mondo dominato dagli uomini: per riuscire a imporsi doveva essere di una bravura enorme. E lo era. Ardeva di talento come il fuoco.
Ho letto che per il ruolo hai pensato da subito a Valeria Bruni Tedeschi.
Fin dal soggetto, sì.
Perché?
Perché Valeria è una grande attrice, ma è anche un’ottima regista, molto sensibile. E poi… [Ci pensa] In un certo senso, credo di aver pensato a lei perché nella vita si piange e si ride. E nel restituire questa cosa, Valeria è bravissima. Abbiamo lavorato in stato di grazia.
“È fondamentale saper dire di no, essere controcorrente. Questo accomuna Martin Eden, la Duse, i protagonisti dei miei altri film.”
I tuoi ultimi tre film sono in costume, e due di questi tre – Martin Eden e Le vele scarlatte – sono tratti da libri. Come si fa a essere innovativi parlando del passato, o riprendendo storie che già conosciamo?
Mantenendo lo sguardo sugli altri di cui parlavo prima. Stando “fra la gente”, come Gork’ij. Tutti i miei film hanno questo filo rosso: sono film su personaggi rivoltosi, capaci di dire no, di andare sempre contro, anche contro il proprio tempo. E questo li rende immortali. Nel caso di Martin Eden, è bastato concentrarsi sul cuore del libro, che poi è un libro ambiguo: chi è davvero Martin? Qual è il suo archetipo? È un buono, è un cattivo? A pensarci bene, è una figura tanto individualista da essere quasi negativa. Lo stesso Jack London non pensava certo di proporla come modello positivo. Ecco, a me interessava quello, l’archetipo. Il resto era malleabile. Per esempio, insieme a Maurizio Braucci, che ha scritto con me la sceneggiatura, abbiamo trasposto la storia da San Francisco alla Campania, dove sono cresciuto, perché una vicenda come quella funziona ovunque, in America come a Cosenza o a Marsiglia. Un altro cambiamento è che nel romanzo Martin tradisce la lotta di classe, mentre il mio Martin tradisce la propria classe di appartenenza.
Perché?
Perché non c’è più, la lotta di classe. L’unica cosa che mi ha emozionato nelle ultime settimane è la protesta dei portuali di Genova, che hanno bloccato gli imbarchi per impedire il traffico di armi. Dicono: “Da qui non passa uno spillo”. Quella è disobbedienza civile, ed è una cosa che mi dà speranza.
Dicevi che i tuoi personaggi sono tutti ribelli. Il più delle volte, lo sono in nome della cultura. Oggi si può esserlo ancora? La cultura può essere una fede così solida?
Dipende dalla formazione. I bambini sono tutti uguali: diventano diversi in base a come li educhiamo. Io mi sono formato con l’inchiesta, da ragazzo ne ho fatte tante. Oggi viviamo in una società arida, senza altruismo. Siamo immersi nell’ignavia, che, aveva ragione Dante, è una cosa così brutta che non la vogliono nemmeno all’inferno. Eppure è fondamentale saper dire di no, essere controcorrente. Questo accomuna Martin Eden, la Duse, i protagonisti dei miei altri film. Il fatto di sapere che ciò che ci arricchisce è la diversità. La forza di dire “Io non voglio essere come voi”.
A proposito di dire no, un tema del film è anche il rapporto tra arte e potere. A un certo punto, il mondo alato e puramente intellettuale di Eleonora Duse incontra quello del fascismo. L’attrice, in un momento di gravi ristrettezze, viene convocata da Mussolini, che le offre un vitalizio. E lei deve decidere se accettare. Cosa è “giusto” per un artista? Quando e come deve essere politico?
Mettiamola così: a volte siamo costretti a vendere il culo, ma l’anima non va mai venduta. Nel film, parallelamente alla storia di finzione su Eleonora Duse, ci sono dei filmati d’archivio sul viaggio e sul corteo funebre del Milite Ignoto. Quindi, da una parte c’è la Duse che va incontro al suo destino, dall’altra il treno con il corpo del soldato che attraversa l’Italia. Nell’immagine delle persone che si inchinano al suo passaggio, per me c’è tutto il dolore del mondo. Il Milite Ignoto nasce come critica agli alti comandi, a Cadorna, a quel laboratorio criminale che è stata la Grande Guerra: era una risposta al bisogno delle madri di piangere i figli caduti. E il fascismo che fa? Se ne appropria, trasformandolo nell’opposto, cioè in un simbolo di guerra. Per giustificare la campagna d’Africa, sostanzialmente. E questa è una mistificazione. Lo stesso tentativo è stato fatto con la Duse e con tanti artisti. Lei però non accetta vitalizi né favori politici, né da Giolitti né da Mussolini. Se ne va dall’Italia, si trasferisce a Pittsburgh, dove morirà, coerente con se stessa.
D’Annunzio, invece?
D’Annunzio, invece, si fa riempire di onori e ricchezze, e così il suo lascito diventa l’estetica del fascismo. È lui il vero impagliato dal fascismo. È stato un grande poeta, ma di lui quello che si finisce per raccontare è sempre la dissoluzione.
Hai citato gli spezzoni d’archivio sul Milite Ignoto. Che rapporto hai, con gli archivi?
Io ho imparato a fare tutto, il produttore, il montatore, il direttore della fotografia… Ma sarò sempre affascinato dalla potenza dell’archivio. L’archivio per me è qualcosa che sta al di sopra di qualsiasi finzione.
Perché?
Perché non posso riprodurre quel tipo di forza con la finzione, la ricostruzione non ha lo stesso valore. È un po’ come la bellezza. Che cos’è la vera bellezza, in fondo? È l’anima delle cose, l’origine, uno sguardo sul creato. Quando ho visto per la prima volta il materiale sul Milite Ignoto mi sono emozionato. Erano anni che non mi emozionavo così tanto.
È questa la tua principale urgenza, come regista? Questa cosa che sta a metà fra la responsabilità della testimonianza e l’ansia per l’oblio?
Non lo so. Ma so che il cinema fine a se stesso non mi appaga più. Se non diventa strumento di educazione, di emancipazione, rischia di essere sterile. In questo momento mi interessa di più dedicarmi ai giovani, creare scuole, lavorare con loro. Faccio il regista, sì, ma perché dovrei sentirmi superiore a un maestro elementare? Spesso nel cinema ci prendiamo troppe arie. Invece, in una società così arida, io credo che venga prima l’umano del creativo. L’arte per l’arte non mi interessa, zero. Naturalmente resto “morso” dal cinema, perché è quello che ho imparato a fare, quello che sognavo da bambino. Ma ciascuno di noi ha bisogno di evolversi: se ti fermi, si ferma anche il mondo intorno a te.
“Mi emoziona la protesta dei portuali di Genova, che hanno bloccato gli imbarchi per impedire il traffico di armi. Quella è disobbedienza civile, ed è una cosa che mi dà speranza.”
C’è un’immagine o una scena che avresti voluto inserire e non hai fatto?
No, anche se mi piacerebbe rimontare tutti i miei film. Porto con me molte immagini e idee che a volte non trovano posto. Col tempo si cambia: a vent’anni avevo tenacia e incoscienza, oggi ho esperienza ma meno resistenza. Bisogna trovare ogni volta un nuovo equilibrio.
E un progetto sospeso?
Non c’entra niente, o forse sì, ma io avevo lavorato a lungo anche su un film su Carlo Pisacane, un personaggio che mi affascina molto. Però questo film non lo farò mai, probabilmente, perché Pisacane è un vinto della Storia, mentre quello che interessa davvero alla Storia sono i vincitori.
Magari alla Storia, ma al cinema no.
Infatti. Ecco perché della Duse ci ho tenuto a raccontare soprattutto gli ultimi anni, non l’ascesa. Quella fase in cui una figura ottocentesca viene travolta da un nuovo secolo e da una guerra che, iniziata nel 1914, in un certo senso non si è mai conclusa. La Duse era già un personaggio del passato, e lo sapeva.
Ma cercava la modernità.
Esatto. E questo contrasto mi pareva fondamentale da raccontare.
Ha avuto ragione lei, visto che, come dicevi, è diventata un modello per il teatro del futuro.
Viveva in un mondo vecchio, quello del teatro italiano, mentre altrove, per esempio a Parigi, la cultura era più avanti. L’Italia era un Paese appena nato, con tradizioni teatrali frammentate e arretrate. Ma la Duse riuscì comunque a trasformarlo, diventando un punto di riferimento per quelli che sono venuti dopo.
Cosa significa essere moderni, oggi? Cosa deve fare un artista per esserlo?
Conoscere il passato. E conoscere l’arte, per poterla tradire. In fondo, per creare servono tre cose: un po’ di questa conoscenza, la necessità del fare e un’idea di progetto.
La più importante fra queste tre cose?
La necessità. È fondamentale, è ciò che dà senso all’azione.
Finora mi hai parlato spesso di contrasti: fra passato e modernità, fra testimonianza e oblio, fra realtà e rappresentazione, fra classi. Questa passione per il contrasto è una cosa molto evidente, nei tuoi film, sorretta anche da scelte estetiche: incongruenze cronologiche nei costumi e nelle scenografie, l’alternanza di musica classica ed elettronica…
Qui la musica classica è di Malipiero, la musica elettronica di Marco Messina, che ha lavorato a tutti i miei film. Mi piace questa mistura, quest’idea di contaminare: la parte classica dà profondità spirituale, quella elettronica introduce una dimensione fantastica.
Un altro contrasto apparente è nel finale. Perché un film così centrato sul volto e sull’interpretazione di Valeria Bruni Tedeschi si chiude invece con un sorriso di Noémie Merlant, che interpreta Enrichetta, la figlia di Eleonora Duse?
Perché Enrichetta rappresenta il futuro. Nell’ultima scena sorride per la prima volta, ed è come assistere a una liberazione. È il nuovo mondo che avanza, il dopo-Duse.
Ci sono contrasti anche fra i tuoi film, oltre che nei tuoi film?
Be’, Martin Eden era un film molto più pop, molto più spinto. Duse è un melodramma. Non a caso ho voluto, in alcuni punti, un’interpretazione che sfiora l’overacting: per fare un melodramma appassionato, come quelli che l’Italia ha inventato e che gli americani hanno poi ereditato.
Come si fa, in questi casi, a evitare il patetismo?
Non si deve necessariamente evitare. Il film racconta un momento storico complesso, con personaggi decadenti che a volte, sì, possono sembrare patetici. Ma il patetismo non è sempre un difetto, è una rappresentazione dell’umano.
Tu hai lavorato molto in Francia. Che differenze ci sono, nel modo di accogliere e incoraggiare il cinema d’autore fra Francia e Italia?
Credo ci sia una continuità culturale tra i popoli europei, e nel caso della Francia e dell’Italia coincide con la continuità territoriale. Il nostro neorealismo nasce dalla guerra, così come il Fronte Popolare in Francia. Se lì non ci fosse stato il Fronte Popolare, qui non ci sarebbe stato il neorealismo, forse. Poi, certo, loro hanno avuto una rivoluzione, e questo fa la differenza, ma in generale credo che il cinema francese e il nostro cinema appartengano alla stessa famiglia, che è quella della cultura europea. Ci capiamo, ci siamo sempre influenzati a vicenda. Ma anche con i russi. Per esempio il cinema russo che ho potuto studiare è molto vicino a noi, e non meno di quello americano: possiamo immaginare una Grande Europa che va da Lisbona agli Urali, lo pensava Bakunin ma anche De Gaulle e tanti altri.
“Il cinema fine a se stesso non mi appaga più. Se non diventa strumento di educazione, di emancipazione, rischia di essere sterile.”
Come si forma un regista?
Quello che ho letto e visto fra i venti e i trent’anni è stato fondamentale. Non ho mai fatto scuole di cinema: ho imparato guardando i film e leggendo i libri. Vedevo come lavoravano autori come Nuto Revelli o Danilo Montaldi, da cui ho imparato un metodo. A loro devo l’amore per le inchieste, che per me è tuttora il punto di partenza di ogni cosa. È iniziato tutto da lì.
Al di là dei tuoi riferimenti letterari e cinematografici, chi sono stati i tuoi maestri reali, quelli della vita vera?
Non è che ne abbia avuto molti. Uno solo, ma fondamentale: Goffredo Fofi. Mi ha educato alla conoscenza e ha riparato la mia totale incultura. Sono scappato di casa a quindici anni, da ragazzo ero un pochino ribelle. Facevo i traslochi, il falegname, il muratore, e tanti altri mestieri per campare. Imparare a imparare da soli era la sola radicalità.
Poi?
Poi ho incontrato Goffredo. E incontrarlo, per me e per altri ha rappresentato una speranza, di poter studiare e guardare il mondo da altre angolazioni, di essere educati ad avere un punto di vista concreto sul mondo che ci circonda. E se sono qui a parlare con te, oggi, è perché lui mi ha dato gli strumenti per arrivarci. [Fa una lunga pausa pensierosa, guarda a terra] Scusa, è che quando parlo di Goffredo sono ancora un po’…
Se vuoi parliamo d’altro.
Ma no, figurati. Sai, l’ho conosciuto che avevo vent’anni, ora ne ho quasi cinquanta. È stato più di un educatore, per me: è stato come un padre, e il privilegio di averlo incontrato e di averlo avuto così vicino per trent’anni è forse la fortuna più grande della mia vita. Un vero maestro.
Che maestro è stato?
Severissimo. Ma anche estremamente generoso, quando ci credeva. A volte ha creato falsi miti, ma chi è che non lo fa? Era cresciuto nell’epoca delle grandi speranze, ma con le nevrosi della guerra. E ha attraversato l’Italia e tutto il Novecento. Ora stiamo realizzando un film su di lui, siamo in tanti di noi a lavorarci, un vero film collettivo. E aprendo le sue carte sono tutti lì: Fortini, Sereni, Morante, Bobbio, Carlo Levi, Capitini, Buñuel… Vabbè, non sto lì a farti l’elenco, ne ha conosciuti troppi, li ha conosciuti tutti. E a noi che apparteniamo a un’epoca intermedia, e non quella delle grandi speranze, con tutta la passione e l’impegno che mettiamo in questi anni nel creare libri o film, confrontarci con le sue carte e con le epoche che Goffredo ha attraversato ci fa sentire veramente piccoli piccoli piccoli.
“Goffredo Fofi è stato più di un educatore, per me: è stato come un padre, e il privilegio di averlo incontrato e di averlo avuto così vicino per trent’anni è forse la fortuna più grande della mia vita.”
Cosa credi che gli debba, la cultura italiana contemporanea?
L’industria culturale non l’ha mai accettato veramente, perché rompeva gli schemi e diceva quello che pensava. Era un uomo profondamente libero, amava Camus e lo ricordava spesso: “Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no”. Goffredo ha campato del suo lavoro fino alla fine dei suoi giorni, non ha mai ricevuto nessuna pensione e ha rifiutato orgogliosamente la Bacchelli. Ci hanno provato in tanti a convincerlo, ma diciamo che ha preso in giro un po’ tutti. Non ha mai accettato incarichi istituzionali, figuriamoci la Bacchelli! Ora sono in molti a celebrare la sua memoria, anche se Goffredo non amava le celebrazioni, e tra questi che lo ricordano anche molti che lo hanno odiato in vita, proprio perché Goffredo era un uomo libero e diceva quello che pensava, e spesso anche perché le suonava di brutto a molti di loro: ai conformisti, ai narcisisti e a tutti quei servitori di un’industria culturale miserabile e poco coraggiosa, agli ignavi del nostro tempo. Il suo vero desiderio era creare scuole popolari, educare nuove generazioni di giovani. Chi l’ha conosciuto lo sa. Educare, educare alla bellezza, a farne buon uso. Mi ricordo che una volta… [Si interrompe] Ma magari non ti interessa, sto divagando.
Mi interessa.
Va bene. Una volta eravamo insieme alle Cinque Terre, a Rio Maggiore. In un posto bellissimo. E Goffredo a un certo punto si agitò e mi disse: “Ce ne dobbiamo andare. Dobbiamo andare via da qui”. E io chiesi perché. Rispose: “È un posto troppo bello”. E ce ne andammo, diversi giorni prima del previsto.
Ti ha spiegato il perché?
No. E ci penso ancora oggi. Lo chiedo anche a te. Perché?
Forse per senso di sopraffazione. A me capita, di esserne innervosito. Ci sono dei posti che ti fanno pesare di più il fatto che sia tutto a scadenza, che tutto debba finire.
Sì, anche questo è vero. La natura è inquietante, perché è l’ombra dell’umanità. Ma in verità credo volesse dire che non possiamo abusare della bellezza. E non possiamo permettere che ci addormenti. Viviamo in un’epoca in cui edonismo e narcisismo prevalgono. Ma la bellezza non può essere nostra: va condivisa, capita, rispettata.
Invece la stiamo barbarizzando, la stiamo banalizzando.
Sì. Le città, le opere d’arte. Vogliamo goderne tutti, e il risultato è che le sciupiamo. Restano belle, ma perdono parte del loro valore, del loro significato. Ed è Goffredo che me l’ha fatto capire: non si può abusare della bellezza, non si può vivere solo comodamente. Bisogna avere uno sguardo critico, saper dire no, e trasmettere tutto questo agli altri.