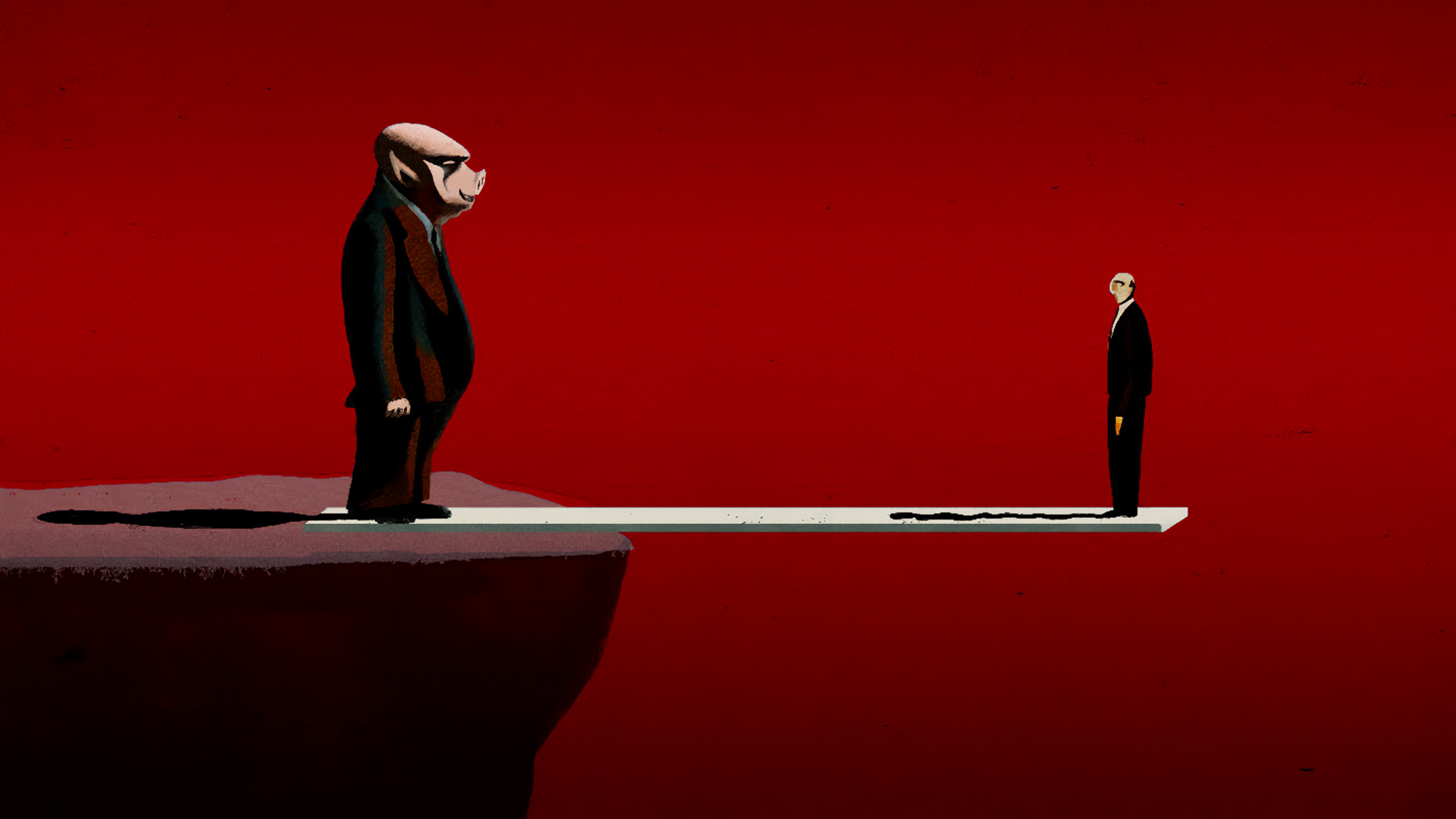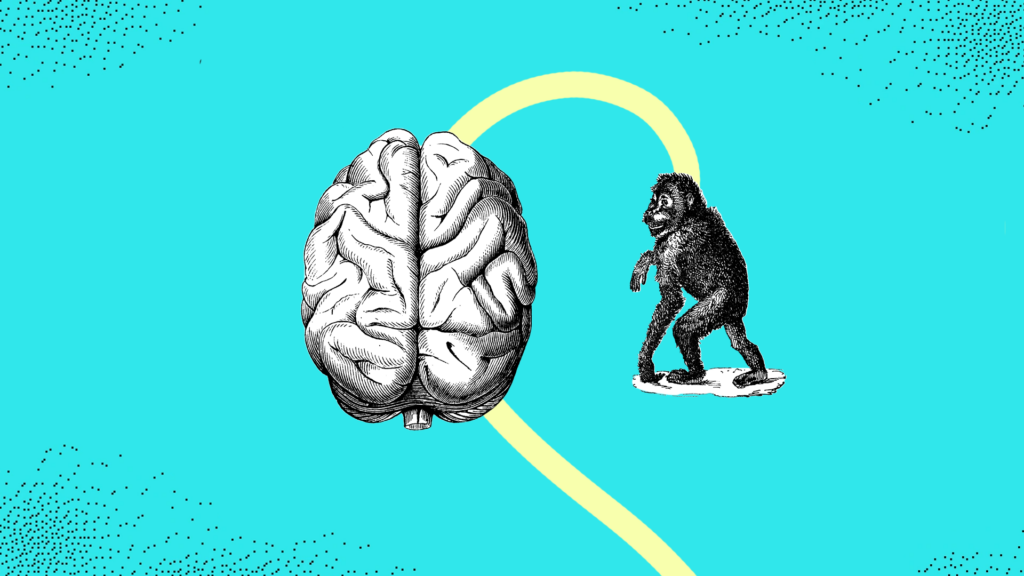Arnaldo Greco
Spazzolini, lassativi, Gratta e Vinci: tre storie di dipendenze insospettabili

08 Giugno 2023
Che cosa hanno in comune una siringa e uno spazzolino da denti? Alla scoperta di dipendenze poco comuni, per cercare di comprendere l'essenza stessa delle ossessioni.
Arnaldo Greco
Arnaldo Greco è giornalista e autore televisivo. Per Einaudi ha curato l’antologia “Aragoste, champagne, picnic e altre cose sopravvalutate”.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati