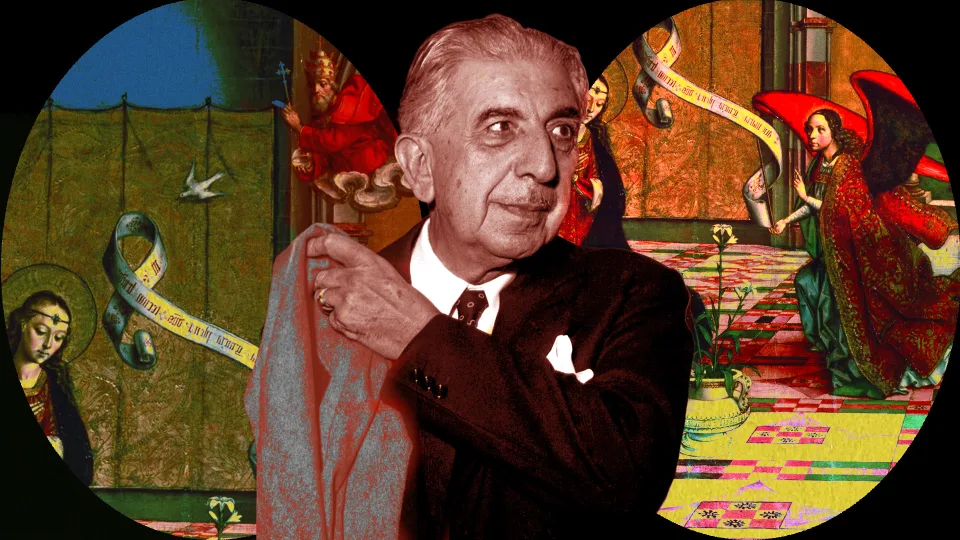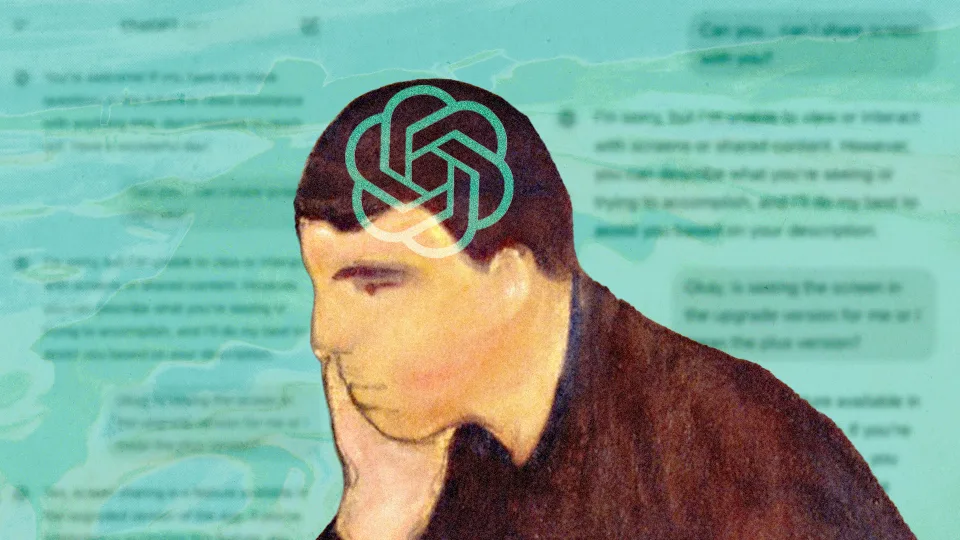Anche se oggi la critica culturale sembra meno centrale di un tempo, c’è chi la pratica in modo originale per svelare e riequilibrare rapporti di potere e dinamiche di consumo, per riflettere sulle idee sottese alle opere d’arte e per mettere alla prova le proprie opinioni e pregiudizi. Andrea Long Chu è, in questo senso, una delle voci più interessanti della critica e della saggistica contemporanea, come dimostra “Authority”, la sua ultima raccolta.
Come molti, la prima cosa che ho letto di Andrea Long Chu, fresca di Pulitzer per la critica, è stato Femmine (Nero, trad. Clara Ciccioni). Avevo comprato il librino su consiglio di non ricordo più chi, che mi aveva parlato di questa autrice che sosteneva che in realtà siamo tutti femmine. La persona in questione non si era addentrata nelle specifiche dell’affermazione, lasciandomi con la curiosità di capirne il senso. Trovai il libro folgorante. Long Chu, prendendo le mosse da Valerie Solanas, sostiene che l’essere femmina implichi sacrificare il proprio desiderio più profondo per lasciar spazio a qualcos’altro di alieno. In questo senso, siamo tutti femmine. Tutti odiamo questo stato delle cose, tutti cerchiamo di emanciparci dal nostro stato di femmina, eppure segretamente tutti desideriamo farvi ritorno. Di più: gli uomini (femmine) hanno costruito il patriarcato allo scopo di proiettare la propria passività sull’altro, la donna, sempre femmina. Ma in realtà tutti tendono al femminile, tutti vedono se stessi come femmine a livello erotico e sessuale. Se l’essere femmina consiste nel farsi oggetto del desiderio per qualcun altro, il genere femminile (la donna) è la realizzazione concreta di questa dinamica – basti pensare alla gravidanza. In On Liking Women Long Chu suggerisce poi che la transessualità non si basa sul sentirsi donna, ma sul desiderio di essere donna: “La funzione principale dell’identità di genere come concetto politico – e, sempre di più, giuridico – è mettere tra parentesi, se non negare del tutto, il ruolo del desiderio in quella cosa che chiamiamo “genere”. E ancora: “Dubito che ci siano donne trans che cominciano la transizione semplicemente perché vogliono essere donne, in senso astratto o teorico. Io no di certo. Io ho deciso di cominciare la transizione per i pettegolezzi e i complimenti, per il rossetto e il mascara, per piangere al cinema, per essere la ragazza di qualcuna, per lasciarle pagare il conto o portarmi le buste della spesa, per il maschilismo cortese degli impiegati di banca e gli antennisti, per l’intimi- tà telefonica dell’amicizia femminile a distanza, per rifarmi il trucco in bagno affiancata da una peccatrice a ogni lato come Cristo, per i sex toys, per sentirmi sexy, per essere corteggiata dalle butch, per quelle informazioni segrete su quali lesbiche temere e quali no, per Daisy Dukes, per i reggiseni dei bikini e per tutti i vestiti, e, oddio, per il seno. Ma ora avrete cominciato a capire qual è il problema con il desiderio: raramente vogliamo le cose che dovremmo volere”.
Unitamente a Femmine, ciò che Long Chu ha scritto sul genere come desiderio e sulle sue transizioni sono tra le cose più interessanti e sovversive che siano state scritte negli ultimi tempi, invasi come eravamo – ora sembra che il genere sia scomparso dai pensieri del mondo – da caroselli Instagram che riportavano frasi retoriche sull’inclusività e sui bagni separati. I suoi libri e interventi fecero arrabbiare tutti o quasi: trans, queer, terf, progressisti e conservatori. Una scelta curiosa per un’americana in un periodo in cui tutti mostravano una compiacenza di pensiero smaltata e noiosissima.
I suoi pamphlet provocatori mi sono tornati alla mente molte volte, e ora mi è difficile non vedere il mondo come popolato unicamente da femmine che lottano per liberarsi dalla responsabilità di essere soggetto del desiderio e non oggetto di quello di qualcun altro.
Nel corso del tempo Long Chu ha continuato a tornare su questi temi, raccontando per il «New York Times» anche della sua transizione e di cosa ha comportato – My New Vagina Won’t Make Me Happy. Poi, quando è stata assunta come critica culturale dal «New York Magazine», ha iniziato a scrivere meno di genere. Qui ha preso a recensire serie tv, spettacoli teatrali e romanzi, soprattutto i bestseller e osannati dalla critica: Hanya Yanagihara, Sally Rooney, Maggie Nelson e molti altri. I suoi pezzi, sferzanti e divertenti, svelano le pretenziosità di scrittori esordienti (acuto e splendido il suo pezzo su Ocean Vuong, che mi ha ridato speranza nella capacità del genere umano di discernere le pose dalla verità) e rileggono l’opera di alcuni autori attraverso dettagli curiosi, come quello in cui fonda la poetica di Moshfegh sulla merda, in effetti molto presente nei suoi romanzi.
Per questi lavori ha vinto il Premio Pulitzer per la critica, e ora molti dei suoi pezzi sono raccolti nel volumetto Authority edito in Italia sempre da Nero, nella collana Not, e tradotto sempre da Clara Ciccioni. Il libro è arricchito da due saggi inediti. Il primo si intitola La critica in crisi, dove Long Chu riflette sulla presunta crisi della critica – presunta perché lei cerca di dimostrare come, nonostante tutto, la critica vada avanti, indifferente ai certificati di morte, da secoli. Il secondo, Autorità (o meglio, Authority, si interroga invece sul concetto di autorità/autorevolezza, su cos’è che rende qualcuno autorevole o meno e perché, attraverso una lunga disamina storica. Sebbene entrambe le questioni poste siano interessanti, sembra qui che l’autrice perda il suo mordente e cada in una trappola che tende a se stessa. Sono pezzi eruditi, pieni di citazioni, spericolati nel passare da un’epoca all’altra, indice di una certa insicurezza dell’autrice, come se il suo acume qui non bastasse per dimostrare la sua ambiziosa tesi. Per dirla in altre parole: come se non bastasse la sua, di authority. Per chi si era innamorato dei suoi primi scritti, è più difficile scovare nei suoi lavori più recenti l’irriverenza, la libertà che infiammava Femmine. Eppure cercando bene la si trova ancora, nascosta tra le pieghe di un giudizio affilato o di una riflessione ardita. Ad ogni modo, è proprio in occasione dell’uscita di Authority che ho incontrato l’autrice a Milano, a giugno, e le ho posto alcune domande.
Vorrei iniziare dal titolo, “Authority”. “Autorità” in italiano indica la posizione di superiorità che legittima qualcuno a esercitare un potere su alcuni aspetti della vita di qualcun altro. C’è poi un altro termine, “autorevolezza”, che si discosta un pochino dal primo, e indica sì l’autorità, ma oserei dire “guadagnata” o “meritata”, ha un’accezione morale, di prestigio sociale. In inglese invece “authority” racchiude entrambi i significati. Mi chiedevo quindi come foste arrivate a lasciare il titolo originale e perché.
Dunque, a onor del vero non ne abbiamo parlato prima che fosse tradotto. Quindi è stata una decisione della casa editrice quella di lasciare “Authority” in inglese. Quando poi ci siamo viste con Clara [la traduttrice] mi ha spiegato questa sfumatura. Se mi chiedi quale significato sto usando, ti rispondo “tutti e due”. Per me è il concetto stesso di “autorità” a essere interessante, perché è difficile definirlo. Che cos’è la vera autorità? L’autorità di uno Stato? Quella del poliziotto all’angolo della strada? Voglio dire, cosa differenzia la vera autorità dalla più o meno velata minaccia di violenza? Ecco, io penso che l’autorità sia il comando senza l’uso della forza. Nel momento in cui costringi qualcuno a fare qualcosa con la forza, non è più autorità. Quando i tuoi genitori devono buttarti fuori di casa con le brutte perché tu non sia in ritardo a scuola, quello è un fallimento dell’autorità, no?
Questo per dire che è difficile definire esattamente che tipo di autorità sia quella di cui parlo, perché in effetti, nel saggio “Autorità” che dà il titolo al libro, il concetto viaggia dalla politica alla morale, fino all’estetica. È un concetto di difficile collocazione, e mai definitiva. E poi, anche se non sono certa che sia così anche in italiano, il termine “autorità” può essere attributo di una persona. E quindi mi faceva ridere immaginare il lettore che vedeva “autorità” e poi il mio nome. Ad ogni modo, non avevamo parlato del titolo per l’uscita in Italia, davo per scontato che sarebbe stato “Autorità”, e poi ho scoperto che invece l’avrebbero lasciato in inglese. Ma sono soddisfatta.
A un certo punto, nel saggio Authority, racconti che Cicerone disse che l’autorità risiedeva nel senato, mentre il potere nel popolo. Secondo te, traslando questa asserzione nel mondo editoriale, si potrebbe dire che il potere lo ha il pubblico che rende rilevante un libro comprandone tantissime copie e che l’autorità sia invece del critico che ha il compito di controbilanciare?
Domanda interessante. Non ci avevo pensato. Cicerone diceva questa cosa quando la Repubblica Romana era sull’orlo del collasso. Ma anche quando la Repubblica prosperava, l’idea che il potere lo avesse il popolo era un pochino utopica. Voglio dire, in fondo anche lì il potere era detenuto da un piccolo gruppo di persone. Ma seguendo il tuo ragionamento riguardo al gusto popolare e alla critica… Quando diciamo che un libro è un best seller, qualche volta lo intendiamo come complimento e qualche altra volta come un insulto, no? Cioè possiamo dire che le persone hanno scelto bene o male, ovvero che hanno aderito o meno al marketing di un brutto libro, che nessuno dovrebbe leggere eccetera eccetera. Il fatto però è che è difficile analizzare cosa succede nel momento in cui un libro viene letto. Cosa succede davvero, intendo. Le persone stanno realmente apprezzando un’opera d’arte o stanno cercando di far passare un viaggio in aereo il più velocemente possibile? Oppure ancora: stanno partecipando a un trend che gli è stato venduto da un’azienda? Ecco, nella tradizione critica si guarda al momento della lettura con grande sospetto, al punto che raramente se ne parla. La stessa cosa avviene nella politica, quando parliamo della volontà delle persone. Si dice che ciò che le persone desiderano coincide con ciò che le persone vogliono. Ma è davvero così? Di solito la critica dice di no, è diffidente della volontà del pubblico, come se le persone non sapessero davvero cosa vogliono. Ecco, io non so rispondere a queste domande enormi, ma nemmeno la critica negli anni ha saputo farlo. Ci si limita al testo, o si cerca di, perché giungere alla verità di ciò che accade nel momento della lettura è troppo difficile.
Ho un’altra domanda direttamente collegata a questa. L’autorevolezza del critico si esprime anche nel momento in cui sceglie l’oggetto della sua critica. Anzi, spesso l’autorevolezza dello scrittore riflette quella del critico che lo elegge a oggetto e viceversa. In questo senso quando tu scegli un libro da criticare in realtà lo stai comunque elevando, perché gli dai valore. Voglio dire, tu non critichi Colleen Hoover, tu critichi Hanya Yanagihara, che certo, ha venduto molte copie, ma è anche considerata “letteraria”. Quindi già l’atto di scegliere sottende il valore che tu stai dando a un libro.
Verissimo. Tra l’altro io e la mia editor abbiamo discusso di Hoover. La trovo intrigante. Mi divertirebbe scriverne prima o poi.
Ah sì, io l’ho letta.
Davvero? Quale?
It ends with us.
Per il film?
No, perché cerco di leggere sempre chi è primo in classifica.
È un scrittrice tremenda, ma mi interessa. Ecco, sono molto interessata ai libri romantici. Mi rendo conto che sto divagando dalla tua domanda iniziale, ma adesso ci arrivo. In Italia va forte il genere “romantasy”? Cioè i romanzi d’amore fantasy? Draghi, principesse, storie d’amore… È una categoria che negli Stati Uniti sta vivendo un periodo felicissimo e mi interesserebbe ragionare sulle ragioni di questo successo. Ho delle teorie. Ad ogni modo sì, è vero, non recensiamo questo genere di libri, mentre scegliamo i libri di Yanagihara. Non posso occuparmi di tanti titoli e quelli che scelgo di solito devono essere abbastanza densi da darmi filo da torcere per un po’. E gli autori devono essere autori affermati, devono avere un certo profilo, aver lasciato dietro di sé una certa traccia del loro lavoro e della loro personalità. Intendo interviste, saggi, articoli… Sai, per un certo periodo ho inteso la critica come “punching up”, come un modo per scuotere qualcuno che ha più potere. Questo non è sempre vero, però in linea di massima la “stroncatura” la fai contro chi non può uscirne davvero distrutto, perché è più strutturato. Insomma, la loro vita andrà avanti tranquilla anche dopo una recensione negativa. In un certo senso, cerco di bilanciare l’autorità di cui gode lo scrittore, o di cambiare una certa fissità di sguardo che abbiamo nei suoi confronti.. Quindi sì, da una parte si dà valore all’oggetto della critica, ma dall’altra si fa anche l’opposto: si prova a metterlo in discussione.
“Le persone stanno realmente apprezzando un’opera d’arte o stanno cercando di far passare un viaggio in aereo il più velocemente possibile? Oppure ancora: stanno partecipando a un trend che gli è stato venduto da un’azienda?”
Sulla dicotomia forma/contenuto in un romanzo, scrivi che tu giudichi il contenuto, perché i romanzi sono a tutti gli effetti delle idee sul mondo. Scorrendo però la tua produzione in ordine cronologico mi pare che questa cosa sia cambiata. Quando scrivi di Maggie Nelson, l’oggetto della critica è il contenuto e l’ideologia ad esso sottesa; ma nei pezzi più recenti, compreso quello su Ocean Vuong, citi passi dei libri e ti concentri soprattutto su questioni formali: la lingua, il giro della frase. Lo hai notato?
Sai che nessuno mi aveva mai chiesto questa cosa? Credo che i miei primi pezzi critici fossero molto imperniati sul contenuto perché ero molto concentrata sulle componenti ideologiche, etiche e politiche del testo. Per esempio, oggi mi rendo conto che la critica a Myra Breckinridge – che si trova nella raccolta – era un pretesto per elaborare alcune mie idee. C’è stato un momento in cui mi piaceva pensarmi formalista, ma non credo di esserlo mai stata. Mi piaceva l’idea di esserlo. Ciò detto, i libri più interessanti per me sono quelli in cui c’è un rispecchiamento di forma e contenuto, e l’una contribuisce alla piena espressione dell’altra (e viceversa). In questo senso il romanzo d’amore è un esempio perfetto: perché l’atto stesso di leggere un libro e apprezzarlo è una metafora dell’innamoramento. E ancora oggi, almeno nel mondo anglofono, le storie d’amore sono le più lette. Quello che mi affascina di un romanzo d’amore è che implica l’amore a ogni livello: racconta una storia d’amore, ma diventa anche un oggetto, assieme qualcosa di tangibile e ideale, che veicola l’amore del lettore. E quindi i romanzi d’amore sono in realtà meta-romanzi che parlano dell’atto stesso di leggere, di cosa significa amare un libro. E allo stesso tempo mentre leggi, di fatto, drammatizzi la tua stessa esperienza dell’amore. E questa struttura così complessa in realtà la si può trovare in vari libri, e non si tratta solo del prodotto di una tecnica particolarmente affinata. Ecco, tutto questo per dire che per me la cosa più avvincente è immergermi in un libro e trovare il punto in cui se io applico una certa pressione mi svela il nucleo ultimo dell’opera. Sai, come guardare un albero enorme, con le radici, le ramificazioni, le foglie, il tronco piantato nel terreno, e tutto questo in fondo non è che il prodotto di un qualcosa di molto piccolo. A me piace trovare quel qualcosa. Quindi sì, hai ragione, ho cominciato nel tempo a concentrarmi molto di più sui dettagli. Probabilmente, nel profondo, sono un’ermeneuta. Sono stata cresciuta da cristiana evangelica, e il mio pastore – un tipo davvero inquietante – la domenica sceglieva dei sermoni da libri diversi e il nostro compito era leggere un paio di versi e analizzarli, e spesso erano passaggi estrapolati dai libri più noiosi della Bibbia. E ogni volta che sceglieva i versi ci diceva “parlano di questo o quello e io vi dimostrerò che però in realtà parlano di Gesù”. E adorava fare questa cosa soprattutto con i versi che palesemente non parlavano di Gesù. Del resto, con i testi sacri di qualunque religione non bisogna troppo preoccuparsi di trovare la risposta perché tanto la sai già. È molto più stimolante il processo: capire come arrivare dalla domanda alla risposta. Con questo non voglio dire che io non sia interessata alla risposta, ma sicuramente sono più interessata a pormi la domanda “Cosa succederebbe se…?” “Cosa succederebbe se questo libro fosse una metafora di se stesso?” E credo che questa domanda in realtà si applichi a molti romanzi, e ne scaturiscano quesiti affascinanti. Forse prima o poi è una domanda che si esaurirà e allora dovrò trovarne un’altra. Ma ti ringrazio, perché è sempre bello ricevere domande sul mestiere.

Nei tuoi pezzi c’è spesso poco spazio per il lettore per farsi un’idea propria, o credere di, al di là della tua tesi. A livello retorico non usi alcun artificio che faccia credere al lettore di star ragionando insieme a te, di star scoprendo qualcosa con te. È ovvio che nei pezzi critici emerge sempre la costruzione di una tesi, ma nel tuo caso tu parti con una tesi molto netta da dimostrare. È così?
Domanda interessante. Qualche volta sono assolutamente parziale nei confronti dell’oggetto che sto analizzando, perché magari mi ha fatto un’impressione tremenda, o perché vorrei che mi piacesse (o il contrario). Però non saprei… È bello avere una tesi, no? A me piace scrivere – e leggere – i pezzi critici in cui si capisce chiaramente qual è la tesi espressa. Anche perché credo che i romanzi siano delle raccolte di idee, e sono quelle a incuriosirmi di più. Ma credo ci sia un processo parallelo a questo, che dall’oggetto mi conduce lontano dai preconcetti che sviluppo inizialmente – se ne sviluppo. Ci sono anche casi in cui mi avvicino con grande entusiasmo a qualcosa, come nel caso di Yanagihara, perché non avevo mai letto nulla di suo quindi non avevo alcun pregiudizio, e piano piano mentre leggevo mi è montata una rabbia che ha poi guidato il pezzo critico. E credo che questo lo renda gradevole alla lettura, ma non lo scriverei oggi, perché sono cresciuta, ho imparato delle cose, e non solo dal punto di vista della critica. Essere una critica è il mio lavoro, tutto qui. Per continuare a far sì che mi interessi svolgerlo cerco di creare un mini-master ogni volta che devo scrivere di qualcosa. Mi spiego: l’ultimo pezzo che ho scritto su Sally Rooney l’ho composto leggendo contemporaneamente Lukacs. Come una sorta di lettura supplementare che mi aiuta con il testo principale. E in realtà è un modo per proseguire con la mia educazione.
Per quanto riguarda il lettore… credo che quello che mi interessa sia fare entrambe le cose che dici. Ovvero da una parte indirizzare con forza il lettore, perché è vero che io non voglio essere contraddetta. Dall’altra però vorrei anche che il lettore pensi che quell’idea l’abbia formulata lui o lei. Se poi io riesca in effetti a ottenere questo effetto non lo so. Dipende dal lettore suppongo. Io vorrei dare una forma al pensiero del lettore. E questo si ottiene applicando un certo grado di controllo.
Interessante… tu quindi credi che il lettore abbia già in nuce l’opinione che tu modelli?
Non necessariamente. Ma qualche volta penso sia così. Si tratta di cristallizzare una sensazione che le persone hanno provato…
Ma…
Anche se non l’hanno avuto voglio che la provino alla lettura del pezzo. Quindi non solo vorrei che pensassero di aver pensato ciò che scrivo, ma anche che abbiano provato la sensazione che ha portato a quel pensiero. Perché non è semplice pensare. Non è semplice essere la persona che trattiene il pensiero, l’idea, abbastanza a lungo da renderla disponibile per discuterne con gli altri. Non è un’esperienza che va data per scontata. Esattamente come gli scrittori soffrono durante la stesura, anche io soffro per ottenere ciò che voglio. Perché per me è qualcosa di più del semplice mostrare le caratteristiche di un oggetto al lettore affinché lui o lei se ne facciano un’opinione. E nel caso della critica, rispetto ad altri tipi di scrittura, c’è un’asimmetria molto forte tra lettore e autore, perché sta a me dare una forma decisa a una sensazione.
Stiamo di fatto dicendo che quando io vado al cinema o leggo un libro, i miei pensieri discendono dall’emozione, giusto? E che se nessuno trasforma quell’emozione in un pensiero, mi rimane solo il sentimento.
Io credo addirittura che non sia solo questo, cioè che hai un sentimento e che questo debba essere trasformato in un’idea, ma anche che sia l’idea stessa a essere sentita in un certo modo. E spesso l’unica relazione che si intrattiene con un’idea è di tipo emotivo.
Molto interessante. Senti, è diverso leggerti quando scrivi di serie tv rispetto a quando scrivi di libri. Sei molto più generosa, per esempio, con l’orribile Yellow Jackets…
È peggiorato rispetto alla prima stagione, dai! (ride)
No, si vedeva fin dal principio che c’erano troppi elementi che l’avrebbero mandata in vacca.
Ahaha. Bè diciamo che è molto più difficile fare un’analisi testuale che scrivere di un oggetto pop come una serie tv. Quando scrivo di un libro ho accesso a una serie di informazioni, di interviste rilasciate dagli autori, di libri precedenti, di saggi… Insomma è un’analisi molto più serrata. E infatti tutti mi dicono che sembra che io preferisca le serie tv al grande romanziere del mese. Ma io credo che sia vero il contrario. Proprio perché mi piacciono di più i libri sono molto più attenta. Oltretutto sono proprio animali diversi. È vero che le serie sono scritte da autori, ma non gli accordiamo la stessa autorevolezza che accordiamo invece agli scrittori come, che so, Zadie Smith. Lei ci dice su cosa poggia la sua opera, che cos’è la letteratura, e ha la convinzione profonda che quest’ultima sia la forma più alta dell’esperienza umana. E allora bisogna rispondere a tono.
Ad ogni modo spesso mi viene imputato di essere middle-brow. Ma il fatto è che io sono un po’ sospettosa quando si tratta di “letterarietà”. Sono un po’ più pragmatica, ecco. Voglio dire, chi legge romanzi d’amore o guarda tanta TV, sa cos’è Colleen Hoover, no? Colleen Hoover: con copertina rigida sono 32.99 dollari, in tascabile 24 dollari, per dire. Sanno che stanno leggendo, anzi consumando, qualcosa di molto reale. Ora, non è che voglio che tutto faccia schifo, non è che io non sia interessata alle domande che la letteratura pone, ma il modo in cui viene recensito oggi il “romanzo letterario” lo fa apparire come se fosse un qualcosa che trascende, anzi, rifiuta il consumo. Ecco, per me non è così, ed è importante ribadirlo.
Ok, ora parliamo della prima cosa che hai scritto, On Liking Women. L’idea fondamentale del libro è che il genere sia in realtà un desiderio, e che quindi la transizione di genere ne ricalchi la traiettoria. Non è che ti senti femmina e quindi vuoi cambiare genere, ma ti piacciono le femmine e per questo vuoi farlo. E infatti nel saggio racconti di quanto ti piacciono le ragazze, quello che indossano, come si muovono… la loro girliness, non so come meglio dirlo. Che però è anche legata alla giovinezza, che è stupenda, e anche io oggi quando guardo le ragazze ne invidio un aspetto anagrafico oltre che di genere. Ecco, mi chiedevo se crescendo il desiderio fosse cambiato, perché le ragazze ora sono donne, cioè soggetti molto diversi, non so se più o meno desiderabili…
Interessante la faccenda dell’età… La transizione in qualche misura equivale in parte a perdere la giovinezza per ricominciare da capo. Questo come puoi immaginare di solito genera imbarazzo in tutte le persone coinvolte. Una TERF forse direbbe che ho gettato la spugna, perché ora sono molto mascolina, butch, non ho niente di quel desiderio femminile un po’ frivolo. Detto questo io credo che tutti si “femminizzino” crescendo. Vedo tutti questi uomini anziani che se ne vanno in giro con la pelle più liscia e morbida del mondo… Comunque sì, in generale diventando adulti cambiano le questioni legate al genere. Le persone vengono prese a schiaffi dalla vita, diventa sempre più difficile vivere e proiettare un’immagine di sé smagliante. Ho partecipato all’evento di lancio del libro di Torrey Peters lo scorso mese [Detransition, baby, pubblicato in Italia da Mondadori, nda] e lei diceva che magari una persona, una ragazza cis, che a vent’anni si trucca perfettamente e va a ballare, a cinquanta può indossare una tuta da lavoro e ripare macchine. Non è una transizione anche quella? Alla fine si tratta del desiderio di andare da qualche altra parte. Perché è sempre in movimento, no? Retrospettivamente è facile vederne il percorso, ma nel presente è impossibile sapere dove si orienterà. È difficile immaginare come diventare la persona che dovresti essere per desiderare qualcosa di diverso da ciò che desideri ora, no? Eppure succede. Quello che dico nel saggio a proposito della caparbietà del desiderio credo sia ancora vero, ma forse vi pongo troppa enfasi… C’è una differenza tra parlare della caparbietà del desiderio e dire invece che è una dimensione fissa. È caparbio, il desiderio, ma si muove, evolve, cambia.
Continuiamo a parlare dei tuoi primi lavori. Erano animati da una voca ambivalente, provocatoria e audace. Libera da qualunque senso di colpa politico o morale, come era quella di Solanas, a cui ti ispiri – “devota alla sua ambivalenza”. Se apro Authority però trovo subito un pezzo che mescola il conflitto tra Israele e Palestina al tuo lavoro. Proseguendo nella lettura, molti tuoi pezzi sono politici in modo granitico. Ed è strano perché quando parlavi di te, del genere, era tutto molto più libero. Al di là della condivisione o meno delle tue istanze, del senso di giustizia che le innerva, mi pare che queste ultime inibiscano un’altra parte di te.
Sì, è così. Sai quando penso a Femmine il livello di libertà, di libertà politica, è qualcosa che mi soverchia. È folle che quel libro esista. Qualche volta mi piace, qualche volta ne sono tormentata. Mi sembra di aver lavato i panni sporchi in piazza. I miei panni sporchi. Ne è appena uscita una seconda edizione negli Stati Uniti con una prefazione nuova, che si trova anche su «N+1» e che credo tradurranno anche qui, in cui rifletto su questa cosa. Ho avuto la sciagura di leggere tantissimo le TERF, e so che molte di loro hanno letto il libro e lo hanno usato per sostenere le loro cause – e non solo loro, tutto il mondo reazionario anti-trans. Succede spesso che qualcuno che appartiene a una minoranza vuole dire qualcosa pubblicamente e altre persone di quella minoranza dicono No, no, non parlarne davanti a tutti. E la ragione è che così facendo fornisci le armi al nemico per distruggerti. E di solito ovviamente sono scettica riguardo questo atteggiamento, ma nel mio caso è successo esattamente questo. Mi hanno letta, mi hanno presa alla lettera. Mi citano. Mi usano per costruire le loro tesi, per sostenere le loro posizioni. Ciò detto io non credo di avergli fornito le armi, quelle le avevano già, ma di avergli dato un bersaglio. E rispetto al libro mi sento protettiva nei confronti della versione di me che l’ha scritto, che soffriva in quel momento. E sai, sapere che JK Rowling mi odia è affascinante ma anche difficile. Ciò detto ovviamente apprezzo ancora quel tipo di libertà, è che a volte non so se quel libro sia originato dalla libertà o dalla disperazione del non avere categorie di appartenenza, dalla solitudine. Mi piace pensare che la libertà oggi la preservo per me stessa. Non solo nella mia vita privata, ma anche rispetto a quello che succede durante il processo di scrittura, nel modo che ho di pensare a qualcosa.
“Ad ogni modo spesso mi viene imputato di essere middle-brow. Ma il fatto è che io sono un po’ sospettosa quando si tratta di ‘letterarietà. Sono un po’ più pragmatica, ecco. Voglio dire, chi legge romanzi d’amore o guarda tanta TV, sa cos’è Colleen Hoover, no?”
La faccenda delle TERF è concreta, è una minaccia vera, che non posso minimizzare. E quindi Femmine era anche un modo per rispondervi, no? Ma credo sia anche un libro artistico, un manifesto. In un certo senso è letterario, no? Si tratta di creare un oggetto… E ora occupo il ruolo che occupo, che non è ciò che avevo in mente quando ho scritto Femmine. Ora il mio lavoro consiste in qualcos’altro, nel comunicare le idee molto chiaramente, e qualche volta quelle idee, o forse spesso, quelle idee sono idee politiche. E quindi per esempio il pezzo che ho scritto lo scorso anno sui bambini trans e ho sicuramente attinto a del materiale da On Liking Women e Femmine ma non in modo esplicito perché sono testi difficili, e quindi è inutile citarli in pezzi di opinione per il grande pubblico. Quindi ecco, sento una nuova responsabilità rispetto alla mia posizione professionale. E so che le TERF hanno odiato proprio la libertà del libro. E so che difendere la libertà di Femmine implicherebbe limitare un altro tipo di libertà che uso nel mio lavoro. Ad ogni modo penso molto al concetto di libertà: anche le TERF sostengono di battersi per la libertà di parola, per la libertà delle donne. E quindi la questione non riguarda solo la libertà in sé, ma a cosa serve questa libertà. E dire che la libertà serve a qualcosa implica anche che questa libertà ha dei limiti. Penso molto a tutte queste cose.
Senti, tu hai iniziato a scrivere al college dove per lo più ti occupavi di testi teatrali e personal essays. Cose molto diverse rispetto ai pezzi critici. Mi chiedevo quindi se il tuo lavoro da critica reprima una tua vena più narrativa.
Sai i primi anni dopo la transizione sono stati molto intrecciati al diventare anche qualcuno “pubblicamente” – non sto dicendo di essere una celebrità ovviamente, però in un certo mondo newyorkese ho iniziato a esistere pubblicamente. E quindi vivevo tanti diversi cambiamenti identitari nello stesso momento. Sono molto cauta quando si tratta di inserire elementi personali nel mio lavoro, perché mi rendo conto che ci sono degli incentivi sociali a farlo. Voglio dire, sai quanti soldi potrei fare da un memoir sulla mia transizione? Ed era quello che tutti si aspettavano. E sono così felice che il Pulitzer non abbia incluso nessuno dei miei pezzi più personali! Ora, non è che io sia contraria al parlare di me stessa, ma semmai lo dovessi fare voglio che sia in modo ragionato.
Foto di Sarah Tricker.