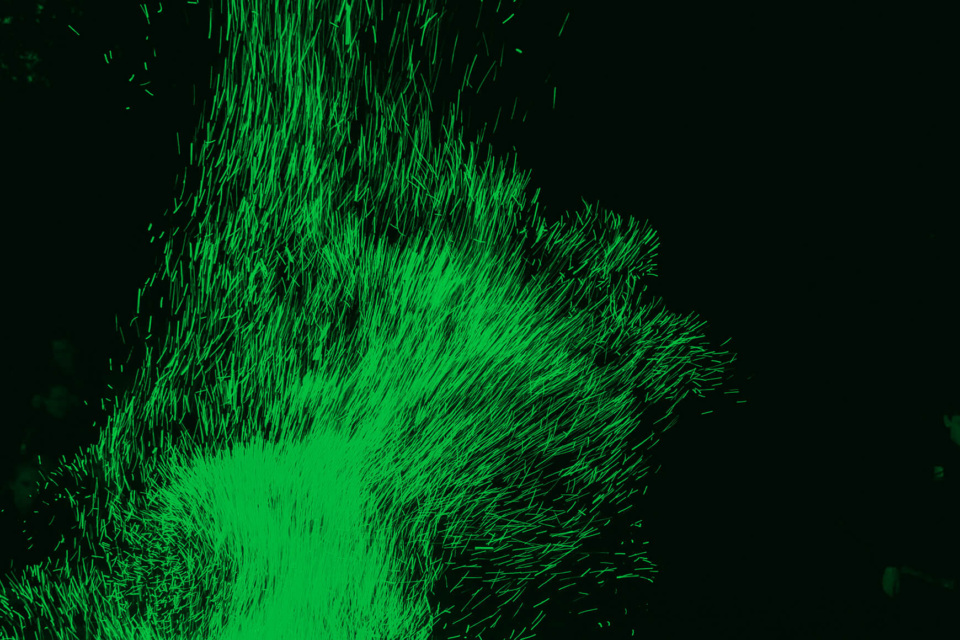Per molto tempo, il Giorno della Memoria è stato un rituale condiviso e quasi indiscutibile, scandito da immagini e parole ormai canoniche. Oggi, a quasi ventisei anni dalla sua istituzione, attraversa invece una crisi profonda, che riguarda il significato stesso dell’espressione “Mai più”.
Fino a pochi anni fa andava tutto liscio. Il 27 gennaio, i canali tv davano i classici alla Schindler’s List o La vita è bella se non avevano da offrire esclusive prime visioni di film meno visti. A scuola venivano proiettati gli stessi film e si leggevano Primo Levi – magari solo nell’antologia – e romanzi più adatti ai ragazzi: Il bambino con il pigiama a righe, Storia di una ladra di libri ecc. Qualcuno riusciva a invitare uno degli ultimi testimoni incrociando le dita per la salute dell’anziano sopravvissuto. Liliana Segre era così amata che persino la scorta sembrava una naturale conseguenza di ciò che accade quando la celebrità scatena torme di haters inspiegabilmente antisemiti. Gli altri organizzatori si arrangiavano invitando i cosiddetti “testimoni di seconda generazione”, categoria che comprende la sottoscritta. Ma nonostante la mamma deportata a Auschwitz dal ghetto della sua cittadina polacca e la quasi totalità della famiglia materna e paterna uccisa nelle camere a gas, non sono mai stata tra gli ospiti più gettonati. Il mio esordio (post)memoriale, uscito prima dell’istituzione del Giorno della Memoria, tornò disponibile quando il mercato ormai debordava di novità pubblicate per la ricorrenza e, inoltre, Lezioni di tenebra non è mai stato promosso come “libro per le scuole”. Cosa che mi dispiace, perché a scuola mi sono capitati gli incontri più belli mentre non posso dire lo stesso per le cerimonie istituzionali: grondanti retorica, spesso arricchite da intermezzi creativi a alto contenuto emotivo che, tra me, chiamavo Holocaust Kitsch, nascondendo il disagio al pubblico commosso.
In più chi organizzava l’evento doveva valutare se l’ospite cui si concedeva il microfono avrebbe violato il copione dicendo qualcosa di sgradito alle autorità. Nel mio caso bastava documentarsi un minimo per intuire che avrei tracciato collegamenti con i profughi e migranti lasciati morire nel “Mare Nostrum” o riportati dalla “Guardia costiera libica” in quei luoghi di tortura e schiavismo che avrei tranquillamente chiamato lager. O che, pur restando nello scenario di Auschwitz, avrei ricordato lo Zigeunerlager come emblema del Porrajmos, dato che il razzismo contro rom e sinti è rimasto vivo e presente. Consegnati ai carnefici anche in Italia, non li menziona il testo della legge del 2000 sul Giorno della Memoria che invece include “i deportati militari e politici italiani”, scelta che oggi appare un “di più” trascurabile.
Ma la legge promossa da Furio Colombo, allora deputato dell’Ulivo, cominciò il suo iter durante l’ultima legislatura degli anni ’90. Era ancora figlia del secolo scorso: della sua memoria ancora viva nella generazione di nonni e bisnonni cresciuti durante la guerra. Dell’ottimismo con cui, dopo la fine del mondo diviso in blocchi, si credeva nelle magnifiche e progressive sorti del binomio “libero mercato e democrazia liberale”. Finalmente si poteva applicare il diritto internazionale umanitario nella forma assunta dopo il processo di Norimberga e la Convenzione ONU sul genocidio del 1948. I Tribunali penali internazionali per l’Ex Jugoslavia e il Ruanda erano nel pieno dell’attività; L’Aja, che ospitava il primo, era già la sede designata della Corte Penale Internazionale, voluta dallo Statuto di Roma firmato nel 1998.
In Italia, la legge sul Giorno della Memoria fu approvata all’unanimità dal Parlamento quando il centrosinistra reggeva una (labile) maggioranza, Umberto Bossi si definiva antifascista e Gianfranco Fini era impegnato a trasformare Alleanza Nazionale in un partito liberal-conservatore. Nel 2003, diventato vicepremier, Fini sarebbe andato allo Yad Vashem per compiere, la kippah in testa, un atto di espiazione nei confronti delle vittime ebree del fascismo.
Trascorrono tredici anni prima che l’austriaco Strache apra la stagione dei pellegrinaggi allo Yad Vashem per siglare il patto – sacro o sacrilego – tra la destra israeliana e quella europea e mondiale. In cambio del sostegno “senza se e senza ma” allo Stato ebraico, quest’ultima riceve l’assoluzione sempre meno condizionata del suo humus antisemita. Sino all’apparente paradosso per cui, alla seconda conferenza per la lotta all’antisemitismo, la parola spetta quasi esclusivamente a figure di spicco che tengono nell’armadio non gli scheletri ma piuttosto le urne degli antenati antisemiti e diffondono teorie del complotto di nota matrice. I lavori si aprono a Gerusalemme, nella data fatidica del 26 e 27 gennaio.
“Fare memoria” oggi può significare domandarsi come tutto questo sia diventato possibile. Da dove viene l’ascesa delle destre etnonazionaliste, razziste e autoritarie ma anche fautrici di quell’ultraliberismo che rafforza le nuove oligarchie? Dalla cecità di non cogliere che la deregulation neoliberista andava a distruggere la democrazia liberale? Oppure persino da prima?
L’Italia è stata, ancora una volta, la “moderata” precorritrice di tali tendenze. Nel ventennio berlusconiano passano, assieme alle leggi ad personam, due riforme della Costituzione “nata dalla Resistenza”. Il 25 aprile diventa vieppiù “divisivo” mentre ottiene un avallo bipartisan la legge sul Giorno della Memoria: compresa l’inclusione dei deportati politici e militari, proposta da Tullia Zevi, figura centrale dell’ebraismo italiano. Erano comunque altri tempi. Oggi la memoria dei deportati politici può serenamente affiancare la memoria della Shoah solo laddove la Regione, il comune o la scuola sono in mano a chi vuole avere cura dei valori dell’antifascismo.
Il Giorno della Memoria, insomma, correva da anni due rischi opposti: esaurirsi in formule e riti avulsi da ogni richiamo al presente o far emergere che il suo significato dipende per forza dalla visione etica e politica del singolo o della comunità che si presta a “riattivarla”.
Se questo è già stato così quando predominavano la ripetizione dei cerimoniali e la saturazione di narrazioni sempre più omologate, adesso è diventato pressoché impossibile continuare a fingere che il rituale “Mai più!” abbia lo stesso significato per tutti.
Come scrittrice sono abituata a sondare il significato delle parole. Non ho tuttavia gli strumenti di Valentina Pisanty, semiologa che si è molto occupata della Memoria della Shoah. Proprio a partire dall’ideazione di questo articolo avrei voluto ragionare con lei sulla crisi della Memoria, cosa che per motivi di tempo e di spazio si è rivelata impossibile. Nella prospettiva di un dialogo da sviluppare con calma, questo pezzo offre una serie di spunti iniziali. Pisanty ne è interlocutrice implicita visto che mi accompagnano i suoi libri: Abusi di memoria. Negare, banalizzare, sacralizzare la Shoah (Bruno Mondadori, 2012), I Guardiani della Memoria e il ritorno delle destre xenofobe (Bompiani, 2019) e Antisemitismo. Una parola in ostaggio (Bompiani, 2025).
C’è un punto centrale che non avrei messo a fuoco con altrettanta chiarezza senza aver letto Pisanty. La crisi della Memoria è una crisi di significati. Quelli che per oltre vent’anni si sono imposti come “senso comune” riuscivano a nascondere delle zone conflittuali.
Ciò che ha fatto esplodere questo nucleo di “senso comune” è l’evidente impatto di due avvenimenti reali: il massacro del 7 ottobre e la distruzione di Gaza. Lo formulo nel modo più neutro visto che, insieme a Pisanty, si tratterà di esaminare come il terreno “tra il fiume e il mare” conteso in un crescendo di violenza abbia generato un campo di battaglia semantico. Guerra tra definizioni, talora anche di valenza giuridica: sul termine “genocidio”, sui disegni legge contro l’antisemitismo. Scontri di narrazioni, interpretazioni e ricadute simboliche. Ragionare su questo non intende, ovviamente, assimilare le vittime, gli esecutori e tutte le vite reali travolte o coinvolte “laggiù” ai discorsi e alle raffigurazioni che qui ne facciamo. Bensì prendere atto che Gaza ha creato una frattura di senso epocale. E che sono stati proprio i collaudati dispositivi della Memoria a innescare un cortocircuito tra Auschwitz e Gaza – entrambi intesi come parte per il tutto.
Una crisi, però, invita a ripensare da capo ciò che davamo per pacificamente acquisito. Riparto perciò dalla domanda su come mai la Memoria abbia finito per coincidere con il topos, luogo-simbolo e, persino, luogo comune a cui diamo il nome di “Auschwitz”.
Nel dopoguerra nessuno volle saperne, quasi nessuno parlarne. I sopravvissuti di Auschwitz oggi considerati autori di opere imprescindibili – Primo Levi, Elie Wiesel, Imre Kertész – faticarono a trovare prima le parole e la forma, poi un editore e, infine, i lettori. L’orrore dei lager aveva semmai altri nomi: Dachau, Mathàusen (all’italiana), Buchenwald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen. I documentari che usavano materiali girati nei campi servivano a rieducare o a denunciare o a fungere da prove a Norimberga. Avevano nondimeno titoli metaforici come I mulini della morte (1945) e Notte e nebbia (1956), indicativi del riserbo che andava mantenuto persino verso un pubblico di ex nazisti. Il primo fu diretto da Billy Wilder, il secondo da Alain Resnais che, da lì in avanti, poté dedicarsi al “cinema vero”. Il suo amico regista Jacques Rivette fece uscire nei «Cahiers du Cinéma» una stroncatura di Kapò (1960): se scrivere poesie dopo Auschwitz era un atto barbarico, lo era a maggior conto ambientarci un film (melo)drammatico come quello di Pontecorvo.
Facciamo un salto al 1993 quando Schindler’s List vince sette Oscar e diventa l’Holocaust Movie tuttora più visto nel mondo. È l’apice di un processo di canonizzazione iniziato molto tempo prima. Lo stesso termine “Olocausto” – come ricorda Pisanty in I Guardiani della Memoria – deve la sua fortuna all’essere stato adottato da Wiesel e poi popolarizzato da Holocaust, la miniserie statunitense che narra di una famiglia ebrea di Berlino deportata nell’Est Europa. Ricordando l’impatto dirompente sulla Germania del 1979 ma quasi nulla della storia narrata, mi sono riletta la trama di Holocaust e mi ha colpito che vi compaiono: i ghetti di Varsavia e di Vilna, i campi di concentramento di Buchenwald e Theresienstadt, il massacro di Baby Yar e i Gaswagen, la Resistenza nelle foreste ucraine e la Rivolta del Ghetto di Varsavia. C’è anche Auschwitz, ovviamente, ma insieme a Treblinka e Sobibor, due dei tre esclusivi campi di sterminio. Insomma quella serie tv, già allora paragonata a una soap opera, mostra comunque una varietà di stadi e scenari del processo che conduce alla Soluzione Finale.
“In Italia, la legge sul Giorno della Memoria fu approvata all’unanimità dal Parlamento quando il centrosinistra reggeva una (labile) maggioranza, Umberto Bossi si definiva antifascista e Gianfranco Fini era impegnato a trasformare Alleanza Nazionale in un partito liberal-conservatore”.
Shoah (1985), il documentario di Claude Lanzmann che ha un ruolo decisivo nel diffondere il nome ebraico dello sterminio, vuole essere l’esatto contrario di Holocaust. Infatti si attesta come opera canonica dell’Era del Testimone, influenzando le modalità filmiche e i principi etici dei documentari. Per cinque ore Lanzmann segue principalmente il nesso tra (grandi) ghetti, treni piombati e campi di sterminio, riservando trenta minuti all’intervista di due ebrei di Vilna scampati ai massacri nella foresta di Ponary. Oggi si stima che almeno un terzo delle vittime della Shoah perì nel genocidio “con le pallottole” in Ucraina, Belorussia, Moldavia, Paesi Baltici. Lanzmann non poteva conoscere questa dimensione mostruosa, sapeva però che il genocidio sistematico era iniziato con l’invasione tedesca dell’URRS nell’estate del ’41. In più è proprio il racconto di quei due testimoni a rendere chiarissimo che Ponary o Baby Yar – luoghi di gite fuori città mutati in luoghi di sterminio – evocasse nei sopravvissuti un orrore diverso ma non “inferiore” a Auschwitz o Treblinka. In Francia, però, cominciava a diffondersi il negazionismo e Lanzmann voleva stroncarlo con la mole schiacciante delle testimonianze di vittime e carnefici. Si trattava di difendere la verità delle camere a gas e, con esso, l’unicità della Shoah. Ma le camere a gas non potevano essere mostrate, né lo dovevano: per rispetto dei “salvati” che si assumevano il peso di testimoniare e, ancora più verso i “sommersi”, gli unici che avrebbero potuto dire tutta la verità. Mi rifaccio a Primo Levi perché per lui, profondamente laico, questo sacro rispetto equivale a quello umano. Lanzmann però non usa il linguaggio delle parole bensì quello cinematografico dove “non mostrare” è impossibile. E così, agli occhi del mondo che deve sapere e deve credere, la verità la incarnano loro e loro soltanto, i Testimoni messi in scena sui luoghi dell’assenza-presenza dell’indicibile che hanno subito: e tutto questo amplifica la dimensione del sacro.
In Abusi di memoria, Pisanty descrive la dinamica da “vasi comunicanti” tra negazionismo, banalizzazione, e sacralizzazione della Memoria. Inoltre Lanzmann doveva tenere assieme una direzione di senso, cioè non deviare troppo dalla linea narrativa dello sterminio industriale di massa, benché questa prevalente linearità suggerisca una lettura teleologica: era tutto programmato e efficace, non c’era scampo.
In Schindler’s List, Spielberg ne calca lo schema narrativo e al tempo stesso lo ribalta: ci sarebbe stato molto più scampo se solamente molti avessero agito come Oskar Schindler, che era pure tedesco e nazista. Il campo visivo però si restringe al ghetto di Cracovia e al lager “di passaggio” sul quale incombe Auschwitz: le vittime salvate ma anche gli spettatori sanno cosa significa.
Esistono motivi di varia natura perché Auschwitz sia diventato presto sinonimo dello sterminio. Dove l’uccisione industriale si ripete a ciclo continuo, come a Treblinka, anche le storie terminano lì, annientate. Auschwitz invece ne racchiude molte: la selezione, la riduzione a numero, l’arbitrio, la crudeltà, la volontà di tirare avanti o il suo contrario, la vita nuda nel tanfo della morte. In più vi finirono gli ebrei di tutt’Europa, in modo particolare i deportati dall’Europa occidentale. Per imporre la Memoria come monito universale bisognava tradurre l’indicibile in un linguaggio comprensibile ai destinatari. “Linguaggio” inteso come cultura largamente condivisa, anche se ciascun scrittore-testimone diventato canonico ne fa un uso differente. L’illuminismo di Primo Levi sta agli antipodi della “teologia negativa” di Elie Wiesel.
Ma la “fabbrica dei sogni”, Hollywood, per narrare “la fabbrica della morte” ha bisogno che il pubblico empatizzi con le vittime. E così i protagonisti di Holocaust rappresentano la middle class berlinese e di cognome fanno addirittura Weiss, “bianco”. Nel film di Spielberg, i comprimari che affiancano Schindler sono ebrei polacchi, però urbani, colti, capaci di esprimersi in un buon tedesco. Persino Il figlio di Saul dell’ungherese László Nemes (2015) si muove a cavallo tra le lingue e tradizioni degli ebrei dell’Est e la centralità di un’ossessione individuale. Il protagonista si chiama Ausländer, “straniero”, il suo shtetl Ungvar: proprio il simbolismo di questi nomi parlanti suggerisce che Nemes, nato a Budapest e cresciuto a Parigi, il mondo di Saul lo abbia ricreato, per forza di cose, attraverso vari passaggi di mediazione.
Di tutti gli autori di testi canonici sulla Shoah soltanto Elie Wiesel veniva da uno shtetl e da una famiglia chassidica. E infatti scrisse in yiddish la prima versione del suo memoir La notte pubblicandolo a Buenos Aires con il titolo Un di velt hot geshvign (‘E il mondo tacque’). Approdato a Parigi, per Wiesel fu decisivo l’aiuto di François Mauriac, scrittore cattolico, antifascista e insignito del Premio Nobel. Mauriac gli trovò un’ottima casa editrice, dove La notte fu pubblicato nel ‘58. L’editing tagliò le parti più rabbiose e vendicative presenti nel testo in yiddish e pure le descrizioni familiari a un ebreo dell’Est ma non a un lettore francese o americano. La notte – a oggi, assieme al diario di Anne Frank, il libro sulla Shoah più letto a livello mondiale – è un testo letterario, però al costo di tradurre la religiosità finita a Auschwitz del giovane chassid in un racconto sacro che nell’Ebreo impiccato scorge “in figura” un novello Cristo.
Il “canone dell’Olocausto” si impone in quanto canone occidentale. Per rispecchiarsi con le vittime ebree bisognava marginalizzare, “ripulire” o “sbiancare” coloro che l’”Occidente civilizzato” disprezzava come gentaglia orientale. Nessuno crede più a una teoria “scientifica” della razza, ma proprio il termine “antisemita” ricorda quale immagine di alterità fosse affibbiata agli Ostjuden. Lo evidenziano le caricature antisemite uscite ben prima del nazi-fascismo: attenzione, suggerivano, questi si presentano come se fossero uguali a noi, ma gratta gratta restano quelli con il naso adunco, i cappelli neri e ricci, le labbra tumide da depravati. Nel voler cancellare quell’immaginario, il canone della Memoria dovette cancellare o “ripulire” coloro che vi erano più associabili: gli ebrei ortodossi, poveri o proletari dell’Est-Europa. Gli ebrei che, per questi motivi, vissero tra di loro, distinguibili dall’aspetto, dal modo di incedere e gesticolare, dalla cadenza yiddish con cui parlavano le lingue ufficiali. Furono l’assoluta maggioranza di coloro che finirono sterminati.
In questi anni è successo qualcosa di paradossale. La Memoria di Auschwitz, intesa come dispositivo morale ormai scarico, si è riaccesa proprio davanti a Gaza. “Mai più!” non ha perso ogni significato, evidentemente. Però significa cose diverse, talvolta opposte, per diverse comunità di parlanti.
“Never again means never again for anyone!” recita lo slogan delle proteste per fermare il massacro di Gaza che prese avvio nei campus americani. All’inizio lo espongono studenti e attivisti di Jewish Voice for Peace e If not Now, gruppi anti- o post-sionisti. Ma nell’autunno del 2025 il 61% degli ebrei statunitensi considera Israele responsabile di crimini di guerra, il 40% di genocidio. La parola tabuizzata per non dissacrare la Memoria della Shoah, o non sminuirne il significato, risulta congrua al 50% degli ebrei dai 18 ai 34 anni. L’azione militare israeliana è disapprovata dal 63% di elettori democratici e dal 53% dei membri di una congregazione reform. Assieme alla frattura generazionale e alla divisione politico e religiosa si è messo in moto uno smottamento ancora più vasto. L’identità liberal ebrea-americana fatica a tenere assieme il suo riconoscersi nel pluralismo degli Stati Uniti e il forte legame simbolico ma anche vissuto con Israele, stato etnonazionalista dove i suprematisti sono al potere.
Il linguaggio dei giovani viene dalle lotte di Black Lives Matter o da ciò che hanno imparato come studenti: il colonialismo di insediamento (“settler colonialism”) aveva causato il genocidio dei nativi, sfruttato lo schiavismo, profittato della segregazione dei neri. Lo decidono i bianchi dove tirare la linea del colore, e gli ebrei sono diventati bianchi.
Vale la pena di ricordare che, prima di produrre Holocaust, gli stessi showrunner ebbero un grande successo con Radici (1977), saga di una famiglia afro-americana, e Spielberg con Il colore viola (1985): narrazioni contestabili per la sensibilità più recente ma indicative che l’antirazzismo era diventato mainstream per gli americani liberal e quegli ebrei in particolare. Come potevano loro, figli o nipoti di gente scappata dai pogrom o sopravvissuta all’Olocausto, non voler fare la loro parte affinché l’America diventasse davvero la terra dove tutti sono nati liberi e uguali?
Avevano marciato per i Diritti Civili e contro la guerra in Vietnam. E adesso si sentivano dire dai figli o nipoti che l’unica democrazia del Medio Oriente” aveva una tara originaria, uguale a quella americana. E che bisognava contestare pubblicamente la Jewish Supremacy colonialista e genocidaria: il silenzio era già complice. L’Olocausto non era forse potuto accadere perché le nazioni libere non avevano fatto nulla per fermarlo? E perché i Giusti, come Schindler, erano stati una risibile minoranza?
Simili discussioni hanno un terreno comune nell’idea che le storie di un “Altro” particolare possano e debbano avere un significato universale. La Memoria della Shoah, configurata secondo il canone sopra descritto, ne rappresenta la realizzazione più riuscita.
E quindi la medesima “lezione della storia” non la hanno tratta solo i giovani ebrei o i giovani americani ma anche i giovani italiani, proprio quelli cresciuti abituati all’esistenza e all’importanza del Giorno della Memoria. E così tutti coloro che, giovani o no, hanno riempito le piazze o manifestato altrimenti il loro dissenso o semplicemente espresso nei sondaggi che simpatizzavano con le vittime palestinesi disapprovando le politiche dei loro governi che continuavano a sostenere Israele.
Dalle ceneri della seconda guerra mondiale sono nati: le Nazioni Unite, il diritto umanitario internazionale; le (bellissime) Costituzioni democratiche di Italia e Germania; e l’Unione Europea, che il Giorno della Memoria lo introdusse per esigere che i nuovi membri dell’Est espiassero il proprio passato antisemita ripetendo all’unisono che Auschwitz non si sarebbe mai più ripetuta.
Da quelle stesse ceneri, naturalmente, è nato anche lo Stato ebraico. Non soltanto perché risultava cosa buona e giusta che un popolo sterminato per due terzi avesse finalmente un pezzo di terra dove sentirsi libero e sicuro. Le nazioni democratiche, che avevano negato l’ingresso agli ebrei perseguitati, preferivano non accollarsi anche i superstiti che nei loro paesi d’origine rischiavano ancora la pelle: meglio spedirli in Palestina, questi ebrei orientali.
E così Israele non si rafforza solo grazie all’apporto fisico e demografico dei nuovi arrivati ma anche tramite un’antitetica “lezione della storia”.
Dapprincipio la Memoria d’Israele salva gli esempi di resistenza ebraica, di cui è emblema la Rivolta del ghetto di Varsavia, con i suoi comandanti sionisti. Gli altri erano così devoti, rassegnati o imbelli da farsi “portare come pecore al macello”. I sopravvissuti sono dunque gente da rieducare: bisogna che parlino l’ebraico moderno e dismettano lo yiddish assieme alla mentalità dello shtetl. Eppure lo Yad Vashem – progettato prima dell’indipendenza, congelato durante le guerre del 1946/47 e 1948 che generano la Nakba – viene inaugurato già nel 1953. I parenti, gli amici e tutti coloro che non avevano seguito la strada dei sionisti non ci sono più. Impossibile dirgli quanto hanno sbagliato. Impossibile tagliare il legame con il mondo distrutto, il “doppio legame”. La memoria da un lato è un lavoro silenzioso, archivistico. L’altro lato è l’inglobamento dei pezzi utili da recuperare dalla Shoah, “catastrofe”, nella narrazione sionista. Come in tutte le mitologie nazionaliste gli eroi recenti si fondono con quelli antichi: eroi biblici o comunque di prima della cacciata in esilio. Anche il luogo comune delle “pecore portate al macello” riecheggia la tradizione religiosa: per contestarla, però, come avevano fatto i giovani sionisti organizzati nei gruppi di autodifesa dopo il pogrom di Kishinev (1903).
Never again! A Program for Survival (1972) è un pamphlet scritto da Meir Kahane, fondatore della Jewish Defense League, rabbino ortodosso, sionista di destra cresciuto a Brooklyn. Sulla copertina arancione campeggia una Stella di Davide, con sopra una mano alzata in pugno. È identica al simbolo dei Black Panthers, però bianca. Kahane ha copiato la militanza radicale dei neri rovesciandola specularmente. Dopo la lotta per i Diritti civili, gli omicidi di Martin Luther King, Malcolm X e altri leader afroamericani, regna un clima di violenza politica e repressione feroce che acuisce vecchie tensioni tra ebrei e neri. C’è razzismo da un lato, antisemitismo dall’altro, reciproco rinfacciarsi di vittimismo. La visione reazionaria di Kahane converge su un punto centrale: la democrazia liberale americana è un inganno ipocrita e, soprattutto, una minaccia delle identità che vanno difese con la massima fierezza. Gli ebrei devono combattere – con il fucile – contro l’odio eterno che si acquatta nell’animo di tutti gli altri. E ancora più contro il rischio di perdere l’identità etnico-religiosa che li ha fatti sopravvivere nei secoli.
Immigrato in Israele – per sottrarsi a una condanna per terrorismo – Kahane applica la sua ideologia allo Stato ebraico. Vuole espellere i palestinesi dall’intero Paese, compresi i territori occupati. Vuole la Grande Israele. Rifondare la nazione sulla legge ebraica, vietare i matrimoni misti. Odia, riodiato, l’establishment laico e laburista, ma disprezza pure i compromessi di Begin, leader del Likud. Fonda un partito, Kach, che solo una volta riesce a vincere un seggio. All’indomani delle elezioni successive, nel 1988, la Knesset vara una legge per impedire che si ripresenti: non sono ammesse liste che incitino al razzismo né quelle contrarie al carattere ebraico e democratico di Israele. Due anni dopo, viene ucciso con un arma da fuoco da un islamista americano di origini egiziane, davanti un Marriott Hotel, a Manhattan.
È un seguace del kahanismo Itamar Ben-Gvir, il leader del partito dei coloni. Il ministro della difesa del governo Netanyahu, quello che ha formato, e armato, le milizie.
Questa storia parla da sé, forse sin troppo. Credo sia una scorciatoia pensare che le idee viaggino come piante dal loro habitat naturale a un altro. O che, estirpate, rispuntino per invadere tutto, perché il terreno che non era adatto, adesso lo è diventato.
E allora provo a riaprirla, questa storia. Meir Kahane si è formato nel luogo più ebraico e ortodosso della diaspora, quello dove lo yiddish non è morto, quello dove i superstiti si sono radunati attorno ai rabbini messi in salvo per rifondare le loro comunità chassidiche. Kahane, americano di terza generazione, non vi apparteneva e non era interessato a quell’osservanza chiusa. Era in missione per conto di Dio, però un Dio molto politico, il cui antimodernismo è frutto della cultura moderna occidentale. Come lo è il nazionalismo e il revanscismo che oggi chiameremmo vittimismo: probabilmente perché le vittime civili delle ideologie, delle guerre, dei conflitti inter-etnici, delle repressioni sono cresciute in misura esponenziale. O perché noi che ci accusiamo vicendevolmente di “empatia selettiva” in fondo parliamo la stessa lingua avendo interiorizzato che le persone inermi non andrebbero mai uccise o ferite o disumanizzate.
Ho voluto recuperare una parte esclusa dalla Memoria pensando che un immaginario cristallizzato funzioni – anche – da memoria schermo. Molti “Mai più!” vengono proclamati nella sottaciuta convinzione che i nazisti avessero applicato un eccesso di zelo e di diligenza appartenenti al secolo delle grandi ideologie di massa, dei grandi apparati burocratici e delle grandi fabbriche, comprese quelle dello sterminio.
In realtà, quel genocidio abnorme è stato – anche – non troppo diverso da quelli venuti prima o dopo, dove la ferocia non è un lavoro sporco e stancante ma anzi l’anima stessa del processo che può sfociare nella distruzione, in tutto o in parte, di un determinato gruppo – per attenermi alla definizione giuridica del termine. Ciò che distingue la Shoah non sono i metodi ma l’intenzione di eliminare tutti gli ebrei andandoli a cercare in ogni anfratto. Non sarebbe stato possibile senza il radicamento del pregiudizio verso una genia vista come radicalmente diversa e malvagia: in tempi di riemergenza dell’antisemitismo è giusto tenerne conto. Rigettando, però, ogni colpevolizzazione collettiva, a maggior conto se riferita al passato, assieme all’idea di un odio eterno e immutabile. Odiare stanca. E infatti la storia intera racconta che gli ebrei per secoli hanno vissuto accanto a coloro che li consideravano diversi. Era vita, non sopravvivenza. Nessuno merita di essere ridotto a vittima o a sopravvissuto. Tantomeno celebrato come tale.