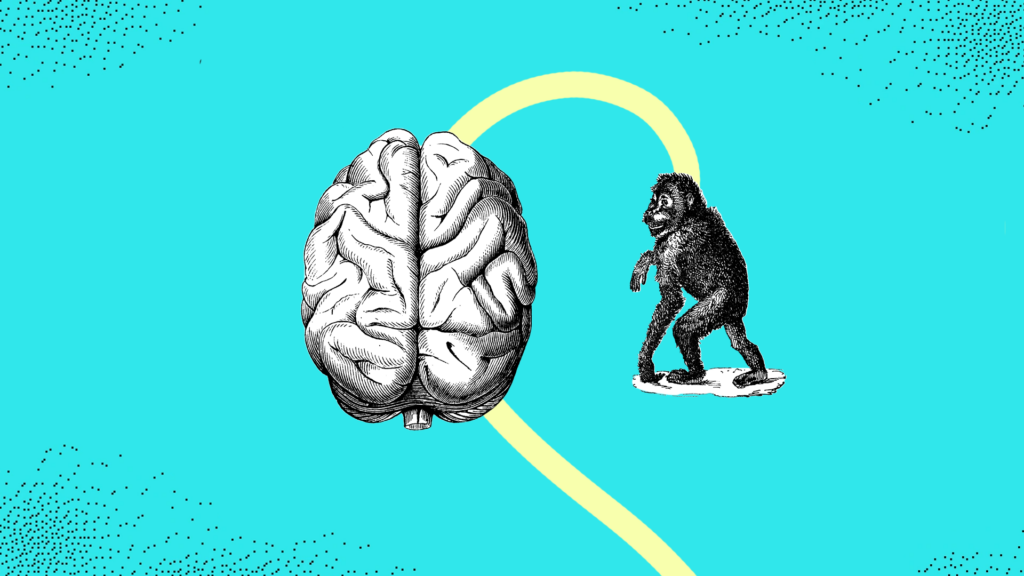Valerio Corzani
La boxe a Cuba è una cosa seria

13 Giugno 2023
A Cuba, la boxe è molto più di uno sport: è una parte fondamentale dell’identità del paese. Un viaggio nelle palestre dell’Avana, tra palazzi fatiscenti, Hemingway e giovani promesse (anche femminili).
Le foto sono di Valerio Corzani, l’autore di questo articolo.
Valerio Corzani
Valerio Corzani è presentatore, autore radiofonico e critico musicale. Voce di Radio 3, collabora con «Il Manifesto» e Bloogfoolk.
newsletter
Le vite degli altri
Le vite degli altri è una newsletter che racconta di vite che non sono la nostra: vite straordinarie, bizzarre o comunque interessanti.
La scriviamo noi della redazione di Lucy e arriva nella tua mail la domenica, prima di pranzo o dopo il secondo caffè – dipende dalle tue abitudini.
Contenuti correlati