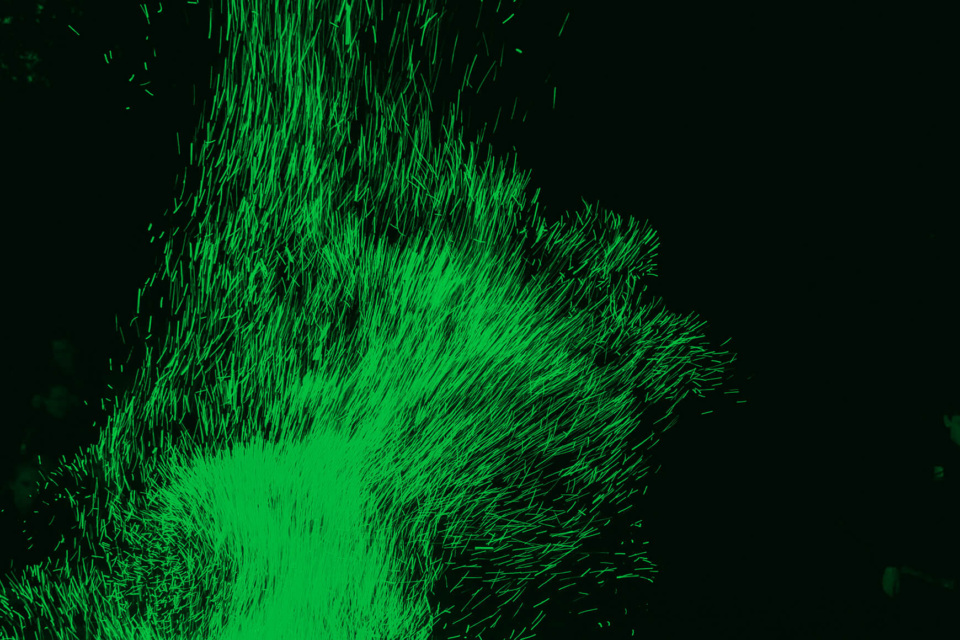Dalla posizione in cui ci troviamo, è difficile non provare impotenza e frustrazione di fronte alle immagini che arrivano da Gaza. Cosa fare? Come essere d’aiuto?
Verso la fine dell’estate, ero a cena a casa di due amici palestinesi. Avevano preparato la Qedra per festeggiare il compleanno di uno dei due. Stavamo scherzando, come spesso accade con le persone provenienti da quella terra. I palestinesi possiedono un umorismo intriso di fatalismo che ricorda molto quello napoletano; se i secondi sono stati costretti a convivere con un vulcano attivo e gorgogliante, i primi condividono una diversa ma analoga condizione di precarietà. Entrambi, napoletani e palestinesi, hanno affrontato questo permanente stato di incertezza con ironia beffarda.
Quella sera raccontavano di un generale giordano che commentava quotidianamente l’invasione a Gaza su Al-Jazeera, ironizzando sul fatto che la Giordania non è mai stata in guerra, e che quindi l’ufficiale esperto era di fatto stato insignito di quel ruolo proprio in virtù della sua inesperienza.
Tuttavia, quando la tv l’ha sostituito con un vero militare, tutti hanno cominciato a rimpiangerlo, perché quella sottostima della ferocia faceva bene ai palestinesi. Mentre si conversava, fumando assieme la shisha, uno dei due mi ha confidato che la sorella era entrata in travaglio a Gaza. Ero profondamente in imbarazzo: non sapevo cosa dire, quali domande fare (sarebbero state lecite? O indiscrete?) e soprattutto, quando dopo qualche giorno le cose si sono complicate, come chiedere. La bambina non voleva saperne di nascere: “Mia sorella dice che la bambina sa che nascere a Gaza in questo momento non è una buona idea, e sta procrastinando come può”. Per un paio di giorni non ha funzionato la connessione telefonica, e quindi non c’erano novità. Poi, finito il liquido amniotico, era chiaro che non c’erano i mezzi e le condizioni per operare un cesareo e mancavano le pastiglie di ossitocina necessarie a indurre il parto
La bambina, fortunatamente, è nata in buona salute, e mi è sembrata la prima buona notizia arrivata da Gaza negli ultimi due anni. In quei giorni inquieti ho smesso di pensare al quadro generale; riuscivo a rivolgere i miei pensieri e la mia attenzione solo a quella vicenda privata che mi angosciava. Mai come in quei giorni ho sentito con tanta intensità il peso di ciò che stava accadendo. E tutto questo mi ha portato, ancora, a chiedermi: quello che succede a Gaza quanto mi riguarda? Cosa dice di me? Cosa mi insegna? E anche se chiederselo così suona quasi un atto di egomania, credo sia necessario un atto di franchezza sulle emozioni che ci attivano, sull’empatia e sui rapporti di potere che generiamo di conseguenza.Ma tutto questo mi ha – ancora una volta – fatto interrogare su cosa ci dice Gaza, su cosa ci insegna di noi. , Più che narcisistiche, queste domande mi aiutano a collocarmi in un contesto così distante, e oggi forse ha senso non solo interrogarci – io, noi – sui sentimenti di empatia o compassione, o rabbia che Gaza ci suscita, ma anche su cosa ci lega a quanto sta succedendo nella striscia di terra che da due anni sta subendo ogni forma di distruzione umana, materiale e immateriale, e che oramai quasi tutti – tranne pochi detrattori – chiamano genocidio.
Inoltre, mai come in questi giorni, la seconda domanda, incredibile, riguarda cosa possiamo fare dalla posizione in cui ci troviamo rispetto a quanto accade. Quella sera, avevo chiesto loro di dirmi come placare il mio senso di impotenza. La risposta era stata serafica: “continua a fare ciò che fai e che hai sempre fatto, anche per la Palestina”. Ma può essere davvero questa l’unica risposta? Come si può mantenere un moto perpetuo di agire se ciò che vediamo quotidianamente ci restituisce uno spazio indicibile? Che rapporto possiamo instaurare con ciò che vediamo?
John Berger, scrittore e critico d’arte (anche se lui avrebbe rigettato quest’ultima definizione), ci ha insegnato che l’atto del guardare è determinato da ciò che sappiamo: lo sguardo non è mai innocente. Lo rileggo e ripenso alle sue parole perché il problema oggi non è più ciò che ci passa sotto agli occhi, ma ciò che sappiamo di quello che ci passa sotto agli occhi. In questo quadro, accediamo a ciò che accade a Gaza con differenti modalità e stimoli, ma indubbiamente il principale sono le immagini: c’è la Gaza del massacro quotidiano, che viene restituita dal filtro opaco di Instagram che protegge la nostra impressionabilità con un rassicurante blur e una richiesta di acconsentire: “Vuoi vedere questo video? Le immagini potrebbero urtare la tua sensibilità”. Le immagini più crude, ora, le vediamo solo se le vogliamo vedere. Sono interi fotogrammi che da 720 giorni ci inseguono nelle nostre case, al lavoro, quando camminiamo per strada, quando beviamo una birra con gli amici. Sono corpi mutilati e denutriti; sono corpi umiliati, imprigionati, bisognosi, sono voci che chiedono aiuto. Che fare di quelle immagini? in che modo ciò che vediamo ci restituisce il senso di ciò che accade?
Soprattutto: cosa sappiamo davvero? Abbiamo solo fonti dirette, non mediate (apparentemente), visto che quelle giornalistiche sono state silenziate: nella migliore delle ipotesi con divieti d’accesso, nella peggiore con la morte. Abbiamo solo le immagini, spesso decontestualizzate, senza un racconto che ci permetta di capire. Ci sono cose che non abbiamo visto che cambierebbero completamente la nostra valutazione degli eventi?
“Queste foto ci paralizzano. L’aggettivo che meglio le definisce è raggelanti. Ne siamo catturati (è vero, c’è chi le guarda distrattamente e passa oltre, ma su di loro non c’è niente da dire). Mentre le guardiamo, il peso di quella sofferenza ci sommerge. Siamo pieni di disperazione o di indignazione. Pur facendoci condividere un po’ di quella sofferenza, la disperazione non porta a nulla. L’indignazione, invece, ci obbliga ad agire. Cerchiamo di riemergere dal «momento» fissato dalla fotografia per tornare alla nostra vita, ma il contrasto è tale che riappropriarci della nostra vita ci appare una reazione terribilmente inadeguata a ciò che abbiamo appena visto” (John Berger, Sul guardare).
Le immagini di guerra, in un presente in cui passiamo la maggior parte del tempo a guardare schermi, ci sembrano l’unica sostanza in grado di dare sostanza al concetto di genocidio. Proprio perché sono moltissime, non ci bastano mai, eppure ci sembra sempre di perdere la visione di insieme a fronte del loro accumularsi. L’oggetto e i soggetti guardati però restituiscono effetti molto differenti. Quella stessa materialità diventa affascinante se guardata dagli occhi di chi mette in atto quella distruzione. Quello che accade a Givat Kobi ne è un esempio crudele Su questa collina a poca distanza da Sderot, pagando cinque shekel, si può ottenere un cannocchiale che permette di assistere alla distruzione di Gaza in tempo reale. Lo stesso fotogramma impresso nella pagina instagram che mi suscita quel dolore e quell’indignazione è visto attraverso le lenti di un cannocchiale a Sderot. L’occhio registra la stessa cosa, ma gli effetti emotivi che la visione suscita sono opposti.
Per spiegare come lo stesso frammento di realtà diventi due cose differenti, la metafora ottica mi sembra la più funzionale: c’è però un problema di messa a fuoco, che permette costantemente ai detrattori di demistificare le battaglie, di demolirne gli obiettivi, di depotenziare la forza politica di ciò per cui si combatte. Noi qui siamo distanti fisicamente – e non solo – dalle colline che guardano Gaza.
Per vedere necessitiamo però di un meccanismo fisico, ossia l’insieme di quei fenomeni legati alla luce e alla sua propagazione, l’interazione con la materia e percezione da parte dell’occhio.
“John Berger, scrittore e critico d’arte (anche se lui avrebbe rigettato quest’ultima definizione), ci ha insegnato che l’atto del guardare è determinato da ciò che sappiamo: lo sguardo non è mai innocente”.
Una parte dell’ottica ragiona sulla luce come raggio rettilineo, che può fare alcune cose: quando un raggio luminoso colpisce una superficie riflettente, come uno specchio rimbalza come un angolo uguale a quello di incidenza, e l’immagine torna fedele. Ecco, da 720 giorni, non c’è un’immagine che sia davvero frutto di una riflessione, nulla di ciò che vediamo torna come dovrebbe. La distanza tra il qui ed ora (anche dalla piazza del 22 settembre e le case di coloro che non c’erano) cambia l’angolo della luce e deforma l’immagine.
Si parla perciò di rifrazione, perché ciò che vediamo ci arriva con una luce filtrata da un mezzo all’altro, come quando immergiamo qualcosa nell’acqua e lo guardiamo attraverso il bicchiere. Ciascuno di noi riceve da due anni immagini che vede attraverso la propria lente, e per questo è difficilissimo capirsi, perché si vedono cose differenti, anche di fronte all’orrore. Le ideologie giustificative producono rifrazioni tali che gli stessi episodi sono prova provata per l’una e l’altra parte. Ci sono poi altri due fenomeni interessanti: l’interferenza, ossia quando due o più onde luminose si sovrappongono, possono rafforzarsi (interferenza costruttiva) o annullarsi (interferenza distruttiva).
È il caso delle alleanze, delle possibilità di guardare nella stessa direzione.
C’è poi la diffrazione, ossia la capacità della luce di “piegarsi” attorno agli ostacoli o di allargarsi passando da una fessura stretta. Pensiamo a come arrivano le informazioni oggi, a come si è deciso di manifestare nonostante le nuove norme sul dissenso, di come a fronte di una grande repressione, le piazze sono piene. Infine, c’è la polarizzazione, ossia quell’effetto per cui la luce, come onda elettromagnetica, oscilla in varie direzioni. Con la polarizzazione si seleziona una sola direzione di oscillazione. Scegliamo solo una parte della visione: gli scontri in stazione e non la manifestazione di Milano con 50.000 persone; gli ostaggi non restituiti anziché i 70.000 morti, di cui almeno 20.000 bambini. Oppure le battaglie si fanno quotidiane e piccole: la barca scelta da Greta Thunberg. il dissing di Enzo Iacchetti: “Sei uno stronzo, ora vengo giù e ti spacco la faccia!”
L’ottica, intesa come fisica del guardare aiuta a dare nome a questo meccanismo. Ogni immagine è una scelta di messa a fuoco, profondità di campo, esposizione. Ogni azione concreta – dalle piazze, alle proteste, ai concerti, ai dibattiti – produce però, in modo quasi caleidoscopico, nuovi sguardi. La macchina mediatica mette a fuoco l’evento più luminoso, che può essere di volta in volta un attacco, una dichiarazione, uno scontro e lascia fuori fuoco il resto: la vita quotidiana sotto assedio, le reti di cura, la ripetizione dei giorni, la morte nella sua quotidiana moltiplicazione. Con il diaframma spalancato per catturare la scintilla la profondità di campo si restringe: Gaza si riduce a “conflitto”, la Freedom Flotilla a “provocazione”, a “white saviour”, le piazze a “disordini”. Chiudere il diaframma, cioè rinunciare a un po’ di luce immediata per guadagnare contesto, restituisce un paesaggio leggibile: il mare e confini del blocco navale, la logistica degli aiuti e discorsi della diplomazia, ancora il passato coloniale e il presente neo-imperialista, le genealogie di oppressione e pratiche di resistenza nello stesso fotogramma. Ma la sola tecnica non basta: servono correzioni di linguaggio.
Guardare una foto che ci mostra un momento di agonia può distogliere la nostra attenzione da un problema più generale e pressante: le guerre di cui vediamo le immagini sono in genere combattute – direttamente o indirettamente – in “nostro” nome. Se ciò che vediamo ci fa orrore, immediatamente dopo dovremmo reagire alla nostra mancanza di libertà politica. I sistemi politici attuali non ci concedono alcuna possibilità legale di influire concretamente sullo svolgimento delle guerre combattute in nostro nome. Rendercene conto e adoperarci di conseguenza sarebbe l’unico modo efficace di reagire a quel che ci viene mostrato dall’immagine fotografica. (John Berger, Sul guardare).
Chi sono i nostri nemici? Sono quelli che si occupano del governo di Israele? Sono i paesi suoi alleati? Sono solamente i responsabili più visibili, ossia Netanyahu, Smotrich e Ben Gvir? Sono tutti coloro che prendono parte materialmente alla distruzione di Gaza e della Cisgiordania? Oppure oggi è necessario estendere la divisione anche a coloro che non se ne dissociano pubblicamente, e che sono più cauti nel prendere una posizione pubblica?
La domanda sui nemici non è banale, perché definisce l’orizzonte verso cui guardare (personale, collettivo). L’intensità della definizione può determinare anche come porsi nei confronti del dilemma anti-sionismo e anti-semitismo, può aiutare a chiarire le gradazioni della conflittualità, ma anche determinare come indirizzare le lotte. Si tratta inoltre di un orizzonte mobile, perché in questi due anni sono state tante le trasformazioni pubbliche e individuali, legate alla gravità crescente, ma anche ad un cambio di senso condiviso, ad uno spostamento dell’opinione pubblica.
Allo stesso modo, mi chiedo anche: cosa e chi sostenere? E soprattutto, come e perché agire? La filosofa Judith Butler dice chiaramente che la sopraffazione che subiamo può essere un motore di attivazione. “Agiamo soltanto se siamo mossi a farlo, e ciò che ci muove è qualcosa che ci colpisce dal di fuori, da un altrove, dalle vite degli altri, qualcosa che impone un eccesso a partire dal quale e sul quale agiamo”. Agiamo perché riceviamo il dolore, l’ingiustizia, la violenza del genocidio, che anche se non ci riguarda, ci tocca, e anche se non ci colpisce direttamente, ci riguarda.
Da oramai parecchi giorni sono salpate dai principali porti d’Europa le barche a vela della Global Sumud Flotilla, che cercheranno di forzare il blocco navale di Gaza per portare aiuti umanitarie hanno ricevuto un incredibile sostegno economico, materiale e politico, come nelle grandi manifestazioni di Genova per supportarne la partenza.
Il 22 settembre le piazze italiane si sono riempite di manifestanti che hanno accettato l’invito mosso dai sindacati di base: Blocchiamo tutto!
Quando discuto delle energie della lotta, dove impiegarle in questo tempo in cui io per prima non so cosa fare, come fare, penso spesso al Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Don Chisciotte, protagonista dell’epica che fonda la modernità, non vede i mulini a vento che ha davanti: vede al loro posto i giganti, che sono suoi nemici.
Questa distorsione della realtà che mette in atto Cervantes è però una scelta di sguardo, non riguarda una delirante follia. L’illusione è infatti capace di diventare più vera della realtà stessa. Lo scrive chiaramente Michel Foucault nell’interpretazione dell’opera che compone una delle parti centrali di Le parole e le cose: “Ma se vuole essere loro somigliante è perché deve dimostrarli, è perché ormai i segni (leggibili) non somigliano più agli esseri (visibili). Tutti quei testi scritti, tutti quei romanzi stravaganti sono appunto senza uguali: nessuno al mondo è mai stato a essi somigliante; il loro linguaggio infinito resta in sospeso senza che alcuna similitudine arrivi mai a riempirlo; possono bruciare tutti e per intero, la figura del mondo non ne resterà cambiata. Somigliando ai testi di cui è il testimone, il rappresentante, l’analogo reale, Don Chisciotte deve fornire la dimostrazione e farsi portatore del segno indubitabile che dicono il vero, che sono il linguaggio del mondo”.
Pensiamo a quanto oggi il diritto internazionale descriva un mondo in cui le ingiustizie possono essere prevenute, i diritti tutelati e puniti, di come quella grammatica abbia costituito il linguaggio del mondo che conosciamo, eppure gli esseri visibili ci raccontano un’altra storia, un’altra parte del mondo, una verità che ci chiede altri fronti di lotta.
I mulini a vento sono perciò l’emblema di tutti i “nemici invisibili”: il potere anonimo, l’ingiustizia sistemica, i fantasmi interiori, ma anche di quella parte di realtà dolorosa che non ci permette davvero di fare qualcosa. Don Chisciotte li affronta con coraggio sproporzionato: sebbene sembri folle, nella sua ostinazione c’è anche la radice di ogni lotta per cambiare il mondo, così come nelle anziane che vogliono boicottare le farmacie, o in coloro che hanno intrapreso la via del mare per un’azione di disobbedienza civile che parte con la prospettiva (molto probabile) di fallire. Distinguere i giganti dai mulini a vento, o scegliere di combattere i mulini per frenare i giganti, avere fiducia in quelle azioni è davvero una questione di sguardo, di vista e di luce. Ma è anche l’unica strada che ci rimane, oggi, quando tutte le battaglie sensate (quelle istituzionali, quelle giuridiche) sembrano essere fallite, inutili o inefficaci.
Ci si sofferma su dettagli molto piccoli, dimenticandosi del senso dell’insieme. Come la miopia che affligge chi della giornata del 22 settembre vede solo gli scontri e i tafferugli (pochi, pochissimi) e perde di vista il più grande sciopero generale in Italia indetto per motivi politici da quello del 16 marzo 1978 per condannare il rapimento di Aldo Moro.
Uno sciopero arrivato tardi, forse, ma per chi come me ieri era in piazza, è stato giusto. Perché se è vero che la disperazione paralizza, l’indignazione obbliga ad agire.
Non siamo fuori campo. Siamo dentro l’inquadratura e decidiamo cosa includere e cosa tagliare, se guardiamo al nostro spazio locale. Se stringiamo sulla Flotilla, Gaza scivola sullo sfondo, e ci sembra di occuparci solo degli attivisti, di perdere la ragione del loro rischiare; se stringiamo su Gaza, spariscono i porti, i camalli e il sindaco di Ravenna che blocca le armi, le piazze europee piene, i tentativi (tardivi) ma in incremento del riconoscimento dello stato della Palestina, le complicità istituzionali. Se invece ci spostiamo, e vediamo il nostro starne ai margini – in termini materiali, di non essere toccati direttamente dalla materialità della violenza – emerge la consapevolezza che molte guerre si combattono in nostro nome; sta a noi misurare il poco o il molto che possiamo fare.
“Chi sono i nostri nemici? Sono quelli che si occupano del governo di Israele? Sono i paesi suoi alleati? Sono solamente i responsabili più visibili, ossia Netanyahu, Smotrich e Ben Gvir?”
Come ha affermato Judith Butler ne L’alleanza dei corpi, “le domande etiche che emergono oggi nei circuiti globali dipendono da questa limitata, ma necessaria, reversibilità dei concetti di prossimità e di distanza. D’altronde, alcuni legami sono già prodotti da questa reversibilità, nonché dall’impasse che la costituisce. E si tratta di una reversibilità che si scontra con la questione della presenza corporea, dal momento che, per quanto possiamo essere pienamente trasportati altrove dai media, di fatto, non lo siamo”.
Ma vale anche il contrario: l’alleanza tra i corpi non può che svolgersi in un’immanenza. Se, come abbiamo visto, siamo mossi da un’obbligazione etica, che qui ed ora ci impone di non restare indifferenti, allora non potendo portare noi stessi in un altrove, non potendo essere corpi di pace, possiamo solo riempire con l’alleanza dei corpi le strade, le piazze, le vie, le stazioni, per portare quell’altrove qui, attraverso quei muscoli, quelle ossa, quei respiri e quegli sguardi che in questo spazio possono restituire alleanza, trasformare i mulini in veri giganti, e provare a sconfiggerli, insieme.