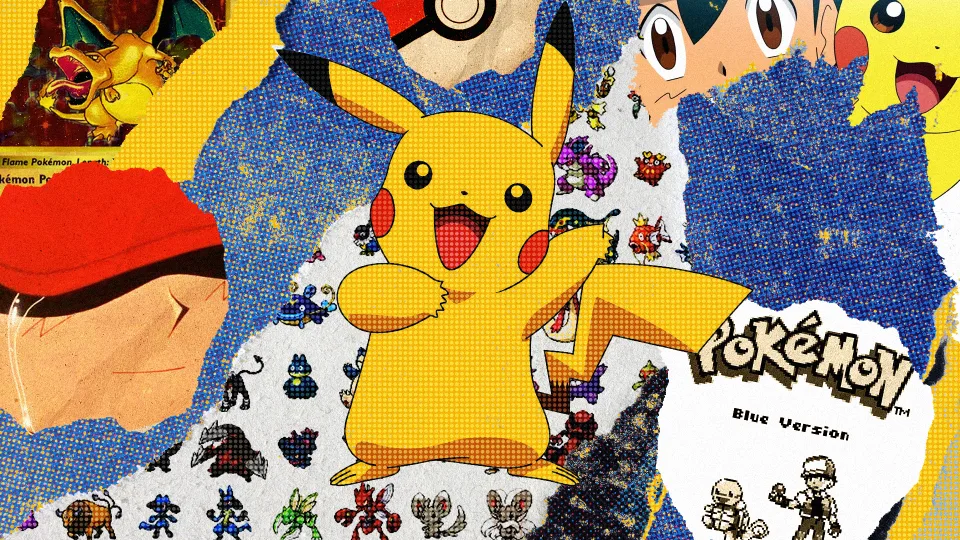Il recente report della United Nations Trade and Devolopment, nel definire i danni del bombardamento istraeliano su Gaza, ha parlato di "abisso prodotto dall'umano". La rottura del consueto gergo diplomatico del documento, oltre a restituire una descrizione efficace della città ormai rasa al suolo, ci dice molto dell'eccezionalità di ciò che sta accadendo in Palestina.
La strada prosegue verso il mare. Tutto è bruciato, ai lati si aprono costantemente crateri. La terra è incandescente sotto la crosta nera. Il manto ha inghiottito ventinove villaggi. Sulle rocce più antiche, a distanza di oltre tre secoli, sono spuntati i primi licheni. Crescono con lentezza esasperante: alcuni studi stimano tassi di crescita di uno o due millimetri all’anno.
Nel processo di sviluppo, i licheni rilasciano acidi organici che corrodono lentamente la roccia, aprendo la strada alla formazione dei primi, sottilissimi strati di terreno. Una volta morti, i loro residui si decompongono e arricchiscono un suolo ancora embrionale. Così, nel corso di molte generazioni, e con un avanzamento impercettibile, trasformano una superficie inerte in uno spazio capace di ospitare vita. Questo processo è noto ai biologi come successione ecologica primaria: la progressiva colonizzazione di un ambiente totalmente vergine. Solo dopo che avranno accumulato abbastanza terreno potranno insediarsi le specie pioniere, ossia i muschi, le erbe tenaci, poi i piccoli arbusti.
Questa scena geologica è il ciclo del rinizio dopo la distruzione, una traiettoria che accomuna tutti i luoghi dove il pianeta è stato portato oltre il suo limite. Il parco Nazionale del Timanfaya è una delle aree con la maggior estensione di terreno oggi inabitabile che, un tempo, erano però abitate. Si trova sull’isola di Lanzarote.
Lo scrittore José Saramago, fuggito dal Portogallo per lo scandalo del Vangelo Secondo Gesù Cristo che era stato censurato e duramente contestato con accuse di blasfemia, si trasferì a dieci chilometri dal parco, e trascorse nella casa di Lanzarote gli ultimi diciotto anni della sua vita in una sorta di autoesilio. Nei suoi diari isolani, scrisse spesso di questo paesaggio. Ne descrive il silenzio, “un silenzio antico, implacabile, che non ammette distrazioni. Chi non lo ascolta, non capisce dove si trova. Timanfaya non è un posto da visitare: è un luogo da sopportare, da accettare dentro di sé come si accetta una verità che non consola”.

Saramago arriva a definirla “la morte stessa della terra”. E, più avanti, fatica a trovare le parole per descriverla: “Timanfaya è l’unico luogo al mondo, tra quelli che conosco, dove il logoro detto secondo cui un’immagine vale più di mille parole acquista pieno significato. In generale, invece, la verità è molto diversa: sono le mille immagini – quali che siano – ad aver bisogno di una parola che le spieghi”.
Se Timanfaya mostra cos’è la terra dopo la scomparsa dell’uomo, Černobyl’ mostra il contrario: la terra dopo l’eccesso dell’uomo.
La vegetazione di Chernobyl è sopravvissuta al disastro nucleare, recuperando gradatamente il territorio dopo l’abbandono di chi ci viveva, ma ha subito notevoli mutazioni per via delle radiazioni. Esempio emblematico è la Foresta Rossa, una zona di pini che inizialmente sembrò morire al punto da assumere un colore rossastro a causa dell’elevato assorbimento di radiazioni. La zona di esclusione è invece una città che continua a esistere come se qualcuno dovesse rientrarci da un momento all’altro. A Pripjat’ è diventato celebre l’ottovolante giallo, rimasto fermo e in qualche modo immagine simbolo della ricreatività scomparsa dopo il disastro. Gli edifici residenziali, grigi, a pannelli, hanno finestre aperte che sbattono al vento. Le scuole sono chiuse dal 1986: quaderni aperti, lettini metallici ad arrugginire negli asili, maschere antigas appese alle pareti. Le piante sono riuscite a sopravvivere e a colonizzare l’intera Zona di Esclusione, crescendo anche tra le rovine delle case e le infrastrutture abbandonate. Gran parte degli abitanti si sono trasferiti nel quartiere Troieshchyna di Kyiv, ricevendo una casa in assegnazione, in quella che viene chiamata informalmente “Via Chernobyl”. Molti di loro sono oggi sotto le bombe del conflitto con la Russia.
Un’intervista di Svetlana Aleksievic, nella sua Preghiera per Chernobyl, racconta come è iniziato tutto: “Pare ci sia un incendio alla centrale. Hanno ordinato di tenere la radio accesa”. Mi sono dimenticata di dire che abitavamo a Pripjat’, vicino al reattore. Me lo vedo davanti ancora adesso: un bagliore diffuso color lampone chiaro, il reattore sembrava essere illuminato dall’interno. Non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana luminescenza. Di bell’effetto. Non avevo mai visto niente del genere, neanche al cinema. La sera eravamo tutti sui balconi, chi non aveva il balcone andava dagli amici, dai conoscenti. Noi eravamo all’ottavo piano, una visibilità eccezionale. Si portavano fuori i bambini, li si prendeva in braccio perché vedessero anche loro: “Guarda! Una cosa che non si dimentica!”.

Se il Timanfaya mostra un pianeta senza umani, Černobyl’ racconta il pianeta dopo il passaggio degli umani, dopo l’abbandono, di chi è riuscito a fuggire (o a sopravvivere). Non si tratta degli unici paesaggi di distruzione, ma di quelli che ne rappresentano la persistenza, la perseveranza, luoghi dove non è ancora possibile l’opposta, perché speculare, azione umana: la costruzione.
Hiroshima e Nagasaki, dopo le bombe atomiche apparivano infatti devastate ma vitali: “La città era bruciata, eppure non era morta. Era un paesaggio che respirava dolore”, scrisse il poeta Hara Tamiki. Il processo di elaborazione dell’uso dell’atomica aveva prodotto un meccanismo difensivo, per cui tali luoghi dovevano rappresentare un precedente irripetibile da cui si sarebbe appresa la lezione. La tecnica sarebbe stata al servizio dell’umano, non viceversa. Nel frattempo, le due città hanno avuto una nuova vita, e hanno elaborato la memoria della propria tragedia rendendola la spinta per una rinascita. Ma quanto accaduto nel 1986 racconta quanto sia vero ciò che sosteneva Gunther Anders, ossia: “L’umanità che tratta il mondo come un mondo ‘da buttar via’, tratta anche se stessa come un’umanità ‘da buttar via’”.
E oggi, quando parliamo di ferite dell’umano, quando pensiamo a quelle fratture etiche e materiali, non possiamo non parlare di Gaza. Se la natura e la tecnologia mostrano come la terra reagisce alla scomparsa o all’eccesso degli abusi dell’uomo, Gaza ci mostra qualcosa di diverso: un abisso prodotto intenzionalmente, dove la distruzione è una precisa strategia politica: l’umano – troppo umano – su questa terra ha prodotto deliberatamente l’inabitabilità. Nei paesaggi attraversati fin qui, infatti, la distruzione, per quanto radicale, non coincide mai del tutto con l’annientamento delle condizioni di esistenza di un luogo. Gaza, a partire dall’ottobre 2023, segna invece un cambio di regime. Le analisi di Forensic Architecture mostrano come l’azione militare israeliana operi attraverso una sistematica riorganizzazione spaziale del territorio: corridoi, zone di esclusione, evacuazioni ripetute, distruzione coordinata di infrastrutture agricole, idriche, sanitarie e di soccorso. Questo insieme di pratiche, lette nella loro ripetizione e nel loro accumulo, produce un effetto preciso: la distruzione delle condizioni materiali, sociali e giuridiche della vita. Gaza non è così un luogo devastato dalla guerra, ma uno spazio intenzionalmente reso non ricostituibile.
Il recente report della United Nation Trade and Development (UNCTAD) sullo sviluppo economico dei territori occupati palestinesi, reso pubblico il 25 novembre, ha stimato i danni prodotti da due anni di bombardamenti su Gaza. Il lavoro, pubblicato nei giorni dell’approvazione della controversa “Pace di Trump” dalle Nazioni Unite, afferma che: “The military operations have significantly undermined every pillar of survival, namely, food, shelter and health care, as well as governance, and plunged Gaza into a human-made abyss, without a respite in sight. The sustained, systematic destruction casts significant doubt on the ability of Gaza to reconstitute itself as a liveable space and society”.
Il testo presenta elementi di novità: UNCTAD sceglie di parlare di “Abisso prodotto dall’uomo”, ricorrendo a un lessico che si discosta significativamente dallo stile usuale – tecnocratico, avalutativo – dei report internazionali. Gli estensori, chiamati a valutare costi e tempi della ricostruzione, hanno esaurito il repertorio neutro e sono ricorsi a un altro campo semantico. Gaza, con la gran parte degli edifici distrutti, per chi scrive il documento non esiste più come luogo di senso, ma solo come spazio abissale. È un momento rivelatore l’evocazione dell’abisso, quasi un “caso di necessità linguistica”: l’istituzione sa che non può più fingere uno sguardo diplomaticamente asettico, e rompe dunque i propri schematismi formali. “Abisso umano”. In qualche modo, dopo due anni di eccidio e di immagini, si realizza la frase di Saramago detta per Lanzarote: a Gaza si pensava che la trita formula “un’immagine vale più di mille parole” acquistasse pieno significato. In generale, invece, la verità è molto diversa: sono le mille immagini – quali che siano – ad aver bisogno di una parola che le spieghi”. Il termine abisso deriva dal latino abyssus, e prima ancora dal greco ἄβυσσος ossia “senza fondo”. “Abisso” indica la soglia oltre la quale vengono meno le condizioni minime perché un luogo continui a essere abitabile, dicibile, giuridicamente pensabile.
Per questo l’architetto Eyal Weizman ha parlato di vero e proprio “Spaziocidio”, nel libro che porta lo stesso nome: un lavoro che è stato scritto nel 2009, durante i bombardamenti di Gaza, quando il 15% del territorio era stato già demolito. Weizman ha anticipato qui l’immagine dell’abisso, parlando di “Hollow Land”, ossia terra cava. Chiamare Gaza ‘abisso umano’ significa ammettere che non è più un luogo né più una terra abitabile. L’abisso è l’annientamento delle condizioni di esistenza del diritto stesso, e soprattutto la cancellazione del presupposto essenziale per l’esistenza stessa di un popolo: il suo territorio. L’abisso è stato prodotto, organizzato e strategicamente approfondito.
È umano perché è il risultato diretto di atti politici. E soprattutto, è umano perché le persone gazawi sopravvissute continuano, per paradossale che sembri, ad abitarlo. Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno allagato decine di migliaia di tende ormai logore, in cui sono riparate famiglie sfollate da ormai oltre due anni. Secondo un report delle Nazioni Unite, più dell’80% degli edifici è stato danneggiato o distrutto dai bombardamenti; nella città di Gaza la percentuale sale al 92%, costringendo a nuovi cicli di sfollamenti. In questo senso, l’“abisso prodotto dall’uomo” è un risultato che sottrae la definizione della categoria da ogni disputa giuridica. La parola, scelta con oculatezza, dice una cosa semplice tanto quanto radicale: a Gaza si è compiuta una distruzione tale da rendere impossibile la ricostituzione di una società, ma la ricostruzione di uno spazio altro, senza passato, la “Riviera di Gaza”, una rimodellazione dello spazio e del senso di tale spazio. Sempre Weizman spiega l’intenzionalità di tale processo, per le anomalie architettoniche compiute. Lo studioso parla di “ungrounding”, ‘sradicamento’, ossia l’azione di trasformazione radicale dei primi 10 cm di suolo avvenuto a Gaza. Lo sradicamento si realizza attraverso lo smantellamento della superficie esistente, ovvero le strade, i marciapiedi, i giardini privati. Tutte le linee di proprietà vengono smantellate, non solo gli edifici.
Per Weizman c’è una differenza profonda: i bulldozer hanno trasformato l’area urbana in una sorta di paesaggio lunare, simile a quello rappresentato nel film Dune. Non ci sono tracce di quello che c’era in precedenza: ogni testimonianza vitale è stata rimossa dal suolo, un-grounded.
Il concetto di abisso offre uno spazio di senso non conteso: con una precisione semantica incredibilmente efficace, il documento esce dal pantano in cui per due anni il dibattito si è incentrato: discussioni, che hanno coinvolto moltissimi esperti, sulla definizione normativa, politica e culturale di Genocidio.
La definizione di abisso racconta una forma di distanza, una misura immisurabile, e può trovare un riferimento letterario che la precisa e ne spiega i sottesi. Perciò, per meglio comprendere l’abisso umano del documento, mi sono rivolta al modo in cui alcuni scrittori hanno provato a sondarlo in letteratura.
W.G. Sebald, in Storia naturale della distruzione, ricostruisce come la distruzione sistematica delle città tedesche da parte degli alleati sia stata omessa o non raccontata. Per l’autore, il tentativo di dare forma a ciò che è accaduto ci mette di fronte a un limite linguistico quantomai attuale: cosa succede quando la distruzione diventa così radicale da eccedere le capacità del linguaggio e della rappresentazione? E cosa implica, politicamente e moralmente, questa incapacità di narrare? Nelle pagine della “Storia naturale della distruzione”, Sebald ci mostra come il resoconto tecnico possa rendere perspicua una realtà che il radicalismo linguistico nasconde, si può “gettare lo sguardo nell’abisso di un’anima ben attrezzata di fronte a ogni possibile realtà”. Un abisso molto concreto e poco spirituale: “Sui terreni invasi dalle macerie e sui tratti di strada che un mondo ridotto a cumuli di rovine ha cancellato, compaiono dopo alcuni giorni piste battute, le quali si ricollegano – appena accennate – all’antica rete di comunicazione. Sorprendente è il silenzio che sovrasta le rovine. Sembra non accadere nulla, ma è un inganno, perché negli scantinati perdurano incendi che si propagano, sotterranei, di carbonaia in carbonaia. Molti gli animaletti striscianti. Alcune zone della città puzzano. Sono al lavoro squadre che vanno alla ricerca dei cadaveri. Un odore di bruciato, acre, “immobile” grava sulla città, un odore che in capo ad alcuni giorni verrà sentito come “familiare”.
“E oggi, quando parliamo di ferite dell’umano, quando pensiamo a quelle fratture etiche e materiali, non possiamo non parlare di Gaza. Se la natura e la tecnologia mostrano come la terra reagisce alla scomparsa o all’eccesso degli abusi dell’uomo, Gaza ci mostra qualcosa di diverso: un abisso prodotto intenzionalmente, dove la distruzione è una precisa strategia politica”.
La scrittura che approfondisce l’abisso, non a caso, si sviluppa soprattutto nei testi che hanno raccontato la Seconda Guerra mondiale e l’Olocausto, o nella critica all’assenza di tale racconto. Primo Levi ha obbligato i suoi lettori a “scandagliare questo abisso di malvagità” raccontato nelle pagine de I sommersi e i salvati e a comprendere come esso custodisca, seguendo la metafora marina, i sommersi: Ciò che alcuni scrittori hanno rivelato dell’abisso, ossia il suo essere insieme una frattura, la perdita del mondo, la cancellazione del vivibile, rappresenta oggi una condizione storica concreta a Gaza. L’abisso non più un’allegoria eminentemente letteraria, ma una realtà a tutti percepibile che ci obbliga a fare i conti con ciò che accade proprio stando sul ciglio della voragine.
Lo scrittore indiano Pankaj Mishra, parlando del “mondo dopo Gaza” ha osservato che la sopravvivenza palestinese oggi avviene dentro una “catastrofe amministrata”, un’operazione in cui la distruzione sistematica è un metodo e in cui l’ordine liberale mostra la sua intrinseca incapacità di proteggere ciò che, invece, proclama di difendere.
L’abisso è l’esito di una lunga erosione del nesso tra diritto e giustizia mondiali: entrambi spettatori impassibili che non hanno saputo frenarne la frattura.
Come si sta davanti a questo abisso? La distanza tra l’illusione di pace proposta dall’ordine geopolitico (“pace trumpiana”: ossia una pace coloniale, gerarchica e securitaria) e quello spazio divenuto arbitrariamente inabitabile è una distanza colmabile? Si può ancora pensare alla soluzione dei due Stati se una parte di quel territorio, tanto conteso, è stata resa impossibile da vivere?
Jean Améry, quando parlava alla “miserabile coscienza del suo tempo”, sapeva bene che l’abisso morale non si supera passando per la retorica. “Lascio cadere la mia parola”, scriveva, “per quanto possa valere”. La gettava nell’abisso perché là dove la giustizia è negata, la parola diventa l’ultimo strumento possibile per restituire il crimine alla verità della giustizia. Ma ogni parola gettata nell’abisso è anche un tentativo di risalita: nomina ciò che resterebbe invisibile e restituisce un minimo argine di contrasto alla dissoluzione del senso.
E tuttavia, proprio qui, nell’abisso o a partire dall’abisso, si misura la responsabilità politica del presente, ossia la spinta che obbliga a cercare giustizia dentro l’abisso, e anche ad abitarlo con la vita.
Non c’è gazawi lontano che non voglia tornare, che parla della bellezza della sua città, e di come sarà ricostruita. Non c’è persona che non abbia nostalgia del campo profughi in cui è cresciuto. E in questa distanza sta tutto il lavoro che ci spetta: nominare i crimini, rifiutare l’indifferenza, costruire ancora, ricostruire Gaza come spazio di Palestina e non come spazio altro, abissale. È proprio in questo spazio sospeso – tra l’annientamento materiale e la volontà ostinata di tornare –, che la politica ha il suo compito: rendere ancora pensabile una vita collettiva laddove è stata cancellata. Perché in fondo, come scriveva il filosofo georgiano Mamardašvili, citato giusto in esergo alla preghiera per Chernobyl, “Noi siamo l’aria, non la terra”. E la frase così continua: “Se cessiamo di agire coscientemente, scompariamo”. Come in un abisso.