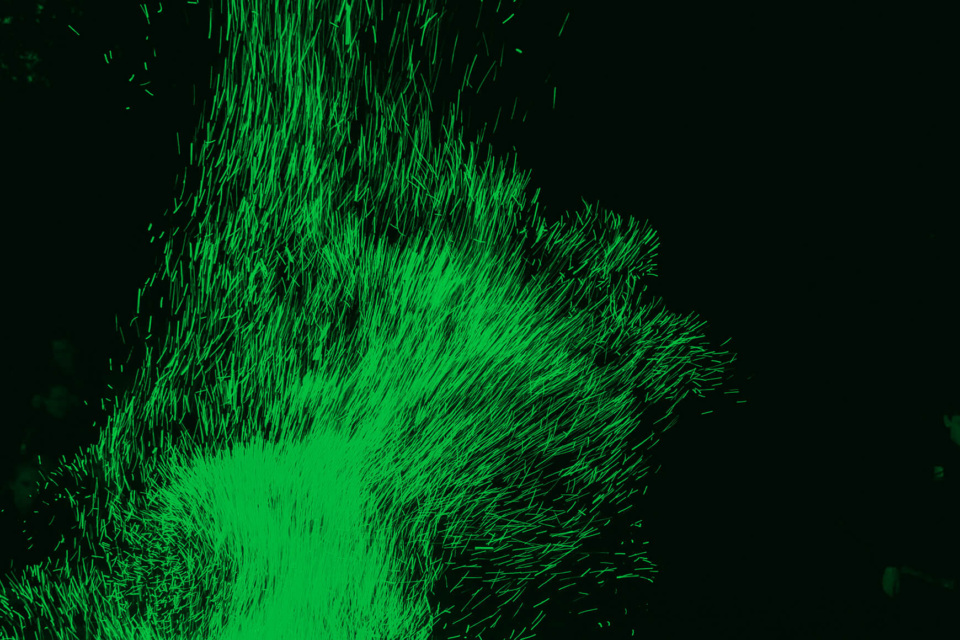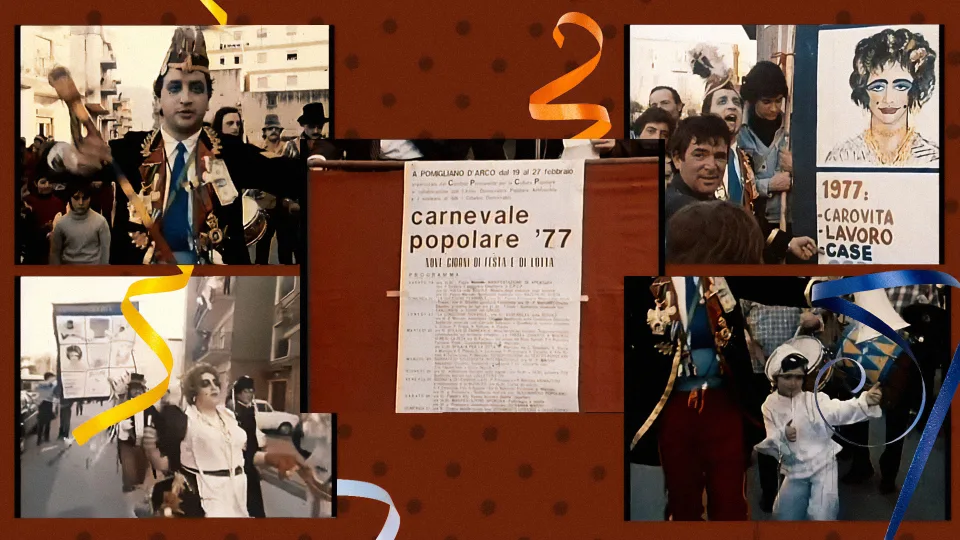Se lo chiede Sofia Torre nel suo saggio-memoir "L'amore no".
Quando il grande amore della mia vita mi lasciò dopo quattro anni romanticissimi e tormentati (o forse romanticissimi perché tormentati), per molto tempo non seppi fare altro che piangere e lamentarmi. Ero pazzamente innamorata di lui, e convinta di aver fatto tutto giusto. Ero stata paziente, leale, vivace. Non me lo meritavo, di essere lasciata così. E invece, “Mi sento soffocare”, mi aveva detto, “mi fai sentire in colpa per tutto”.
Avevo poco più di vent’anni, e per un periodo irragionevolmente lungo – quanto tempo perso, mi sono poi rimproverata –, lamentarmi e piangere sono state, a essere precisi, le uniche attività che mi offrissero un briciolo di conforto. Un piacere che aveva i tratti della catarsi, come se attraverso tutte quelle lacrime, e quelle parole ripetute sempre uguali, io stessi cercando di aprire un varco per liberarmi dalla tristezza che mi abitava, e che minacciava di avvelenarmi.
Nelle rare foto di quel periodo ho sempre una sigaretta tra le dita. Mi cullavo fantasticando scenari in cui lui sarebbe tornato a cercarmi – un ragazzo distrutto, smagrito, logorato dalla mia mancanza – e io gli avrei di certo opposto un po’ di resistenza, ma non troppa. Quel tanto che bastava a rendere ancora più poetico un nuovo abbandono fra le sue braccia.
Lui, ovviamente, non ci pensava neanche. Il telefono restava muto, io mi lasciavo, giorno dopo giorno, inghiottire dai cuscini del divano come se fossero sabbie mobili a cui non potevo opporre resistenza. Tutto quello che fino a quel momento avevo amato, ogni film, ogni libro, sembrava non appartenermi più. Arrivai a domandarmi se quei film e quei libri mi piacessero poi davvero, o se mi fossero piaciuti solo perché piacevano a lui, e mi chiedevo in fin dei conti chi fossi io, dove potessi trovare il mio nocciolo autentico, e se esistesse.
Sofia Torre racconta qualcosa di molto simile. L’amore no – Discorso sul pessimismo post-amoroso, pubblicato da Minimum fax, si posiziona nel felice crocevia che sta fra saggistica e memoir, e prende le mosse da una rottura sentimentale che si fa non solo crollo di un mondo, ma anche di una struttura individuale che fino a quel momento aveva retto, e che poi non tiene più. L’autrice, delusa da un amore da cui si era lasciata travolgere, si sistema nel ruolo della vittima – una parte storicamente ad appannaggio femminile, grazie a soap e melodrammi di varia natura che offrono solidi modelli di riferimento – perché quella è l’unica posizione che le è concesso occupare dopo essere stata lasciata – o l’unica che si porti dietro almeno un briciolo di potere, quello rivendicato dalla buona coscienza: “soffrire significa avere ragione, e la ragione permette di ridefinirsi”.
Il ruolo della vittima può essere confortante, e perciò difficile da abbandonare, perché libera dal peso della propria responsabilità. Alla vittima non viene chiesto di mettersi in discussione né di rispondere dei propri comportamenti; essa gode di uno statuto speciale, protetta da un’aura di intoccabilità per cui ogni domanda esterna rischia di suonare come un’accusa, ogni sollecitazione come una mancanza di empatia. Per quanto fossi sempre triste, non ricordo quei mesi come un periodo difficile: il copione che recitavo ogni giorno era molto semplice, privo di grandi ambiguità.
Innocente per definizione, la vittima attende solo che il tempo lenisca una ferita che le è stata – per statuto – ingiustamente inferta. Lo spiega bene Daniele Giglioli nel suo Critica della vittima (nottetempo), quando scrive: “Perseguitata dalla realtà, l’innocenza si rifugia nell’immaginario, ed è lí che incontra la vittima, perché solo la vittima è autorizzata a dire: non è colpa mia, non è a me che si deve chieder conto. Una vittima non ha debiti, ha soltanto dei crediti”.
In questo quadro, e con la consapevolezza di quanto sia facile cullarsi nel vittimismo, l’obiettivo polemico di Torre è chiaro: l’idea che il sentimento amoroso, e perfino il dolore che segue la fine di una storia, debba essere formativo, edificante. Se, ci dice Torre, è sacrosanto cercare modelli alternativi alla monogamia eteronormata che ci ha cresciuti, dall’altra bisogna anche stare in guardia dalla mortificazione sentimentale di chi vorrebbe incasellare il caos dei desideri all’interno di schemi preconfezionati, efficaci e sempre felicemente produttivi di benessere. L’amore non arriva, o quantomeno non sempre, per migliorarci e traghettarci sulla sponda successiva della nostra evoluzione identitaria. Al contrario, molto spesso lo smacco per una storia che finisce – ma anche la fatica per una storia che arranca – ci lascia del tutto impotenti e disorientati, privi di quel lucido senso di autodeterminazione che ci fa alzare alle sette per andare in palestra o che ci consente di rispettare scrupolosamente gli undici step della skincare coreana.
Siamo circondati di vademecum su come fiorire all’interno delle nostre relazioni, ma in questa grande illusione positivistica degli affetti spesso si dimentica che l’amore non è un pranzo di gala, ma un sentimento complesso che si innesta su personalità sempre un po’ sghembe, irrisolte. È nevrosi e ossessione e vuoti da riempire. Non è sempre cura e misurata pacatezza, è più spesso uno tsunami, una rivoluzione – e come tutte le rivoluzioni è probabile che si porterà dietro qualche cadavere: a volte ci va male, e il cadavere siamo noi.
Il leitmotiv di matrice cristiana – poi ripreso da molti teorici dell’amore come Fromm e bell hooks – che ci insegna che l’amore è una prassi, e che consiste nel trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi, è carico di buon senso – ma cosa succede se noi per primi non siamo capaci di trattarci tanto bene? Se lo sguardo che ci rivolgiamo non è amorevole e diretto, ma schivo e tormentato? Il sentimento amoroso non aumenta la nostra agency, non ci trasforma quasi mai nella versione migliore di noi stessi che vogliono venderci su Instagram. Una parola sbagliata, uno sguardo mancato, un ghosting improvviso e non c’è empowerment che tenga: la nostra esistenza muta di segno, la nostra pelle si fa sottile, tutto diventa ferita. Ci manca solo sentirci in colpa per il nostro stesso dolore.
Il postcapitalismo in cui viviamo ha dipinto uno scenario sociale che richiede un’ottimizzazione costante del nostro tempo, delle risorse emotive di cui disponiamo, dei nostri stessi corpi. Scrutiamo chi ci invita a bere una birra in cerca di red flag cui concediamo lo stesso valore epistemico degli assiomi geometrici, applichiamo l’esasperante lessico psicologico all’analisi dei nostri flirt nel tentativo (fallimentare) di governarne l’imprevedibilità, ci affidiamo perfino alle mani incerte dell’astrologia: ha la luna in Toro, non fa per me.
Siamo terrorizzati all’idea di soffrire e convinti che sia possibile innamorarsi scansando il rischio di rimanere col cuore in panne. Rivendicare, come fa Torre, sia la libertà di innamorarsi senza fare il calcolo dei costi e dei benefici, sia il potere curativo della sofferenza più disfunzionale (eccolo, il lessico psicologico che ritorna), significa assumere una prospettiva antieconomica e anticapitalistica, che niccianamente interpreta la vita non come accumulo di risorse e conservazione del proprio benessere, ma piuttosto come spreco generoso e come aperta, potente dissipazione di forze in eccesso.
Torre attinge alla cultura letteraria e a quella più pop, e ci offre una carrellata di donne – da Anna Karenina a Emma Bovary fino alla protagonista di Il mio anno di riposo e oblio e de La vie d’Adèle – che soffrono per amore con un senso di abbandono pieno, a tratti riposante come solo certe sconfitte possono essere: “lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d’amore”, cantava Giovanni Lindo Ferretti. In parallelo, Torre srotola sotto gli occhi del lettore la sua infelice storia d’amore – e se fino a un certo punto viene piuttosto spontaneo figurarsi un maschio dall’emotività scarsamente alfabetizzata nel ruolo del carnefice, è poi l’autrice a correggere la nostra immaginazione: l’oggetto d’amore e di struggimento è infatti una donna, dagli occhi azzurrissimi e dai capelli sottili.
Di quanto sia difficile vedere la violenza psicologica all’interno delle relazioni queer, e in particolari lesbiche, aveva già scritto Carmen Maria Machado in quel memoir potentissimo e intelligente che è Nella casa dei tuoi sogni (Codice, traduzione di Monica Capuani). Machado racconta una storia che ha tutti i cliché della relazione tossica mentre smonta, pezzo per pezzo, tutti i miti sull’amore romantico che confondono la vista e rendono difficile riconoscere l’abuso. Fra questi, c’è il grande pregiudizio secondo cui fra donne non sia possibile farsi del male, figlio di un altro grande pregiudizio che vorrebbe tutte le donne sensibili e dedite alla cura emotiva del prossimo. “Ero convinta che il patriarcato ci avesse rese sorelle nel dolore, e invece siamo umane come tutti gli altri: capaci di una crudeltà che non ha bisogno di muscoli per distruggere”, scrive Machado.
Torre si pone nel solco di questo disvelamento, teso a smentire il mito aprioristico della sorellanza e finalizzato a sottolineare, ancora una volta, come il femminismo sia una pratica da studiare e correggere giorno dopo giorno, a volte con fatica. Mentre per le coppie etero esistono copioni ben noti dell’abuso, narrazioni che tutti conosciamo, nelle relazioni sentimentali lesbiche manca spesso un archivio, un manuale a cui fare riferimento. E se non hai neanche un modello per capire cosa ti sta succedendo, il crollo è totale.
Era stata un’amica, S., a tirarmi fuori da quei mesi di geremiadi senza fine. Mi lamentavo perché avevo bisogno di parlare di lui, di pronunciare il suo nome e aggrapparmi ancora per un po’ a quell’amore che mi aveva fatto scoprire chi ero. Ricordarmi quanto fosse stato ingiusto, paradossalmente mi offriva un accenno di speranza, perché mi aiutava a confidare in un futuro in cui l’equilibrio si sarebbe ristabilito e avrei finalmente avuto quello che meritavo. Dopo mesi di abbracci e parole di conforto, però, S. era sbottata: “Senti, l’amore non è un contratto e neanche un premio”, mi aveva detto, “non deve essere giusto. Non ti vuole più, è così e basta”. Mi aveva scossa, ma poi mi aveva aiutata a capire.
Non ci sono per forza grandi lezioni da imparare quando finisce una storia, se non il fatto che siamo capaci di crollare. Ed è in quel crollo che non serve a nessuno — non alla società, né alla nostra carriera, né alla nostra crescita personale — che risiede la verità dell’amore, che “non è necessariamente qualcosa di buono e che assomiglia, piuttosto, al sentimento difficilmente ricambiato e nevrotico che si prova per il cinema, la letteratura e l’arte, alla creazione inconsapevole di fantasmi, malinconia, ispirazioni e nuove idee. L’amore non serve a niente, ma è in grado di cambiarci, in modi inaspettati, non necessariamente positivi e spesso irreversibili”.