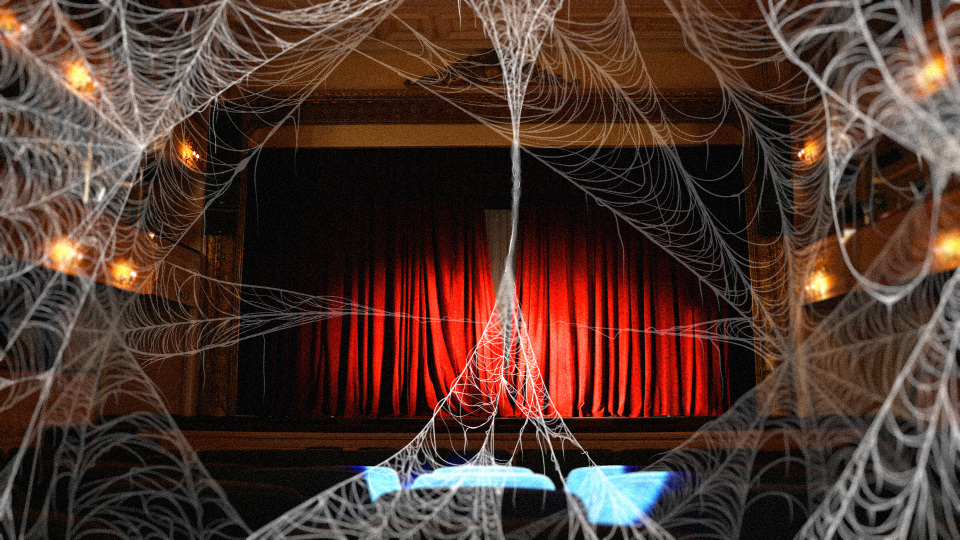Dietro i molti tagli e declassamenti previsti dal Ministero della Cultura c’è una visione ben precisa di cosa debba essere il teatro pubblico in Italia. Una visione che, più che promuovere qualità e pluralismo, sembra premiare conformità e progettualità rassicuranti.
L’estate teatrale, una stagione solitamente festosa e ricca di appuntamenti, incontri e novità, quest’anno è stata funestata dallo spettro dei tagli ministeriali. Una rimodulazione fatta di declassamenti ed esclusioni dai finanziamenti che, a ben guardare, sembra una vera e propria “riscrittura della realtà”: festival e compagnie storiche sono state estromesse o ridimensionate, mentre realtà di medio e scarso livello – a giudizio di buona parte della critica e della comunità teatrale – raggiungono la vetta della valutazione qualitativa. Nonostante a fine luglio alcuni tagli siano rientrati, vale la pena domandarsi: che cosa sta accadendo?
A giugno le dimissioni dei tre membri di minoranza della commissione prosa – l’organo di esperti chiamato a valutare in modo non vincolante i progetti presentati – viene raccontata dai giornali nazionali principalmente a causa del declassamento del Teatro della Pergola di Firenze, che perde lo status di “teatro nazionale”. La notorietà del neo-direttore Stefano Massini certamente fa da volano. Ma come ha modo di ribadire sul Corriere uno dei tre dimissionari, Angelo Pastore, la questione è ben più ampia del caso fiorentino e riguarda la tenuta dell’intero comparto teatrale.
Pochi giorni prima era stata la danza contemporanea a venire fortemente penalizzata, sia in termini di compagnie che di manifestazioni; e successivamente la scure si è abbattuta anche sui festival. A far rumore è soprattutto il ridimensionamento del Festival di Santarcangelo, piazza storica della ricerca teatrale (ma ci sono anche festival interamente esclusi, come Attraversamenti Multipli, e altre realtà storiche come Armunia a Castiglioncello tenute dentro per il rotto della cuffia, con a uno “zero virgola” a salvarli dall’esclusione). Anche se ad oggi diverse di queste valutazioni sono state riesaminate, limitando i danni almeno per l’anno in corso, le scelte della commissione ministeriale sembrano palesemente un segnale politico che vale la pena di analizzare, perché ad essere colpito è soprattutto un settore, quello del teatro contemporaneo. La questione tuttavia è piuttosto complessa, ha radici profonde, e non può essere ridotta soltanto al semplice scontro di visione tra destra di governo e mondo dell’arte, anche se una parte del problema sta proprio lì. Cerchiamo di mettere in fila i nodi principali della questione.
Partiamo dalla questione della visione politica. Il comparto più interessato dai ridimensionamenti è certamente quello del teatro e della danza contemporanei: quelle realtà che lavorano sull’abbattimento dei confini tra i generi (questione per altro “vecchia” nel panorama internazionale) ma anche sulla formazione del pubblico, sul rapporto con la cittadinanza, sulla drammaturgia relazionale e sull’inclusione a vari livelli, dalle questioni di genere alla disabilità. Di colpo ciò che era considerato “premiale” diventa “penalizzante”. Alcune associazioni che avevano presentato domanda con soluzioni di linguaggio inclusivo come lo “schwa” vengono penalizzate a monte. Santarcangelo, che passa da un punteggio di 28,3 su un massimo di 35 – quindi piuttosto alto – a un punteggio di 14, appena sopra la sufficienza, fa discutere. Il paventato ridimensionamento del festival romagnolo ha un valore simbolico per una duplice ragione: da un lato è storicamente legato a una certa idea di teatro contemporaneo; dall’altro, da un decennio a questa parte, ha sposato una linea particolarmente radicale in tema di ricerca performativa e attivismo. Quest’ultimo aspetto, hanno rilevato alcuni commentatori, è stato nel tempo anche oggetto di critica da parte di un pezzo di mondo teatrale: ma è proprio da qui che si evince il carattere “punitivo” del provvedimento ministeriale. Perché un conto è l’esercizio della critica e un conto è la limitazione delle possibilità espressive, compromesse dai tagli (invocati, per altro, persino dalla destra locale che dovrebbe sostenere le eccellenze del proprio territorio). L’equivoco principale risiede nella “valutazione di qualità”: questo parametro, dal punto di vista ministeriale, riguarda un mix di questioni che vanno dalla congruità economica del progetto, alla valorizzazione degli artisti under 35, alle reti internazionali sviluppate. E pur essendo presente una sottovoce piuttosto vaga legata alla “qualità della direzione artistica”, di fatto il tutto si traduce in una valutazione di conformità tra il progetto presentato e i suoi obiettivi, alla luce di una serie di comparti da valorizzare. Non ha quindi a che vedere con un giudizio sulla programmazione che, semmai, è materia che interessa i Cda delle singole istituzioni e il rapporto di queste col proprio pubblico. Altrimenti il Ministero finirebbe per trasformarsi in una specie di direttore artistico “abnorme”, che intende indirizzare per intero il gusto degli italiani, anziché orchestrare e armonizzare le tante pluralità di cui è composta la scena.
Il 30 luglio l’emergenza che riguarda Santarcangelo rientra, almeno per l’anno in corso: da quanto si apprende lo storico festival, così come anche Armunia, riesce a compensare il taglio qualitativo grazie ad una serie di altri parametri quantitativi. Ma la questione resta in piedi. Non solo perché molte altre realtà storiche della scena sono tuttora a rischio, ma anche perché le valutazioni ministeriali sembrano essere il segnale di un cambio di paradigma. Gli effetti si vedono anche sulle stabilità teatrali, con la valutazione a segno meno del nazionale dell’Emilia Romagna e del Metastasio di Prato, che sono tra le istituzioni che maggiormente hanno contribuito a sostenere le compagnie indipendenti e la scena contemporanea. Dal punto di vista delle zone che scontano una dimensione periferica, invece, appare davvero arbitrario l’accanimento sulla regione Sardegna, penalizzata in più comparti. Sempre il 30 luglio viene confermato il declassamento della Pergola, ed è giusto sottolineare un paradosso: secondo molti la stagione presentata da Massini è la prima vera stagione di caratura “nazionale”, dopo un decennio in cui il teatro fiorentino ha presentato cartelloni da teatro commerciale. C’è chi ha sottolineato che si tratta di regioni amministrate dal centrosinistra: sicuramente questo ha un peso e rientra nella lettura della strumentalità delle valutazioni. D’altra parte nelle regioni e nei comuni amministrati dal centrodestra abbiamo assistito alla “promozione” di teatri decisamente meno legati all’eccellenza del settore, come lo Stabile di Catania e quello d’Abruzzo (che, per inciso, promuove una rassegna estiva dove compaiono in cartellone i giornalisti Mario Giordano e Pierluigi Paragone insieme per “uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto”). Ma la questione va oltre il sostegno che una maggioranza politica può decidere di fornire a un mondo artistico che avverte come più affine a discapito di un altro – pratica discutibile, perché contraria all’autonomia artistica dei teatranti, ma a onor del vero assai diffusa nel nostro paese. Ciò che preoccupa maggiormente è lo stravolgimento del senso stesso del finanziamento pubblico al teatro, quell’idea di teatro come “servizio pubblico” che aveva sintetizzato Paolo Grassi: un teatro viene supportato dalla comunità come strumento di crescita, di rischio artistico, di maturazione sociale compiuta come un rito collettivo. Come ha sottolineato pubblicamente Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio, con l’indirizzo imboccato dal Ministero il teatro pubblico rischia di cessare di esistere e di trasformarsi in tutto e per tutto in teatro commerciale. La scomparsa del “rischio artistico” tra i parametri richiesti e la contemporanea crescita dell’importanza della congruità economica spinge a privilegiare spettacoli “sicuri” con nomi “sicuri”, imprigionando il teatro nel pantano del già noto (che è spesso rappresentato da un’aristocrazia vetusta e nemmeno troppo eccelsa della scena teatrale, oppure da nomi televisivi e cinematografici che, grazie alla notorietà, possono garantire un immediato consenso). C’è da chiedersi, tuttavia, se ha senso finanziare un’impresa come il teatro pubblico per far confluire denaro dei contribuenti su artisti che sono già ampiamente riconosciuti, che hanno un loro mercato, o addirittura su giornalisti e altri volti noti, semplicemente per sbandierare un “sold out”.
“L’estate teatrale, una stagione solitamente festosa e ricca di appuntamenti, incontri e novità, quest’anno è stata funestata dallo spettro dei tagli ministeriali”.
Secondo Cresco – il coordinamento delle realtà della scena contemporanea che lo scorso 18 luglio ha presentato il proprio dossier alla Camera – quello che si va disegnando è un sistema teatrale dove le realtà più fragili (che sono anche quelle più legate agli artisti di nuova generazione e ai nuovi linguaggi) vengono sistematicamente penalizzate per consolidare le realtà più istituzionali e meno innovative. Cresco sostiene da tempo la necessità di una riforma del settore: si tratta, dunque, di una posizione non conservativa. Ma le nuove linee ministeriali finiscono non tanto per riformare, quanto per aggravare le sproporzioni tra vecchi e nuovi soggetti, e confermare le “rendite di posizione” di quei luoghi istituzionali che sono più direttamente controllabili dalla politica. Insomma, prima ancora che una concezione “di destra” si tratta di una concezione gerontocratica, esangue e – cosa gravissima per il settore teatrale – senza un briciolo di immaginazione.
Tuttavia è proprio qui che si intravede come la questione, in realtà, non sia semplicemente legata alle scelte dell’attuale governo Meloni, ma abbia radici lontane. Già dalla riforma Franceschini, che ha inaugurato il modello dei teatri nazionali, il sistema teatrale pubblico ha proceduto spedito verso l’accentramento, consegnando il grosso delle risorse e del potere produttivo e distributivo nelle mani di poche istituzioni saldamente controllate dalla politica, invece di valorizzare la natura del panorama teatrale italiano, fatto di tante realtà piccole e grandi sparse per il territorio e in stretta connessione con esso. Gli effetti di questa scelta, che finisce per contraddire in nome del controllo politico quelle che dovrebbero essere i pilastri dell’investimento pubblico nel teatro – e cioè l’apertura alle nuove generazioni e ai nuovi linguaggi e la decentralizzazione – si sono visti. Ma anche volendo adottare una prospettiva “opportunista” si può affermare con serenità che si è trattato di un calcolo errato: se un domani, come è accaduto, è la parte politica opposta a vincere le elezioni, non ci si può lamentare se guida un settore fortemente centralizzato nella prospettiva che preferisce, finendo per scardinare il sistema. Vale la pena qui ricordare che i consiglieri di minoranza che si sono dimessi dalla commissione prosa erano espressione degli enti locali.
C’è un altro elemento che sfugge, colpevolmente, alla lettura della contrapposizione destra-sinistra, ed è la perdita di reddito che molti lavoratori e lavoratrici dello spettacolo rischiano di subire o stanno già subendo. Mentre il presidente della commissione cultura del Senato, Federico Mollicone, snocciola dati sulla crescita degli sbigliettamenti, che nulla dicono in realtà sullo stato di salute del settore dal punto di vista dei redditi e dei bilanci, e definisce renzianamente “gufi” tutti coloro che provano a sollevare perplessità, molta gente rischia concretamente il posto di lavoro. Non stiamo parlando – o non solo – di persone che si sono affacciate da poco alla professione, che comunque hanno tutto il diritto di tentare il loro percorso con delle garanzie lavorative come per gli altri settori, ma di artiste e artisti consolidati. D’altronde quello dello spettacolo dal vivo è un settore piuttosto strano, dal punto di vista lavorativo: reso fragile da contratti precari e dall’assenza di un reddito di intermittenza che esiste ad esempio in Francia, istituito proprio a causa della natura peculiare del lavoro artistico, di fatto è un settore in balia delle onde. O meglio, scarsamente considerato. Anche perché sconta il fatto che i principali referenti che il ministero consulta per la gestione e la riorganizzazione del settore sono associazioni come Agis e Federvivo, entità che rappresentano gli imprenditori, gli operatori, gli esercenti e non certo i tecnici e gli attori. Estremizzando un po’, è come se a un tavolo concertativo sul lavoro metalmeccanico si ascoltasse soltanto la parte datoriale e non i sindacati.
Per uscire fuori da questa situazione occorrerebbe – come ha sottolineato Angelo Pastore – rimodulare il sistema teatrale secondo un meccanismo di “vocazione” dei singoli spazi e dei singoli festival, di modo da svincolare i soggetti che percepiscono denaro pubblico da una logica competitiva, indirizzandoli piuttosto su obiettivi di scopo (la danza, le nuove generazioni, la nuova drammaturgia, la tradizione, il rapporto coi territori, etc.). E, dall’altra parte, occorrerebbe ripensare per intero un meccanismo produttivo e distributivo che impedisce agli spettacoli di girare e che spinge all’iperproduzione di nuovi lavori – un altro dei punti sottolineati da Cresco – che fanno poche repliche e intercettano, di conseguenza poco pubblico. Insomma, occorrerebbe svincolarsi da un “criterio dei numeri”, così tanto venerato da destra come da sinistra, fine a sé stesso: non ha senso parlare di congruità economica, sbigliettamenti e produttività se questi stessi parametri finiscono per uccidere gli spettacoli in culla, impedendo loro di girare e incontrare il pubblico (con la sola eccezione, com’è ovvio, delle produzioni di punta dei teatri principali, che possono godere di una rete di scambio). Per fare questo, tuttavia, occorrerebbe smontare il modello centralizzato che tanto la destra quanto la sinistra hanno contribuito a creare, e occorrerebbe ripensare completamente le garanzie reddituali degli artisti, che sono tanto più ricattabili quanto più fragile è la loro condizione economica. Ma, a parte singole voci, questo ragionamento non sembra trovare sponde nella politica italiana.