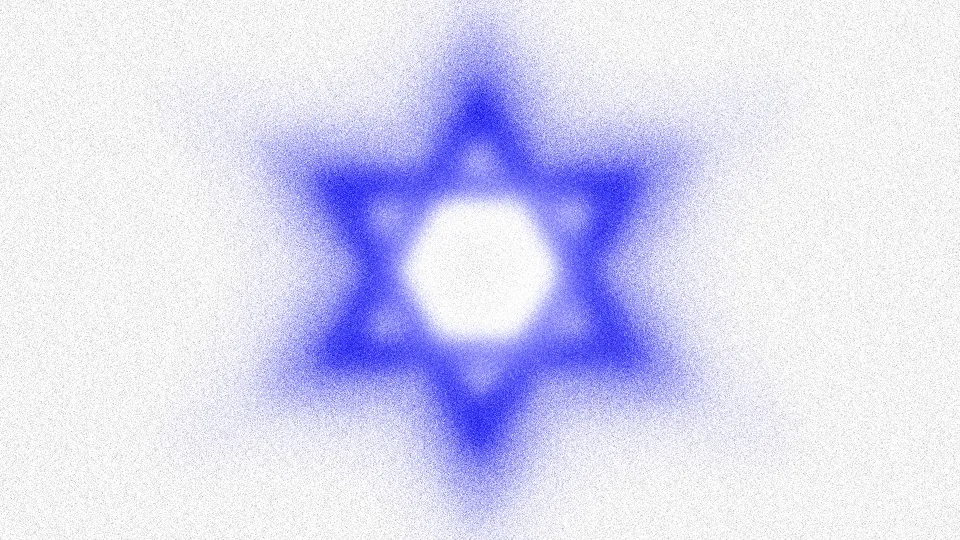Dopo Gaza l’identità ebraica è entrata in crisi? Secondo alcuni intellettuali ebrei, sì.
Nel giugno scorso lo storico e filosofo israeliano Yuval Noah Harari è stato intervistato a Londra da Yonit Levi, giornalista del canale televisivo israeliano 12, e da Jonathan Freedland, scrittore ed editorialista del «Guardian». Harari è noto per una serie di saggi che ripercorrono la storia dell’umanità su archi temporali vastissimi, da migliaia di anni fino all’intera evoluzione della specie. Proprio per questa sua prospettiva di lungo periodo, Freedland gli ha chiesto come inquadrasse i venti mesi trascorsi dalla strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 all’interno della storia ebraica.
Harari ha risposto che ciò che stava accadendo in Israele – o meglio nella striscia di Gaza – rischiava di cancellare e confutare duemila anni di storia dell’ebraismo. La crisi non riguardava la possibile scomparsa fisica dello Stato d’Israele, scenario evocato senza tregua da quanti ritengono che lo Stato ebraico stia combattendo una battaglia esistenziale. Israele, sostiene Harari, sopravviverà grazie a una straordinaria potenza militare e a quella dei suoi alleati, oggi gli Stati Uniti e la Germania in primis, in futuro chissà.
La vera crisi, secondo lo storico israeliano, risiede nella trasformazione di Israele in uno stato fondato su un’ideologia di supremazia ebraica e sul culto della violenza: uno stato che in definitiva nega i valori ebraici per come sono stati tramandati per circa duemila anni dopo la seconda distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Valori tra i quali spiccano lo studio e la passione per l’apprendimento, alla base di una tradizione che ha fatto della riflessione critica e dell’impegno educativo gli strumenti centrali per preservare la propria identità in contesti storici mutevoli e spesso ostili.
Questa lettura coglie un tratto reale della storia culturale ebraica, ma tende anche a cristallizzarlo in una forma quasi atemporale, come se quei valori si fossero mantenuti identici e universalmente condivisi lungo i secoli. Si tratta, in parte, di una stilizzazione retrospettiva: accanto alla tradizione dell’apprendimento e dell’esegesi testuale – indiscutibile e spesso decisiva – la vita ebraica ha sempre incluso una varietà più ampia di pratiche, interessi e orientamenti, non sempre riconducibili a quel canone ideale. Anche questa pluralità, fatta di attività economiche, consuetudini sociali e adattamenti locali, ha avuto un ruolo rilevante nel plasmare le continuità e le trasformazioni dell’ebraismo.
In questo quadro lungo e multiforme, un tema centrale riguarda il rapporto tra ebraismo e potere. Per la maggior parte degli ultimi duemila anni, gli ebrei non hanno esercitato potere politico o militare. Non sono mancati episodi e figure ebraiche associabili alla guerra, ma dopo la distruzione del Tempio l’identità ebraica non si è caratterizzata per una particolare propensione a fare la guerra. Nel Kuzari (1140), uno dei trattati filosofici ebraici più noti del Medioevo, Judah Halevi mette in scena un dialogo immaginario fra il re dei Cazari e un rabbino. Il rabbino rivendica l’amore per la pace del popolo ebraico; il re replica che questa “umiltà” dipende dall’impotenza dell’esilio e che, se avessero potere, gli ebrei “ucciderebbero come gli altri”. Il rabbino, nella finzione letteraria, è costretto ad ammettere: “Hai toccato il nostro punto debole, o re dei Cazari”. Halevi intuì che la tradizione di condotta non violenta non derivava tanto da una qualità intrinseca quanto dalla condizione storica minoritaria e vulnerabile della diaspora, che rendeva l’uso della forza e della sopraffazione difficile se non impossibile.
Molti secoli più tardi, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, il quadro storico era radicalmente mutato, e nuove forme di partecipazione politica iniziarono a prendere forma. In quel periodo la vita ebraica diasporica – soprattutto nell’Europa centro-orientale – si caratterizzò per un ambiente culturale dinamico, mobile, intensamente testuale, spesso plurilingue, con inclinazioni cosmopolite e una forte propensione alla sperimentazione artistica e intellettuale. Un patrimonio che appare oggi in buona misura contraddetto dall’evoluzione marcatamente sciovinista dello Stato israeliano.
Secondo Harari, l’eventuale disastro spirituale non riguarderebbe soltanto Israele, ma l’intero mondo ebraico. Per gli ebrei della diaspora, infatti, diventerebbe sempre più difficile – se non impossibile – sostenere che un ebraismo modellato sulla supremazia etnica non rappresenti ormai la corrente egemone. A giugno lo storico era stato relativamente prudente: non aveva parlato della crisi morale ebraica come di un evento inevitabile o già compiuto, ma come di una mutazione che era ancora possibile scongiurare.
Altri intellettuali ebrei sono più pessimisti rispetto all’ipotesi di una crisi morale dell’ebraismo. Il tema era già emerso negli Stati Uniti soprattutto per merito di Peter Beinart, che lo ha elaborato all’inizio dell’anno in modo esplicito nel pamphlet Essere ebrei dopo la distruzione di Gaza (Baldini + Castoldi). Il punto di partenza della riflessione di Beinart, editorialista del «New York Times» e professore di giornalismo al City College di New York, è l’orrore per l’eccidio commesso da Hamas il 7 ottobre. Nulla giustifica il massacro di civili innocenti.
All’indomani del 7 ottobre, Beinart esamina scritti e discorsi delle frange più radicali della sinistra anti-israeliana, cercando – senza trovarle – tracce di indignazione per il massacro di civili israeliani. La sua solidarietà con gli israeliani non si estende però all’offensiva militare condotta con tutta evidenza non solo per neutralizzare Hamas, ma per infliggere una punizione collettiva alla popolazione palestinese di Gaza. Al di là delle esecrabili politiche del governo Netanyahu, ciò che anima la critica di Beinart è l’esasperazione per il sostegno di una gran parte della diaspora ebraica americana ai crimini commessi durante l’intervento militare israeliano nella Striscia.
L’incapacità di riconoscere che le offensive Spade di Ferro e Carri di Gedeone hanno causato sofferenze immense ai civili e la distruzione quasi totale dell’enclave palestinese deriva, secondo lui, dalla sacralizzazione dello Stato di Israele, considerato come l’espressione più alta della vita ebraica. Beinart è un ebreo osservante e rintraccia nella storia ebraica e nella Bibbia episodi che mostrano come anche “gli ebrei possano essere oppressori”. Li scorge, ad esempio, nel Libro di Ester, dove gli ebrei mettono a morte 75.000 persiani, e nella vicenda della schiavitù di Agar da parte di Abramo e Sara. Per Beinart, questi antichi racconti sono prefigurazioni delle politiche adottate oggi dal governo israeliano e dell’atteggiamento, largamente diffuso nella società israeliana, che giustifica o tollera un numero elevato di vittime civili, la carestia, la pulizia etnica e altre forme di punizione collettiva inflitte alla popolazione palestinese.
Lo scrittore americano non crede dunque a un ebraismo immune dalle tentazioni del potere quando questo è esercitato senza controllo e senza tutele giuridiche per milioni di palestinesi. La critica di Beinart – come quella di Harari – non investe solo lo Stato di Israele, ma l’ebraismo tout court, e in particolar modo quello coltivato da una parte significativa della comunità ebraica americana. Quest’ultima, a suo avviso, ha sostituito i propri punti di riferimento identitari, costituiti dalla religione e dalle tradizioni culturali, con un culto incentrato sullo Stato di Israele, posto al di sopra e al di fuori di ogni critica.
L’immunità a qualunque critica deriva in gran parte dal retaggio di vittimizzazione – in primis la memoria della Shoah – utilizzato strumentalmente per giustificare o ignorare sofferenze altrui. Il risultato è che l’ebraismo rischia di normalizzare pratiche contrarie a principi che per secoli ne hanno plasmato l’identità.
Beinart si augura che gli ebrei adottino “una nuova narrazione per rispondere ai crimini di guerra che un paese ebraico ha perpetrato con il sostegno di molti ebrei in tutto il mondo. Il suo elemento centrale dovrebbe essere questo: non siamo le eterne vittime virtuose della storia. Non siamo stati programmati per patire il male per l’eternità senza mai commetterlo. Quella falsa innocenza, che pervade la vita ebraica contemporanea, dissimula la supremazia come autodifesa. Esenta gli ebrei dal giudizio esterno. Offre una licenza infinita ad esseri umani fallibili”.
Per alcuni versi, Beinart riprende la riflessione del filosofo Yeshayahu Leibowitz, che già all’indomani della vittoria della guerra dei Sei giorni aveva criticato come moralmente corrosiva l’identificazione tra fede religiosa, identità nazionale e dominio sui territori occupati, avvertendo che tale fusione avrebbe finito per deformare dall’interno i valori ebraici e la stessa vita morale dello Stato. Ma Beinart si spinge oltre, mettendo in discussione non soltanto lo Stato di Israele ma l’ebraismo come tradizione culturale quando una parte della diaspora sacralizza Israele fino al punto da rendere impossibile qualsiasi critica anche di fronte a gravi abusi o crimini di guerra.
Vista dall’Europa la riflessione di Beinart è quasi paradossale, poiché nella diaspora statunitense – molto più che in quella europea – si sono aperte da anni fratture profonde sul legame con Israele. Un numero crescente di ebrei americani non riesce più a conciliare la propria identità progressista con il sostegno a un governo che, ben prima del 7 ottobre, era alleato con governi sovranisti e reazionari come quelli di Milei, Modi, Orbán e Trump. Al contrario, in paesi come la Francia, l’Italia, la Germania, dove peraltro i contesti storici e sociologici sono molto differenti, questa dissonanza è assai meno pronunciata: il baricentro politico delle comunità ebraiche, anche influenzato da ciò che accade in Israele, si sta spostando progressivamente a destra e il sostegno allo Stato ebraico – a prescindere dalle politiche che adotta – resta in larga misura ampio e incondizionato.
Ciò non significa tuttavia che manchino voci critiche nelle comunità più conservatrici. Anche in Europa alcuni intellettuali ebrei parlano apertamente di un collasso morale dell’ebraismo. Il giudizio più drastico è quello dello scrittore francese Jean Hatzfeld che, in un recente editoriale su «Le Monde», ha affermato che “nel distruggere Gaza, Israele distrugge l’ebraismo”. Più misurate e analitiche sono invece le posizioni degli storici Esther Benbassa e Jean-Christophe Attias, che nel saggio Israël-Gaza. La conscience juive à l’épreuve des massacres (Textuel, 2024) mettono in guardia, da una prospettiva laica, contro una deriva etno-nazionalista dell’ebraismo: una trasformazione in cui la sicurezza dello Stato ebraico prevale sugli obblighi morali universali, minando sia il diritto internazionale sia le stesse leggi israeliane.
“Harari ha risposto che ciò che stava accadendo in Israele – o meglio nella striscia di Gaza – rischiava di cancellare e confutare duemila anni di storia dell’ebraismo. La crisi non riguardava la possibile scomparsa fisica dello Stato d’Israele, scenario evocato senza tregua da quanti ritengono che lo Stato ebraico stia combattendo una battaglia esistenziale”.
In Italia, contemplare l’ipotesi che, dopo Gaza, l’ebraismo sia in crisi è ancora impegno di pochi. L’“orizzonte morale” della componente maggioritaria della comunità ebraica appare talmente saturato dalla preoccupazione per il crescente antisemitismo da relegare i crimini di guerra commessi a Gaza ad un aspetto marginale, quando non addirittura ad azione ritenuta necessaria per scongiurare un nuovo 7 ottobre. Tra le voci che hanno esplicitamente avanzato l’idea che la reazione israeliana al massacro di Hamas non sia solo una guerra di difesa, ma rappresenti uno scivolamento nell’abisso, spicca quella di Anna Foa, il cui bestseller Il suicidio di Israele (Laterza, 2024) solleva fin dal titolo la questione del decadimento morale di un paese guidato ormai da oltre due anni dagli eredi del rabbino ultra-razzista Meir Kahane, bandito a suo tempo dalla Knesset per incitamento all’odio razziale.
Altri, tra cui Wlodek Goldkorn e Stefano Levi Della Torre, hanno affrontato la questione con interventi puntuali, mostrando come il fatto d’interrogarsi sul cedimento morale in atto in Israele e nel mondo ebraico riguardi una fetta piccola ma rilevante della comunità ebraica italiana, contribuendo a delineare un dibattito sempre più consapevole del rischio di una frattura non più eludibile.
Queste voci non pensano che Hitler stia ritornando sotto le spoglie dell’Iran o di Hezbollah. E si rifiutano di trasformare i recenti atroci crimini di Hamas in un pretesto per bloccare ogni discussione sulle responsabilità di Israele nel conflitto ultradecennale con i palestinesi: per rimodellare l’ebraicità come una corazza difensiva, incapace di dubitare di sé e refrattaria a qualsiasi autocritica, ripiegata in un vittimismo compiaciuto. Preferiscono richiamare un passato ebraico refrattario al conformismo e incline a promuovere confronti piuttosto che a chiuderli. Ne emerge una versione dell’ebraismo come metodo critico: un’abitudine mentale a mettere sistematicamente in questione tutto e a dire verità sgradite quando necessario, quella qualità dell’essere ai margini e dunque di procedere controcorrente che un tempo ci caratterizzava.
A questa tradizione critica appartiene anche il riconoscimento che, quando esercitano potere, gli ebrei – come ogni altro popolo – possono abusarne. Dopo la Seconda guerra mondiale, gli ebrei in Palestina hanno combattuto ed esercitato il potere per affermare la propria autodeterminazione. Ma con la conquista della Cisgiordania dopo la guerra dei Sei giorni e, più recentemente, con la campagna militare a Gaza, l’esercizio del potere israeliano ha conosciuto una trasformazione ulteriore, radicale e oltranzista. È chiaro che anche Israele e gli ebrei, quando si trovano in una posizione di potere, possono vestire i panni del faraone: una constatazione che mette sotto pressione non solo la politica israeliana, ma il rapporto fra potere e identità ebraica così come si è sviluppato lungo i secoli della diaspora.
Leggendo Harari, Beinart e altri si comprende che non basta più dissociarsi da ciò che accade in Medio Oriente come se riguardasse soltanto Israele. L’ebraismo, se vuole essere fedele alla sua migliore tradizione critica, deve applicare quello stesso rigore anche alle politiche messe in atto dal governo israeliano e al sostegno che esse ricevono nella diaspora – dalle operazioni militari a Gaza al blocco degli aiuti umanitari – fino al punto in cui troppi ebrei arrivano a percepire ogni scelta del governo israeliano come parte integrante della propria identità ebraica.