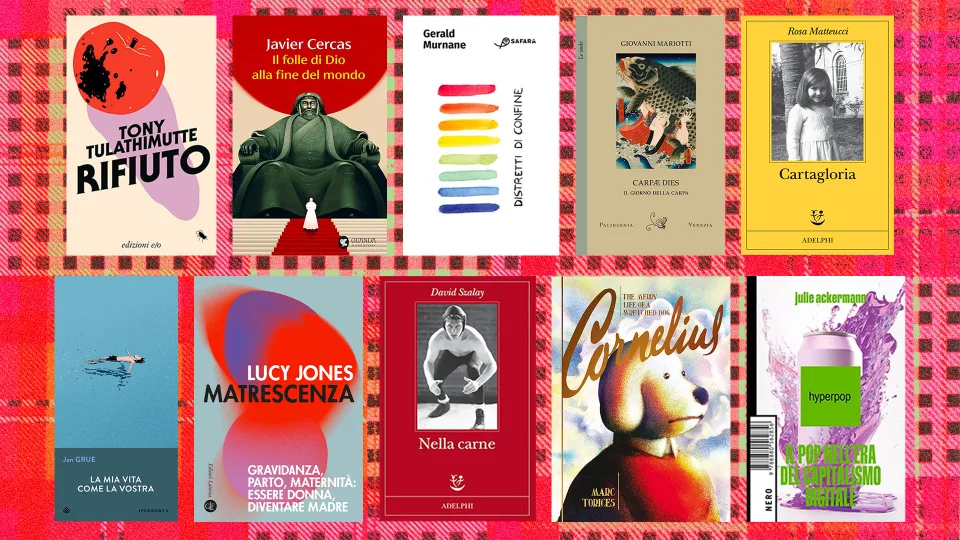Alcuni consigli letterari a cura della Redazione, tra loro diversissimi, dedicati a chi aspetta le feste per poter leggere un po' di più.
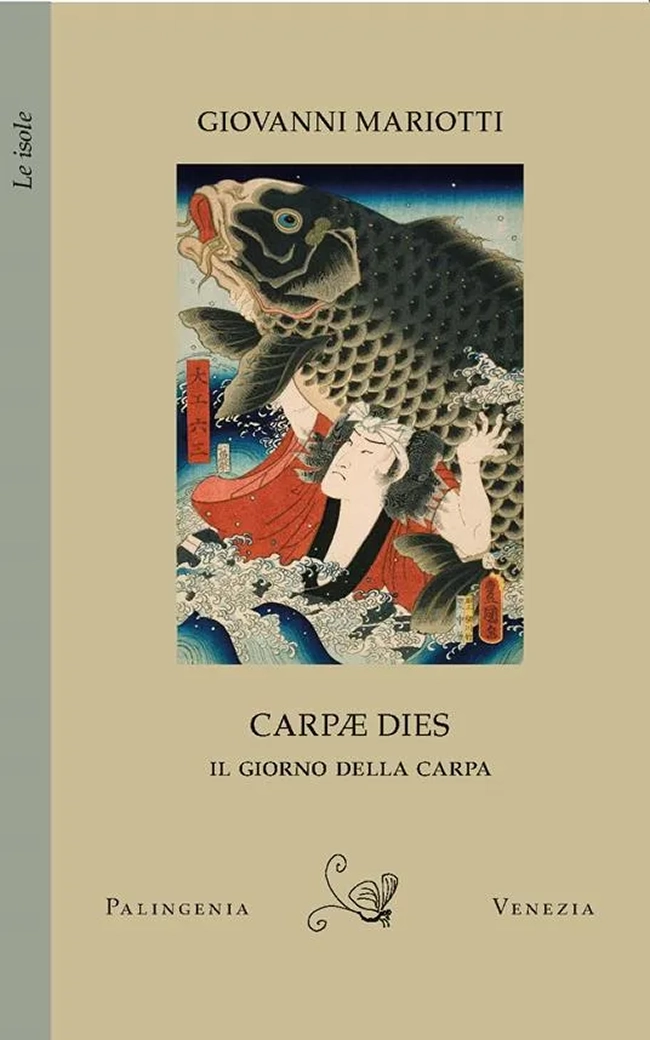
Emiliano Ceresi: Giovanni Mariotti, Carpae Dies. Il giorno della carpa (Palingenia)
Di Storia di Matilde di Giovanni Mariotti, Pietro Citati scriveva essere uno dei romanzi italiani più importanti degli ultimi anni. Quasi una colata, priva com’era di punti di interpunzione, in cui ogni lettore doveva scovare da solo il tempo. Da allora Mariotti, autore poco incline ai clamori, ha continuato ad assecondare un tragitto personalissimo almeno quanto appartato, spartendo il suo scrittoio tra curatele per Franco Maria Ricci, divertissement calligrafici, traduzioni miniate.
A farsi carico della sua ampia ma coerente bibliografia, ci ha pensato Palingenia, editore veneziano da poco nato per iniziativa anche di alcuni transfughi di Adelphi che si sta facendo notare per il gusto nella rilegatura dei propri volumi così come in certi repêchage (meritorio, quest’anno, quello de La tigre viziosa di Sergio Antonelli). La casa editrice ha infatti promesso la ripubblicazione dell’intera opera di Mariotti dispersa in varie sedi – insieme a qualche primizia ancora inedita.
È risalendo per queste sponde che giunge allora Carpae Dies, il nuovo libro di Mariotti, ambientato in un Giappone arcaico, letterario e indeterminato che pare tolto da una pagina di Lafcadio Hearn.
All’interno vi si racconta la storia di Kōji, monaco ritroso (“un talento nel passare inosservato”) e invaghito dei bagliori cangianti delle squame dei pesci, creature di cui ama dipingere i guizzi fissandoli sui rotoli, per poi ri-tuffarle nel loro habitat. Il karma lo “premierà” rendendolo uno di loro e facendogli trascorrere una giornata equorea, non priva di momenti di vanità, per via di una “livrea degna di un imperatore delle acque”. È passando per questo battesimo che Kōji riuscirà a finalmente accantonare le proprie ansie: i turbamenti terreni, cioè, che ne hanno fiaccato la vita nel tempio dove era, specie nel rapporto con gli altri, un pesce fuor d’acqua”, ovvero la trasparente allegoria di uno scrittore.
Di là di una trama assai movimentata, non sono pochi gli elementi che conciliano a stupire leggendo la tutto sommato breve vicenda di quest‘uomo d’acqua dolce che mi ha ricordato, per certi esiti, La verità sul caso Motta di Mario Soldati: qui il grigio impiegato trovava il coraggio di non respirare sotto il mare e, così, scopriva le gioie dell’erotismo prima su un baldacchino di coralli in compagnia di una sirena, poi in una corsa sfrenata a dorso d’un pesce.
In cima, sta la souplesse con cui è scritto il libro di Mariotti, che fa sua la lezione de Lo stile dell’anatra di La Capria: la storia di Kōji passa per continui imprevisti e capovolgimenti di fronte (a mutare è anche la voce narrante), eppure lo stile dell’autore non dà mai mostra di fatiche: la prosa resta all’apparenza placida proprio come lo specchio del lago Awi che, sotto la sua superficie immobile, brulica però di insidie dietro ogni ansa.
C’è poi il vivido manierismo con cui Mariotti aderisce al luogo, o meglio, all’idea tutta letteraria del Paese che racconta: un talento dell’immedesimazione che fa talvolta pensare a modelli illustri: all’eleganza frigida dei reportage asiatici di Parise, per esempio, o al romanzo orientale mimato ad arte da Calvino in Se una notte d’inverno un viaggiatore (anche Carpae Dies è, a ben vedere, il rifacimento di un’opera di Ueda Akinari, maestro della short story nipponica, una tradizione di cui Mariotti è peraltro cultore). La metamorfosi più persuasiva senz’altro quella con cui Mariotti si muta nel protagonista vestendone, volta a volta, i desideri e le aspirazioni; ma non è da meno neppure l’estro con cui lo scrittore allestisce un Giappone quasi da acquarello nel fiorire di metafore e dorature che riesce, proprio per questo, più vero del Giappone
Da ultimo, vi è lo spirito che anima il libro. Nella lettera che accompagna il volume, Mariotti (classe 1936) ammette “scrivendolo […] non ho mai riso, però ho sorriso dall’inizio alla fine, nonostante i malanni dell’età”. E del resto non v’è traccia di risentimento senile in questa storia, anzi, a prevalere è piuttosto un incanto adolescente. Come Pasolini avvertiva proprio nel Calvino più narrativo, quello di Mariotti pare piuttosto “il libro di un ragazzo. Solo un ragazzo può avere da una parte un umore così radioso, così cristallino, cosi disposto a far cose belle, resistenti, rallegranti; e solo un ragazzo, d’altra parte, può avere tanta pazienza – da artigiano che vuol a tutti i costi finire e rifinire il suo lavoro”. In effetti anche in un libro tardo può talvolta affiorare la stessa pazienza di ieri: leggendo, forse non per caso, mi è tornato alla mente un aneddoto su Basho, il grande maestro dell’haiku, su cui Emanuele Trevi chiudeva giusto il suo esordio: “quando basho […] era ormai sul punto di morire, a osaka nel 1694, gli allievi e gli ammiratori gli chiedevano insistentemente l’ultima poesia. i tre versi definitivi – quelli del congedo. ma basho, il saggio basho, non ne voleva sapere. tutte le poesie che ho scritto, rispose agli scocciatori, sono la mia poesia funebre, la mia ultima poesia. come dire: quello che c’era da sapere, lo si sapeva da sempre, o non lo si saprà mai piú”.

Nicola H. Cosentino: Javier Cercas, Il folle di Dio alla fine del mondo (Guanda). Traduzione di Bruno Arpaia
Il folle di Dio alla fine del mondo si apre con il sogno di ogni scrittore: trovarsi una grande storia fra le mani senza dover fare alcuno sforzo d’invenzione. È quello che succede a Javier Cercas nel 2023: il Vaticano lo contatta e gli chiede se sia interessato a seguire Papa Francesco durante il suo viaggio in Mongolia – un viaggio per certi versi eccezionale, in un Paese buddista con appena 1500 cattolici – e a trarne, se riterrà, un libro. Lui cade dalle nuvole: “Ma siete impazziti o che?” risponde. “Non lo sapete che sono un tipo pericoloso?”. Intende che è conosciuto come un intellettuale libero, ateo e anticlericale, ma dal Vaticano insistono: lo vogliono proprio per questo. E allora lui accetta, ma solo a patto che Bergoglio gli conceda, durante il viaggio, cinque minuti tête-à-tête, per una semplice domanda: esiste davvero la vita dopo la morte? Il Papa accetterà.
Come gran parte degli altri libri di Cercas, tutti editi in Italia da Guanda, Il folle di Dio alla fine del mondo è un romanzo ma anche un saggio, una biografia, un’autobiografia, un’inchiesta, un diario di viaggio, un reportage, una raccolta di interviste. Il mega innesto risulta naturale grazie alla capacità dell’autore, fra i più lucidi di questo tempo, di mantenere alta la curiosità di chi legge con pochi, ma gravi, elementi di trama, mentre qua e là solleva questioni storiche, filosofiche, teologiche e politiche su cui tutti ci siamo interrogati almeno una volta. La data d’uscita in libreria, capitata pochi giorni prima della morte di Bergoglio, ha ammantato il romanzo di un fascino testamentario. Il bellissimo finale – oltre alla risposta di Francesco alla domanda sull’aldilà – fa il resto.
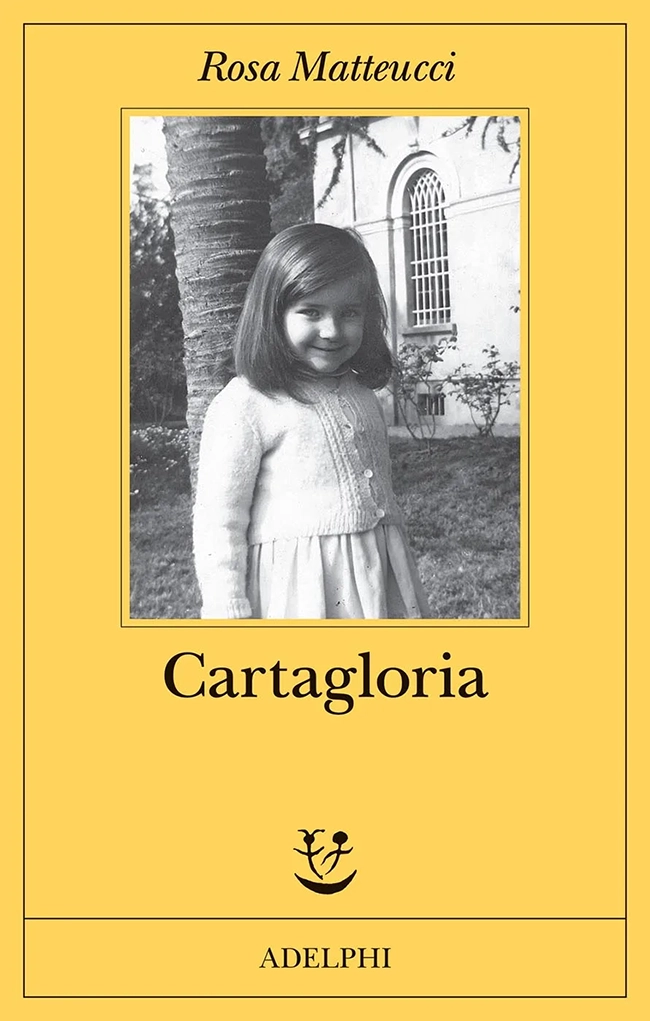
Lorenzo Gramatica: Rosa Matteucci, Cartagloria (Adelphi)
Rosa Matteucci ha un talento per il comico raro e lo conferma nel suo ultimo romanzo non-romanzo, Cartagloria (Adelphi).
Ma il doppio oscuro del comico è ovviamente il tragico e in Cartagloria non manca: il dolore originale è la morte dell’adorato padre scialacquatore, che ispira nella protagonista un senso di ingiustizia, di rivalsa nei confronti di Dio e coincide con l’inizio di una ricerca spirituale caotica e generosa, tra orientalismi e riti tridentini, destinata solo in parte ad alleviarne l’inquietudine.
Questo lutto spezza la vita in due. Prima l’infanzia, con il desiderio intenso di ricevere la Prima Comunione, i giochi e l’amicizia con i cani, gli agi di una villa decadente nella campagne umbre, tra le anticaglie, i ninnoli, le reliquie dei santi, le cornici delle cartaglorie spoglie che molto la attraggono, i nonni, la sorella maggiore, ricche prozie di passaggio, una madre altera e soprattutto questo padre avventuroso e scaramantico; e poi la necessità di sopravvivere senza questo padre, sola in un mondo ormai privo di quello stupore fiabesco che il genitore sapeva suscitare.
“La morte di mio padre mi apparve come il culmine di tutte le sventure che si erano abbattute su di me […] ero cieca dal dolore e dalla rabbia, non avevo occhi per vedere, per quanto scrutassi nel mio cuore, dentro e fuori della mia anima pesta, nulla veniva in mio soccorso”.
Ora: sola al mondo, senza più il padre e nella graduale dissoluzione dell’agio in cui è cresciuta, la narratrice-autrice diviene essa stessa avventuriera. Avventuriera attiva, perché si reca a Lourdes, in India, incontra frati esorcisti, frequenta messe in latino. E avventuriera passiva, perché scopre di essere scrittrice – come Norman Bates, diventa essa stessa il suo genitore, tenendolo attraverso la scrittura a una studiata distanza, che solo in parte ne ridimensiona l’immagine quasi eroica.
Cartagloria si pone quasi come la conclusione di una fase per la scrittrice umbra: riepilogo, messa in fila, sintesi ed espansione della sua opera. Come in un politicco, Cartagloria è costituito da parti tra loro legate ma quasi indipendenti.
Qui ci sono i grandi temi di Matteucci, la cui carriera è iniziata nel 1998 con Lourdes, sempre Adelphi, che le valse ai tempi entusiastiche recensioni: il Padre e lo Spirito Santo, l’amore terreno e quello trascendente, la perdita e il desiderio di colmare un vuoto profondo. La famiglia è un covo di matti a cui voler bene, la vita è assieme insopportabile e un dono per cui ringraziare – e per cui pregare e scrivere, che sono in fondo la stessa cosa.
Già accostata da Fruttero, ai tempi del suo esordio, a Bernhard e Céline, a me pare che di Matteucci sia invece fratello maggiore Guido Ceronetti. Come lui, Matteucci è spassosamente crudele, impegnata in una solitaria ricerca spirituale e intellettuale, incapace di lenire un dolore divenuto cronico e che si indossa come un cilicio rosa. Il desiderio di essere pienamente felici si rivela nella sua natura illusoria: la completa integrazione nel proprio tempo, l’adesione agli altri, è impossibile. E infatti, la lingua che usa Matteucci riflette questa condizione di spaesamento: desueta, nella sua ricercatezza, come una messa in latino, che cerca nell’anacronismo una risposta al caos. Una lingua che a volte ricalca quella dell’epica alla Brancaleone, come una fuga dalla miseria del quotidiano. L’ironia è un incerto strumento per accettare l’assurdo della vita e nel caso di Matteucci, e quindi della protagonista di Cartagloria, è un dono paterno, forse l’eredità migliore che si possa lasciare a una figlia.

Irene Graziosi: Lucy Jones, Matrescenza (Laterza). Traduzione di Alessandra Castellazzi
Da che mondo è mondo si fanno figli. Li fanno un po’ tutti: pesci, funghi, uccelli, ornitorinchi, gatti e via dicendo. Per lo più, questi figli li fanno le femmine. E per lo più, sono le femmine a occuparsene. Nel mondo umano, i cuccioli rimangono cuccioli per un tempo infinito, e questo vuol dire che l’allevamento dei bambini è un lavoro lungo, faticoso e, soprattutto, ancora femminile. Un alieno atterrato sulla Terra penserebbe a questo punto che della gravidanza e del processo che porta una donna a diventare madre si sa già tutto. E invece, proprio perché è una faccenda da donne, se ne sa poco e niente su tutti i piani: medico, anatomico, cerebrale, ormonale, umano. È un campo, quello della maternità, disseminato di miti, leggende, false informazioni, tradizioni balzane e idee preconcette che per anni e anni hanno dato l’illusione che non servisse sapere altro oltre ciò che era stato tramandato. Non solo, da un certo momento in poi gli uomini hanno deciso che erano loro a sapere come si veniva al mondo e come si allevavano i figli, con il risultato di una serie di dogmi assurdi che venivano imposti alle donne in un tempo in cui ancora credevano al mito del maschio.
Ci voleva Matrescenza (Laterza), di Lucy Jones, giornalista inglese e madre di tre bambini, a stravolgere tutto. Usando come guide alcuni grandi testi del passato (tra cui spiccano Nato di donna di Adrienne Rich, saggio fondativo degli anni ‘70 sul femminile e la maternità da una prospettiva femminista, e Il lavoro di una vita di Rachel Cusk, più orientato sull’esperienza soggettiva della maternità), Jones traccia una mappa della metamorfosi dinamica che coinvolge ogni aspetto della donna che, d’un tratto, si ritrova madre: la matrescenza, appunto, la chiama lei. Si inizia così dalla gravidanza e dai livelli di ormoni che aumentano anche del 300%, si attraversa la placenta, un organo straordinario e misterioso, si parla dell’allattamento – croce iniziale di tutte le madri, anche e soprattutto di coloro che non riescono a farlo “naturalmente” – della deprivazione del sonno, della totale assenza di aiuti alle neomadri e poi del cervello materno e di come questo cambi letteralmente forma dal concepimento del figlio fino alla propria morte. Con una scrittura scorrevole e chiara e la formula ormai vincente del saggio-memoir, la disamina di Jones è interessantissima da tutti i punti di vista. Oltretutto, se la si legge da incinte o da madri, allevia per qualche istante il (paradossale) senso di solitudine in cui si tende a sprofondare mentre si dà la vita a un altro essere umano al quale si sarà per sempre legate. E poi finalmente si scoprirà come mai il cervello appare vuoto e pieno al tempo stesso, una condizione lontanissima dallo sminuente “baby brain” (quella condizione che porta le donne incinte a scusarsi ancora più del solito per normali dimenticanze o distrazioni), e molto più creativa di quanto non si immagini. Un saggio davvero importante, che continuerà a essere letto e diventerà un classico, ne sono certa.
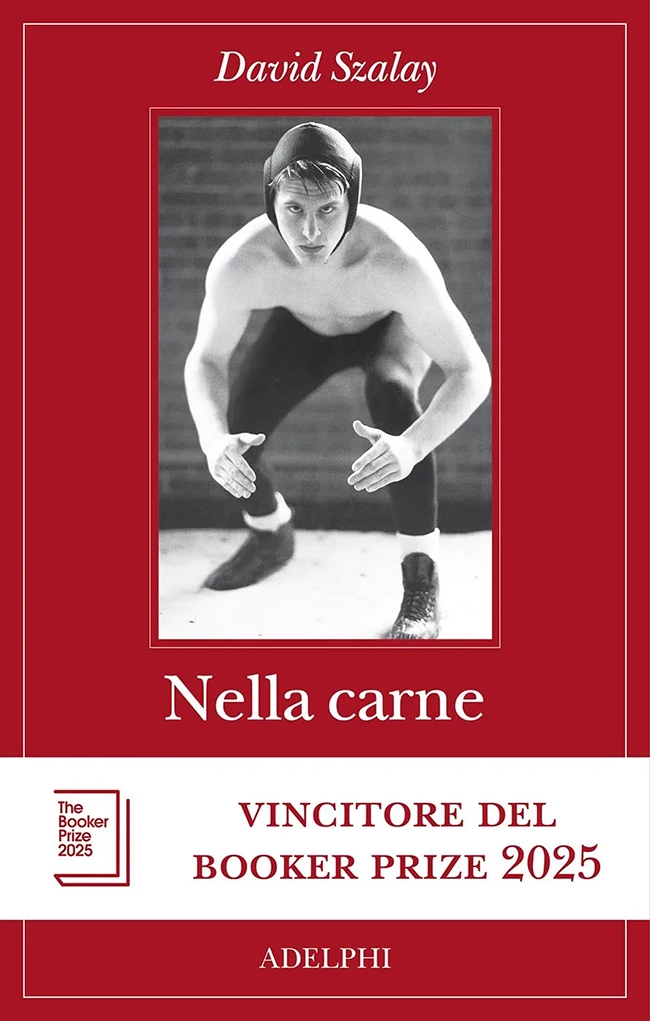
Nicola Lagioia: David Szalay, Nella carne (Adelphi). Traduzione di Anna Rusconi
Si è molto parlato di Nella carne di David Szalay, specie dopo la vittoria del Booker Prize. I giurati del premio, con qualche iperbole negli anni di Jon Fosse e Laszlo Krasznahorkai, hanno dichiarato nelle motivazioni di non aver mai letto nulla del genere. A differenza di Krasznahorkai e Fosse, tuttavia, Szalay usa una scrittura minimale e precisa – precisa ma non fredda –, tutta in levare, sapientemente costellata di “buchi narrativi” che spetta al lettore riempire. Insomma, il romanzo si fa leggere con grande piacere. “Per due giorni ho smesso di controllare le notifiche sullo smartphone” è il più grande complimento che di questi tempi si possa fare a un libro, e ho sentito molte lettrici e molti lettori fare commenti simili. Io stesso, per due giorni e una notte, non vedevo l’ora di tornare alle pagine di un romanzo che si fa leggere come una storia d’avventura ma è anche una meditazione sull’esistenza, sulla solitudine che presto o tardi attanaglia tutti, su come istinti e caso abbiano la meglio sopra ogni volontà, sul nostro essere sempre, nonostante tutto, delle creature sentimentali, condannati alla quasi incomunicabilità su quella tempesta perenne che è il nostro stato emotivo, ben coperto dalla “carne”, sigillato a morte dalla “pelle” (altra parola cara agli scrittori e ai lettori di un certo tipo). Ciò che però chiediamo alla letteratura per farcene davvero conquistare è un sentimento di prossimità, meglio di intimità, e per tutta la vicenda così ben orchestrata da Szalay ci sentiamo vicini a István, il protagonista del romanzo, che troviamo quindicenne nei sobborghi malandati di una città ungherese e abbandoniamo quando ormai è un uomo di mezza età, dopo una serie di vicissitudini degne di un Barry Lindon contemporaneo (su questo le note di copertina dicono il vero) che lo hanno portato, tra alterne fortune, in Medio Oriente, a Londra, in Germania, poi ancora in Ungheria. Un perdente. Un vincente. Un ricco. Un povero. Un mediocre baciato dalla fortuna. Un coraggioso perseguitato dalla sventura. István, negli anni, è tutte queste cose, e si rimane ammirati per come l’autore riesca a farci sentire vicine (in certe pagine del libro sembra di stare a letto con István quando si addormenta, mentre ci addormentiamo pure noi, vinti da un sonno a cui non vorremmo dare soddisfazione pur di leggere ancora un capitolo) le vicende di un uomo che più diverso da noi non potrebbe essere. Diverso? Eppure in certe descrizioni della periferia di Budapest ho rivisto la trascuratezza di certi luoghi sperduti del sud Italia. E nell’apprendistato erotico di István qualcosa che riguarda l’adolescenza della mia generazione. E nelle sue avventure londinesi le rocambolesche vicende di molti expat che conosco. Ma il tipo di prossimità di cui ho parlato investe anche chi con István, la sua generazione e il suo background non ha davvero nulla a che fare (mettiamo giovane donna, estrazione borghese, livello di studi superiore). Si è spesso scritto in queste settimane che il vero tema di Nella carne – ciò che ne fa un romanzo infine lancinante – consiste nel misurare a ogni pagina la distanza tra la ricchezza della vita interiore di István (che percepiamo continuamente tra le righe) e la sua assoluta incapacità di tradurla in parole. Non è così per tutti? La distanza tra István e il più facondo tra noi non è insignificante rispetto a ciò che separa ogni umano dalla capacità di tradurre (a sé stesso, ai simili) il fondo della propria esistenza? Il vero merito di Nella carne consiste allora nella capacità di conciliare tanto bene il racconto dei sentimenti con una trama avvincente. Di solito l’esplorazione delle vite interiori va a discapito del plot e una trama troppo strutturata allontana emotivamente dai personaggi. Qui una cosa si intreccia bene all’altra, temo con un paio di cedimenti nel finale (provo a dirlo senza spoiler: il destino di Helen, il colpo di scena finale con Thomas, in questi casi la macchina del plot rischia di prendere il sopravvento e Szalay non ha l’ironia di Nabokov, il quale, quando i colpi di scena si facevano un po’ troppo spettacolari nei suoi romanzi, tirava platealmente in ballo “Mister McFatum”), ma nel complesso funziona tutto molto bene. Sul piano editoriale Nella carne mi sembra poi la prima scommessa vinta “in purezza” dell’Adelphi post Calasso, più dei ritrovamenti céliniani o dell’operazione muscolare intorno a Philip Roth. Ancora un autore dell’Europa orientale, ma in marcia verso le ombre del XXI secolo.
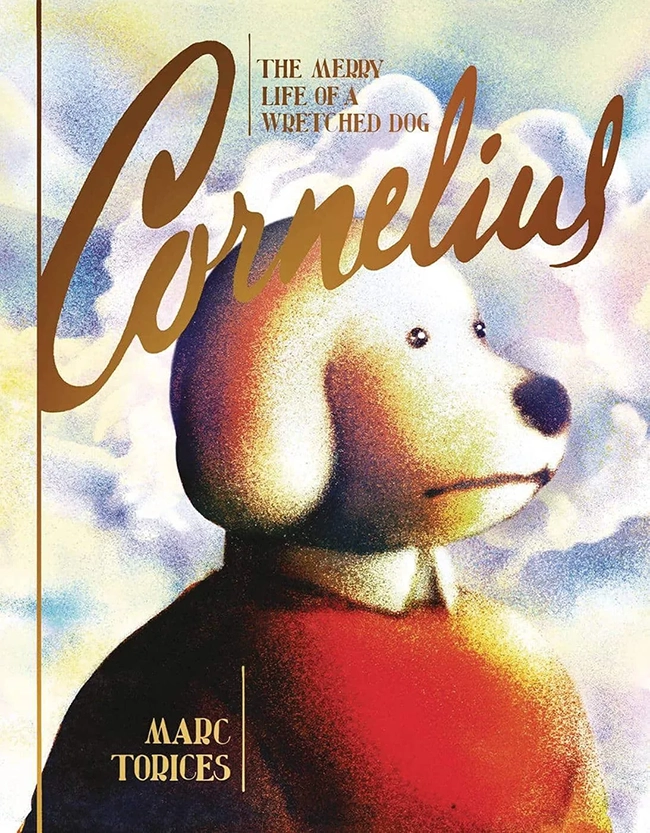
Lorenzo Matteucci: Marc Torices, Cornelius. The Merry Life of a Wretched Dog (Drawn & Quarterly). Traduzione di Andrea Rosenberg
Poco più di una decade fa, agli albori di Instagram, Facebook era ancora uno spazio felice e poco contaminato da messaggi per augurare il buongiorno o dedicare preghiere. Oltre a essere il social più amato dai boomer, va dato merito a “quello blu” di essere stato la prima casa digitale per strisce a fumetti aperta al grande pubblico – nel bene o nel male e con tutte le conseguenze di iperproduttività e stagnazione delle tematiche del caso.
Non sono mai stato un fan di quel genere di fumetto autoconclusivo che nei social andava per la maggiore già dall’epoca. Quel fumetto intimista che ripercorre esempi di quotidianità con l’aggiunta di una nota di pessimismo e autocommiserazione. L’ho sempre trovato facile, perché, in fondo, si gioca sull’immedesimazione, che è uno dei nutrienti necessari al sostentamento dei social (vedasi “no vabbè troppo noi”).
In quegli anni avevo scoperto il lavoro di un fumettista spagnolo poco noto, una serie basata sulle avventure di Cornelius, un cane antropomorfo. Quelle vignette erano quanto di più lontano dagli standard del tempo, a cominciare dal protagonista stesso, un vero miserabile. In un’epoca dove il fruitore medio di fumetto sui social si aspettava di rispecchiarsi in un fumetto malinconico sulle turbe adolescenziali o sulla vita da neo-adulto, la scelta di creare un protagonista così disprezzabile come Cornelius era quanto meno coraggiosa. Mediocre, egoista e ignavo, Cornelius non creava empatia, ma rabbia nel lettore.
A ciò va aggiunto che le strisce di “El Perro Cornelius” erano puro caos narrativo, e spesso mancavano di una vera e propria conclusione, cosa che lasciava un certo spaesamento in chi le fruiva. Ma erano disegnate molto bene; e io di certo non potevo resistere a degli animali dai tratti così teneri. È da lì che ho iniziato a seguire la produzione artistica di Marc Torices.
Mandando avanti di qualche anno arriviamo a giugno 2025 e all’uscita del maxi-volume Cornelius: The Merry Life of a Wretched Dog, una creazione straordinaria del fumettista spagnolo, tradotto in inglese da Andrea Rosenberg e pubblicato da Drawn & Quarterly.
Nel libro si ritrova tutto lo spirito degli albori: poca linearità, salti temporali e stilistici, e quei bellissimi personaggi animali dall’estetica delicata e dall’animo turpe. Una gran gioia per me.
Il cortocircuito inizia presto: fin dall’inizio del libro, si ha la sensazione che Torices stia prendendo in giro il lettore. Il prologo promette che questo volume è il primo di “una serie di 40 che ripercorreranno la traiettoria di Cornelius” e che il medesimo è una celebrazione del 300° compleanno del personaggio, ormai diventato un’icona mondiale delle strisce a fumetti.
Il libro è strutturato come una raccolta di strisce con note storiche/contestuali sul retro. Alcune di queste sono datate all’inizio 1900, ma Cornelius, e chi lo conosce lo sa bene, è ben più giovane. Questo è un chiaro indicatore del fatto che non bisogna prendere tutto alla lettera, specie le parole di Torices. Mi fa sorridere pensare a chi ha acquistato il libro senza questo bagaglio di conoscenze acquisito, e al fatto che probabilmente aspetterà di leggere i 39 volumi successivi, o cercherà online immagini di Cornelius datate un secolo fa.
La storia, sebbene apparentemente semplice, si complica rapidamente: dopo il rapimento della sua amica Alspacka, Cornelius fa ben poco per aiutarla e si dedica invece a inseguire il suo sogno di diventare scrittore. E In questo percorso tra incontri grotteschi, uso di stupefacenti e deviazioni varie farà di tutto pur di ignorare la sua amica in difficoltà. Di cui, anzi, quasi sabota il salvataggio facendo sparire la richiesta di riscatto.
Tecnicamente il fumetto è bellissimo. Ogni pagina è una sorpresa, con stili che variano da forme geometriche colorate a dettagli vividi e vignette surreali.
In un’epoca dove tutto va giustificato Cornelius si fa portatore di un messaggio: abbracciare il nonsenso è parte della vita e dell’esperienza umana. Se amate l’assurdo, la complessità, i disegni fatti bene e soprattutto gli animali carini disegnati bene Cornelius: The Merry Life of a Wretched Dog è un’opera che merita sicuramente la vostra attenzione.
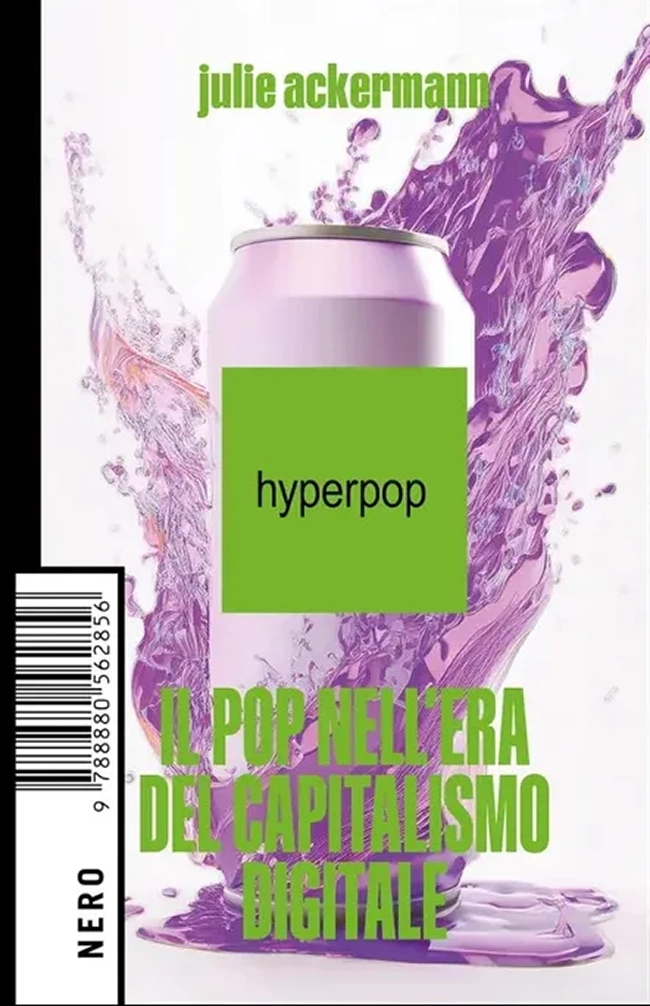
Marta Savignano: Julie Ackermann, Hyperpop (Nero). Traduzione di Akoi 1
Mi ricordo ancora la sensazione che provai la prima volta che ascoltai Immaterial di SOPHIE. Il tutto era accompagnato da una carica emotiva molto forte e, allo stesso tempo, straniante. Percepivo chiaramente di trovarmi di fronte a territori musicali che non avevo mai esplorato prima. Probabilmente, all’epoca, non avevo ancora la sensibilità né gli strumenti giusti per apprezzare fino in fondo quel genere.
Quattro anni e almeno cento dischi dopo, mentre stavo disperatamente scrivendo la tesi, mi imbattei in 1000 gecs and The Tree of Clues dei 100 gecs. La copertina era surreale, fiabesca e caotica: un Bosch contemporaneo. Al centro, un fungo antropomorfo insegue un topo tra funghi allucinogeni. Sullo sfondo si intravede una foresta magica popolata da creature mitologiche, immerse in un rave psichedelico sotto LSD.
La prima canzone che ascoltai fu xXXi_wud_nvrstøp_ÜXXx ft.Tommy Cash e Hannah Diamond. Ripensai a SOPHIE. Forse ero finalmente pronta ad affrontare e varcare le porte di questo nuovo mondo: l’hyperpop. Un pop “sperimentale”, massimalista ma anche nostalgico e parodistico che cerca di esasperare le caratteristiche del pop portandole all’estremo, con voci distorte, basi elettroniche e continui riferimenti alla cultura consumista.
Un immaginario e un suono che prendono forma proprio attorno a figure come SOPHIE e A. G. Cook, fondatore del’etichetta PC Music, e anche a progetti come i 100 gecs. Negli anni più recenti, l’hyperpop è tornato sotto i riflettori grazie a Charli xcx che ha contribuito a una nuova ondata di attenzione mediatica verso il genere attraverso la brat summer. Un genere che può essere letto come riflesso della società contemporanea, in particolare del mondo digitale caotico e iperconnesso e dei valori della Gen Z. Se vostra cugina è fan di Charli xcx, ha preso la brat summer molto sul serio (forse troppo) e ha condiviso almeno un meme verde fluo su Instagram, probabilmente questo libro è il regalo giusto.

Irene Moro: Gerald Murnane, Distretti di confine (Safarà). Traduzione di Roberto Serrai
“Bada ai tuoi occhi” si ripete Gerald Murnane in Distretti di confine. L’ha letto per caso da ragazzo dietro a un santino e decide di farne il proprio mantra e la sua prima ragione di scrittura. La seconda, a suo dire, è la meraviglia scaturita dall’osservare la vetrata della chiesa del suo quartiere da un punto inondato dal sole e non riuscire a identificare i colori e le forme visibili quando le osserva, invece, da un punto in ombra.
Distretti di confine vuole essere l’ultimo romanzo di Murnane, ma lo è davvero? Si tratta di un lunghissimo monologo descrittivo che, però, ha poco a che fare con l’occhio: l’autore ci offre una versione del suo mondo, filtrata dai vetri colorati delle finestre della sua mente, con un fitto simbolismo immaginifico. Nel suo osservare, la vista viene messa piuttosto da parte a favore di immagini mentali.
Il risultato è una mappatura dei distretti di confine della sua mente, dove il narratore prende nota della sua storia per immagini, a partire da quelle riferite al mondo religioso che, una volta persa la fede, non gli sono più di alcuna utilità. Non hanno alcun riferimento esterno, ma fanno parte del suo prezioso panorama mentale. Percorriamo la sua (e la nostra) vita attraverso una serie di raffigurazioni, di concetti, di aspettative o proiezioni che sembrano essere l’unico modo per orientarsi nel mondo.
Conosciuto soprattutto per Le pianure (pubblicato in Italia sempre da Safarà), Murnane non è mai uscito dall’Australia e non possiede alcuno strumento tecnologico, forse proprio per paura di inquinare il proprio orizzonte interiore, la cosa a lui più cara: “La mia immagine dell’Inghilterra corrisponde a quella di una carta topografica perlopiù verde, molto dettagliata e tuttavia relativamente piccola per un Paese immaginario”.
Che ci si spinga oltre i confini o che si resti a presidiare i territori liminali della nostra immaginazione, le pagine di Murnane ci ricordano che lo sguardo non è mai solo un fatto di occhi. E, forse, ci invitano ad aggiungere un buon proposito alla nostra lista per il nuovo anno: badare alla nostra geografia interiore.
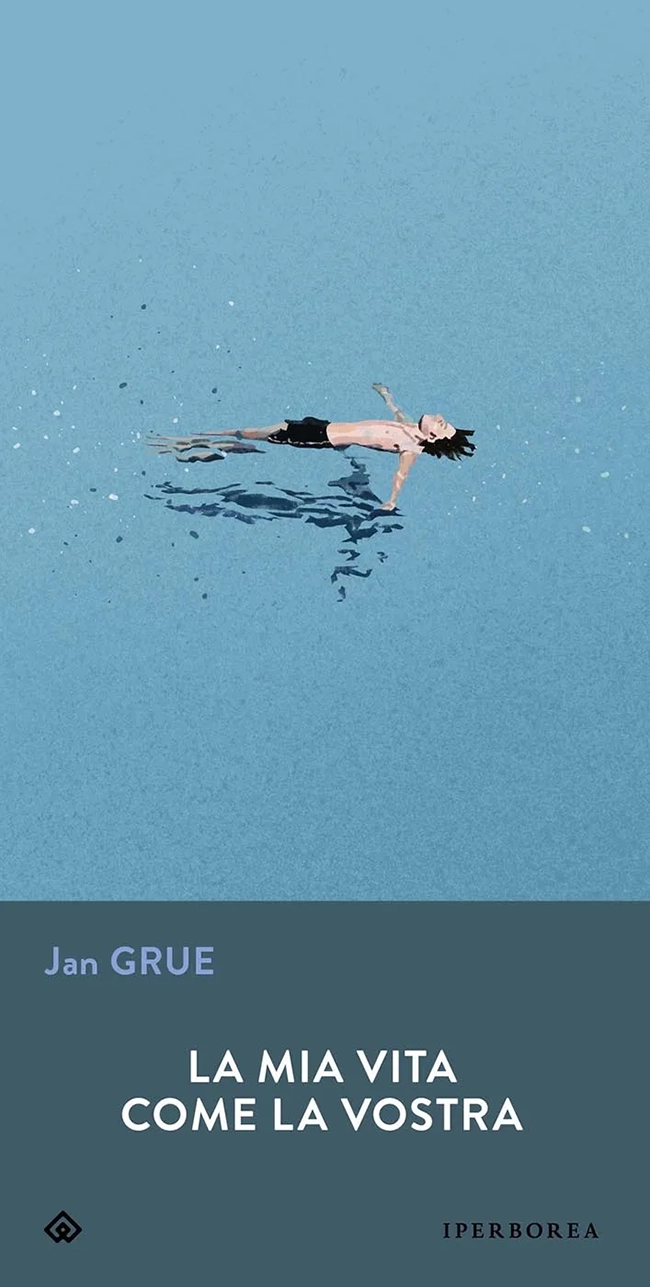
Elena Sbordoni: Jan Grue, La mia vita come la vostra (Iperborea). Traduzione di Eva Valvo
“Esiste uno sguardo, una specie di riconoscimento. Esiste un senso di solitudine, la sensazione di essere un corpo con cui nessuno, men che meno il diretto interessato, vuole avere a che fare.”
Jan Grue, fin dai primi anni di vita, non ha un corpo normale. Non gattonerà mai e quando imparerà a stare in piedi cadrà ripetutamente, inciampando in ostacoli invisibili sparsi sul suo percorso. “Non sembra interessato a sollevare la testa, girarsi o provare a strisciare sul pavimento”, legge dalle note cliniche raccolte nei faldoni che i genitori gli consegnano ormai adulto. Quelle migliaia di pagine raccontano, con un linguaggio asettico e succinto, la sua infanzia e la sua patologia – la miopatia neuromuscolare congenita, che comporta ipotonia e debolezza muscolare.
Eppure quei fogli non sono la sua vita. Sparsi sul tavolo della cucina sembrano comporre la biografia di uno sconosciuto: un corpo difettoso con un futuro mesto e limitato. Jan analizza con lucidità il proprio corpo perché è ciò che lo definisce, condizionando ogni suo movimento, ogni scelta e relazione.
Quando la società guarda un corpo disabile con accondiscendenza e pietismo, è quello sguardo a condizionarlo, a imprigionarlo in una narrazione che non gli appartiene. La discriminazione è in quella pietà non richiesta che trasforma una persona in un oggetto da compatire piuttosto che in un soggetto con cui confrontarsi.
Oggi professore del Dipartimento di Sociologia e Geografia Umana all’Università di Oslo, padre e marito, all’inizio del memoir La mia vita come la vostra Jan Grue si pone una domanda: come si diventa un essere umano se per gli altri non sarai mai normale? Se per te la vita sarà sempre una rincorsa al progresso della scienza per ottenere braccia o gambe surrogate per un surrogato di vita?
“Una diagnosi è intima, è una risposta. Se arriva dopo anni di incertezza, può risultare liberatoria. […] Se la diagnosi descrive una condizione degenerativa, è anche fonte di inquietudine. Evoca immagini del futuro, è la mappa che conduce al luogo in cui non vorresti mai andare”.
Con una struttura che intreccia ricordi poetici e riflessioni, Jan Grue racconta una vita – nella sua singolarità e nella sua radicale ordinarietà.
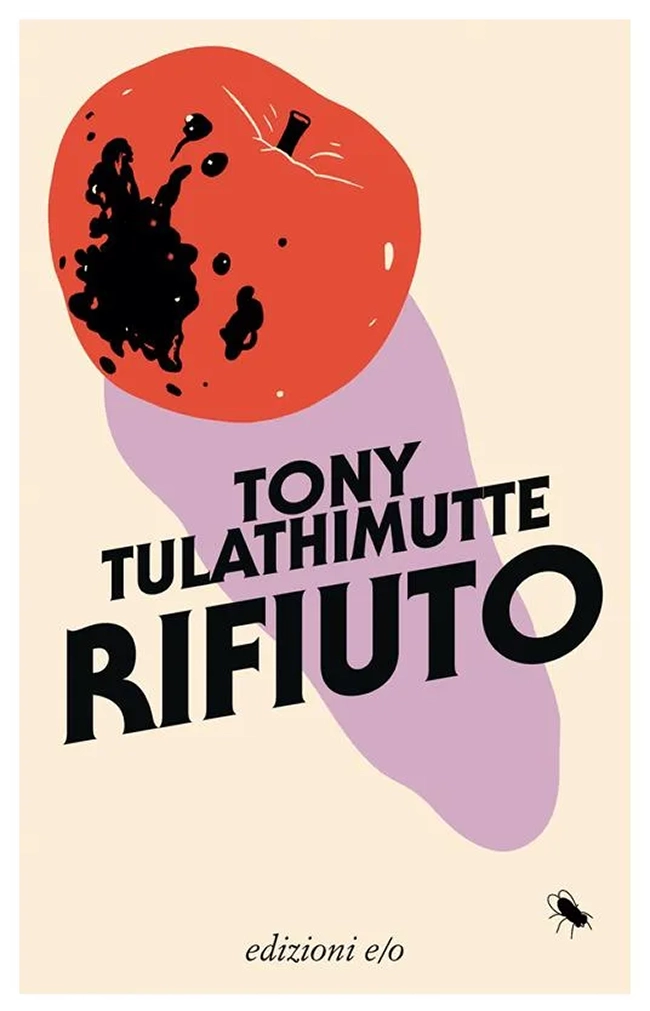
Mattia Venturi: Tony Tulathimutte, Rifiuto (edizioni e/o). Traduzione di Vincenzo Latronico
Un ragazzo cresciuto leggendo bell hooks e Angela Davis che si professa alleato del genere femminile, salvo poi scoprire che il suo vocabolario morale non gli garantisce alcuna intimità. Una donna che, dopo essere stata rifiutata sentimentalmente, precipita in un vortice di autodistruzione e dipendenza affettiva. Un uomo che sublima la repressione sessuale in fantasie estreme, finché il privato collassa sotto il peso dello sguardo pubblico. Un businessman che traduce ogni desiderio in KPI, ogni fallimento in ottimizzazione. Una voce che riscrive ossessivamente se stessa attraverso le categorie dell’identità, fino a dissolversi. Questa è l’umanità grottesca che popola le pagine di Rifiuto: figure che oscillano tra il bisogno di mostrarsi e il desiderio di nascondersi, incapaci di approdare a un disvelamento definitivo perché oltre ogni velo ce n’è sempre un altro.
La raccolta di Tulathimutte parla di identità: identità sbandierate, difese, rivendicate; ognuna finisce per rivelarsi inconsistente, non rifugio ma costruzione retorica che cede alla prima frizione. I sistemi simbolici – politici, morali, linguistici – vengono portati fino al punto di rottura, dove la logica mostra la propria incompletezza e la lingua la propria arbitrarietà. I personaggi si aggrappano a categorie che promettono senso e appartenenza, per scoprire che non c’è alcun nucleo stabile a cui essere fedeli: “Tutti gli anni che avevo sprecato a darmi addosso perché avevo tradito la mia vera identità, e ora scoprivo che non c’era nessuna identità da tradire”. Al centro resta il bisogno di appartenere – a qualcuno, a una comunità, a un discorso condiviso – e il dolore di sentirsi comunque respinti.
Poche delle coordinate tradizionali della narrativa sopravvivono: quasi nessuna descrizione degli spazi, nessuna vera crescita, un tempo che scorre vacuo e insignificante. La sensazione, leggendo, è quella di essere immersi nel doomscrolling: un flusso indistinto di casi umani, paranoia e risentimento. La lettera editoriale che chiude il libro – un rifiuto immaginario ricevuto dall’autore – è anche una dichiarazione d’intenti: certi personaggi sono troppo sgradevoli – troppo veri, forse – per trovare cittadinanza nel mondo, o almeno nel suo ideale.
Come dice un oppositore nel forum online del racconto Il femminista: “Qui dentro è come fissare uno specchio maledetto che più lo guardi più ti vedi brutto, ma sei così rapito che continui a guardare”. Ecco, l’auspicio di Tulathimutte nel consegnare il suo libro al lettore è più o meno questo.