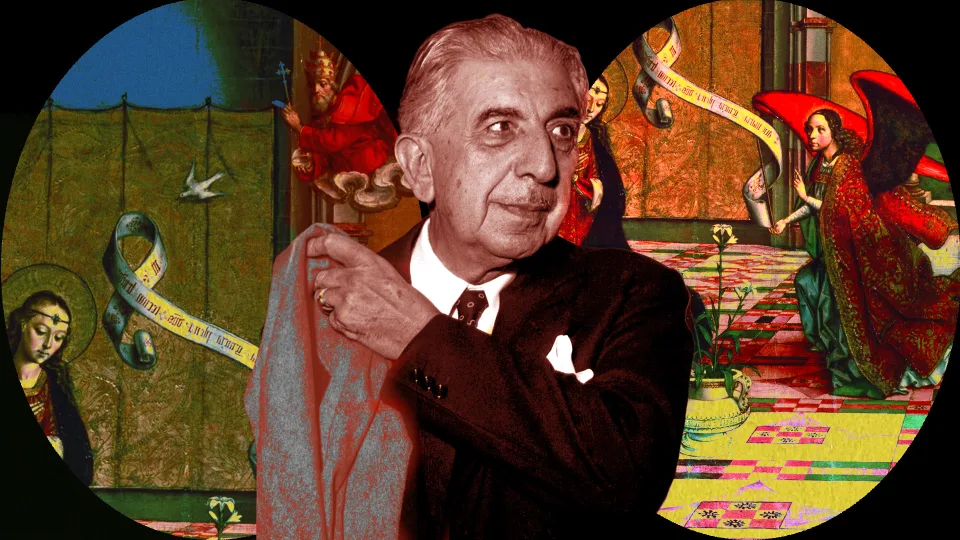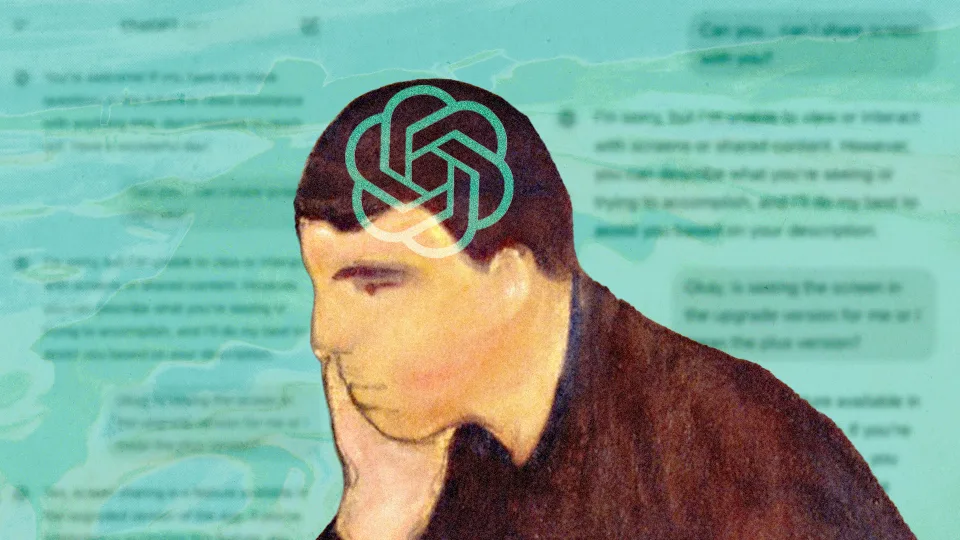A quarant'anni dalla sua scomparsa, leggere Elsa Morante è ancora un'esperienza folgorante che suscita una reazione intensa. E non solo per la sua scrittura, i suoi personaggi, il dramma della Storia da cui sono travolti gli abitanti delle sue opere. C'è qualcosa di più profondo e perturbante ancora, che ha a che fare con una visione della realtà diversa da quella di tutti gli altri.
Chiunque apra una pagina di Elsa Morante è obbligato sempre, quasi fisiologicamente, anche suo malgrado, a una reazione. Può essere la sensazione di ritornare a casa, o una riappropriazione dello sguardo, come quando si trovano finalmente le lenti giuste: ecco, ora vedo, ricordo che cos’è vedere. Ma può anche essere un effetto di lieve sospetto, o addirittura di rifiuto, per una lingua così originale e insieme naturale, senza maquillages né artifici, semplice senza essere facile, diversa da tutte le altre sue contemporanee. E sempre diversa da se stessa, in ogni libro.
Questo effetto così potente, credo, è dato dal fatto che Elsa Morante non è soltanto scrittore o poeta – come lei stessa amava provocatoriamente rubricarsi, riservando ad altri il titolo di poetessi – ma è anche qualcosa di più: in Elsa Morante c’è sempre una corrente sotterranea che attraversa la scrittura, una lava incandescente che scorre tra le sue pagine, dai racconti giovanili fino ad Aracoeli. È a questa corrente che ogni volta reagiamo. È qualcosa che vorrei chiamare qui, provvisoriamente, pensiero – ma ognuno lo chiami pure come preferisce. Che cos’è il pensiero? Non lo stanco rimuginare della testa, quello che secondo qualcuno non occorre fare troppo perché bisogna vivere, quello contrapposto alle emozioni e ai sentimenti (come se questi fossero, invece, la verità ultima). No: il pensiero è quella attitudine naturale verso il mondo, in cui non ci accontentiamo di conoscere le cose intorno a noi, ma vogliamo anche essere ciò che vediamo e conosciamo. È qualcosa che unisce la mente e il corpo, il dentro e il fuori, le idee che abbiamo e i modi in cui viviamo. Non un’unità raggiunta (non torneremo mai all’Eden), ma qualcosa che si manifesta anzitutto come una impazienza, una certa mobilità, un’insofferenza verso ogni posizione data – e che tuttavia prende ogni volta posizione. In questo carattere noetico, interessato più alla realtà che alle categorie per definirla, credo risieda una delle più preziose virtù di Elsa Morante, ciò che la rende ancora inafferrabile.
Dunque sì, Elsa Morante ha scritto senz’altro romanzi, racconti, poesie, articoli, favole, filastrocche. Ma niente sarebbe più ingiusto, nei suoi confronti, che giudicarla da un punto di vista solo letterario, ignorando così i presupposti più urgenti di ogni sua pagina. Come sarebbe anche sbagliato, credo, considerarla del tutto fuori dalla letteratura, seguendo così una tentazione che mi pare abbia molti esponenti, per cui Morante è ridotta a schermo delle migliori proiezioni della buona coscienza civile: militante di volta in volta anarchica, femminista eterodossa, comunista senza partito, animalista partecipe dei dolori del mondo; o anche infine, più modestamente, zia affabulatrice un po’ matta, ma geniale depositaria di una sapienza amorosa. Ma davvero Elsa Morante è questo? È un’immagine comoda per alcune restituzioni televisive o documentarie, per certe biografie, ma totalmente addomesticata, scolarizzata, priva di spigoli. Nulla, credo, lei avrebbe detestato di più di questa immagine civile rassicurante. Morante non è Ida, la protagonista de La Storia, mater dolorosa che piange l’ininterrotto scandalo della tragedia storica. E non è riducibile neanche alla scanzonata ribellione anarchica de Il mondo salvato dai ragazzini, al sessantotto. In Elsa Morante ci sono anche Spinoza e Simone Weil, c’è una potente immaginazione metafisica mescolata a una sostanza originaria fantastica, più selvatica e irriducibile a ogni intenzione pedagogica. Che cos’è allora?
Una dei doni più preziosi che si ricevono dalla lettura di Elsa Morante è una certa libertà dai criteri e dalle definizioni. Ciò non significa, naturalmente, che non bisogna giudicare affatto. Tutti continuamente giudichiamo, siamo portati dalla nostra intelligenza e dal nostro cuore a rendere ragione di ciò che vediamo. Ma questi giudizi sono veri solo se sono di volta in volta in rapporto, direbbe Spinoza, a una certa potenza di agire. Ovvero se nascono da un certo rapporto o frizione immediata con le cose stesse, e non con i nomi, con le categorie, con i criteri, come molto spesso accade. È ciò che rende così penose molte discussioni letterarie: come definiamo un saggista? E che cos’è il romanzo? Quando la poesia è poesia? Qual è lo stato della letteratura italiana odierna? È più attuale Gadda o Moravia? Difficilmente si può immaginare quale sterminio interiore bisogna aver subito per svolgere simili discussioni, sui giornali o altrove.
Ecco, Elsa Morante rappresenta semplicemente l’esatto opposto di tutto ciò. Il suo è un deciso rifiuto della cultura in quanto tale, di tutto l’apparato che definisce sistematicamente le cose, offuscando la loro più ricca vitale possibilità. Basti la sua definizione di scrittore, in Pro o contro la bomba atomica: “un uomo a cui sta a cuore tutto quanto accade, fuorché la letteratura”. O il suo testo sul romanzo, dove la definizione che viene data del romanzo è talmente plastica, libera, così agile e larga, da poter includere al suo interno anche la Bhāgavad-Gīta. O il pezzo sul Beato Angelico, dove ci viene descritto, quasi avvenisse davanti ai nostri occhi, il miracolo insondabile, la nascita della luce. Perfino Piazza Navona, lungi dall’essere uno spazio urbano con un perimetro definito, diventa per lei un’immagine sensibile del bene.
È questo, anche, a rendere così preziosa Elsa Morante, la corrente da cui la sua scrittura prende linfa, il suo pensiero. E se si guarda al pensiero, entrambe le definizioni – quella puramente letteraria e quella più rozzamente politica – decadono. Non che in Elsa Morante non vi siano interessi estetici, o che non vi fosse consapevolezza della propria statura letteraria – ma il suo interesse principale, come non ha mai smesso di ripetere, è la Realtà, ovvero la restituzione del mondo nella sua integrità incorrotta. Così in Elsa Morante è presente senz’altro una potente vocazione politica, che le ha fatto prendere sempre posizione sui problemi più urgenti dell’attualità, dal caso Braibanti alle Brigate Rosse. Il suo sguardo è partecipe al mondo, alla storia e alla tragedia umana – ma questo sguardo è ogni volta rigenerato poeticamente, inseparabile dalle parole con cui viene ogni volta enunciato. Questo, il fatto che il pensiero venga ogni volta generato nelle parole, è la prova della verità.
Rappresenta la capacità di rimettere ogni volta in discussione tutto, senza fissarsi in un luogo preciso e identificabile. È un doppio sguardo: all’Isola e alla Storia. Chi guarda alla Storia senza vedere l’Isola, chi condanna il male solo perché è incapace di immaginare il bene, costui è complice del male che condanna, è infetto dalla stessa irrealtà. La bomba atomica – o Gaza – non sono il male, ma un effetto del male e della disintegrazione, ovvero dell’incapacità di fare esperienza sensibile del bene. Tutti ne siamo complici. Chi guarda all’Isola senza vedere la Storia, si condanna alla irrealtà letteraria, all’estetismo, all’impotenza del pensiero.
Si comprende facilmente, allora, come per afferrare l’integrità della realtà occorra semplicemente essere integri e reali, ossia non cedere alle tentazioni che ci vogliono ogni volta definire, spezzettandoci e amputandoci con i più diversi mezzi, contagiandoci di irrealtà. Lo sforzo che Elsa Morante chiede ai suoi lettori è anzitutto questo: il coraggio di vedere, di vedere direttamente ciò che si vede, senza schermi o infingimenti, sperimentando così una forma della presenza meno irreale e disintegrata. Questo è il reagente che le sue pagine contengono, ciò a cui non possiamo non reagire. E per fare questo, per vedere, si intende, non servono soltanto gli occhi. Anche perché la realtà non è semplicemente la realtà nuda e cruda, il principio di realtà. È un esercizio molto peculiare di attenzione, in cui più si restringe il fuoco dello sguardo verso ciò che c’è, più l’orizzonte si amplifica e si dilata. La veggenza poetica che Elsa Morante insegna, l’immaginazione, è una forma di attenzione.