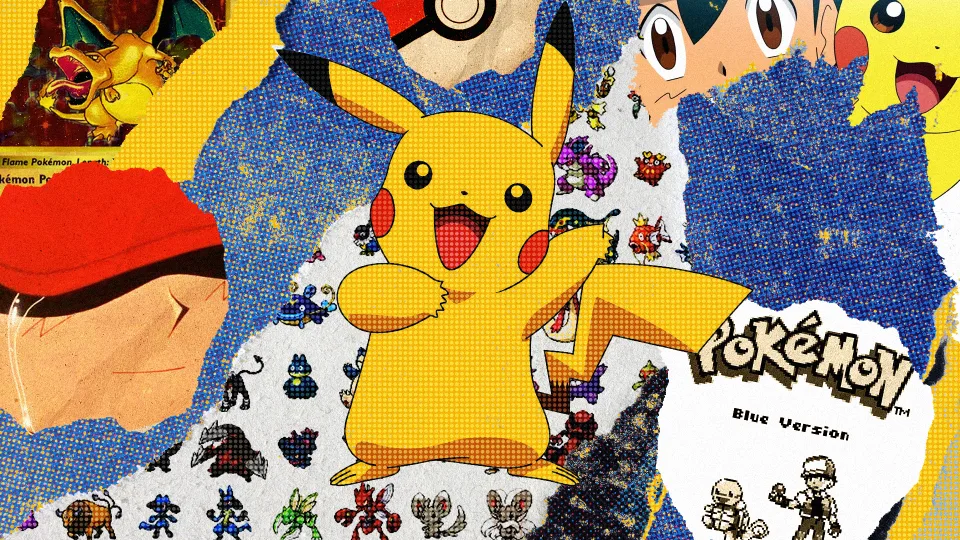È morto ieri a 93 anni Valentino Garavani, uno degli stilisti più importanti della storia recente. Con il suo atelier è riuscito a imporre un impero dell’immagine, fatto di forma ed eleganza, che è stato il riferimento decisivo per alcune tra le dive e le first ladies più potenti al mondo.
È morto Valentino Garavani, e la notizia arriva invece come un flash al magnesio, bianco e impietoso, che ti inchioda il profilo di una figura e lascia in bocca il sapore metallico di qualcosa che non si può più lucidare. Io però, davanti a lui, non riesco a parlare di “stilista” senza sentirmi come uno che chiama la Cappella Sistina “un soffitto ben decorato”.
Valentino era un dispositivo di politica estera in abito da sera, un consolato portatile cucito a mano, un ambasciatore senza valigetta che invece del comunicato stampa usava una piega. E, se vogliamo proprio dirlo con un termine che oggi sembra inventato da un dipartimento universitario con buffet triste, Valentino è stato il soft power prima ancora che Joseph Nye lo rendesse un concetto da manuale: potere di attrarre e cooptare, non di costringere.
In questa storia, l’America è sempre lì, non come semplice mercato, ma come grande schermo mentale del Novecento, schermo dove la politica ha imparato a truccarsi e dove la bellezza ha imparato a comandare senza alzare la voce; e Valentino, italiano fino al midollo e insieme cosmopolita fino alla sfacciataggine, ha restituito agli americani l’eleganza hollywoodiana che loro avevano inventato, solo che gliel’ha rimandata indietro stirata meglio, con una disciplina da atelier romano e un senso della scena che pareva uscito da un set (l’odore della seta invece della celluloide).
E già il nome, qui, è un indizio che sembra innocente e invece è una chiave politica. “Valentino” non è un soprannome: è il suo nome di battesimo, inciso all’anagrafe dentro il suo nome completo, Valentino Clemente Ludovico Garavani: quindi, prima ancora del marchio, c’era il destino del suono.
Quel suono, nella cultura globale, rimanda inevitabilmente a Rodolfo Valentino, cognome d’oro del muto, divinità mediterranea adottata dall’America e poi rimandata indietro come mito. Una notizia biografica molto diffusa racconta che fu proprio quell’attore a suggerire alla madre il nome da dare al figlio, come se Hollywood avesse messo un timbro sul certificato di nascita. Altre ricostruzioni insistono invece sulla genealogia familiare, sul nome del nonno, cioè su una tradizione domestica più che su un colpo di cinema. A me interessa il risultato, non la contabilità dei motivi: in un caso o nell’altro, Valentino nasce già con un brand addosso, e non perché se lo sia scelto, ma perché la modernità funziona così, ti dà un nome e poi ti chiede di interpretarlo. Non è solo estetica: è geopolitica della percezione. E infatti lui, anni dopo, torna esplicitamente a quel fantasma hollywoodiano, firmando costumi e perfino debuttando in ambito teatrale con un’opera intitolata The Dream of Valentino, dedicata proprio alla vita di Rodolfo Valentino: come se il cerchio, alla fine, dovesse essere chiuso con un fiocco.
Guardo la sua parabola e ci vedo, in controluce, l’evoluzione della società americana:un abito che cambia taglio ogni decennio, ma non riesce mai a rinunciare del tutto all’idea di spettacolo.
Negli anni Quaranta e Cinquanta, mentre l’America esce dalla guerra e impara a vendere al mondo non solo frigoriferi ma sogni, Hollywood diventa una fabbrica di aura, un’industria che produce desiderio in serie; e quel desiderio, proprio perché apparentemente frivolo, si rivela più invasivo di molte dottrine. Nye lo dice senza giri di parole quando spiega che una parte enorme del soft power americano nasce dalla società civile e dai suoi simboli culturali, e cita Hollywood tra le sorgenti principali di quella attrazione. E Valentino, che si forma a Parigi ma sceglie Roma come palcoscenico, capisce una cosa che l’America sa da sempre: il potere non è solo quello che fai, è quello che fai desiderare.
Intanto Valentino studia alla Chambre Syndicale, entra nei laboratori, si sporca le mani con il mestiere, impara la costruzione, i rapporti tra tessuti e colori, l’ossessione della forma; prima con Jean Dessès, poi da Guy Laroche, cioè da due maestri che gli insegnano la disciplina e il drappeggio come grammatica del corpo.
Torna in Italia, apre a Roma, e nel 1960 incontra Giancarlo Giammetti: nasce una coppia che è insieme romanzo privato e architettura pubblica, perché Giammetti costruisce il sistema, la comunicazione, l’organizzazione, e Valentino può restare quello che vuole essere, cioè la mente che disegna e decide. È qui che l’America comincia a riconoscersi nello specchio romano. Perché l’America del dopoguerra è un paese che si racconta come democrazia, e però percependosi come impero di immagini: vuole la modernità, sì, ma vuole anche una continuità aristocratica, un’etichetta, un cerimoniale.
Valentino gli offre proprio questo: una nobiltà pronta all’uso, venduta non come nostalgia, ma come futuro con memoria. E quando Jacqueline Kennedy Onassis entra nella sua orbita e a vestire Valentino, la faccenda smette di essere solo moda e diventa antropologia politica: Jackie è un simbolo nazionale in carne e ossa, un lutto diventato eleganza, un’idea di America che si porta addosso la tragedia e la trasforma in stile; e Valentino, quando le firma l’abito da sposa per il matrimonio con Aristotele Onassis e poi le dedica la famosa White Collection, non sta solo vestendo una donna, sta cucendo una continuità narrativa per un Paese che vive di storytelling prima ancora che la parola diventi un lavoro. «El País» ricorda quanto quell’ascesa internazionale passi anche da lì, da quel circuito Roma-New York, da quel modo in cui gli americani, negli anni Sessanta, hanno fame di Europa senza però volere le sue colpe, e dunque la consumano in versione couture.
Poi c’è il rosso, che è il suo passaporto più potente, più riconoscibile di un accento. Il rosso Valentino non è un colore, è una dichiarazione di sovranità estetica. E la cosa comica, quasi crudele, è che tutti dicono “ha inventato il rosso” con la stessa serietà con cui si dice “ha inventato l’amore”, eppure nel suo caso la leggenda funziona perché lui ha saputo trasformare un’esperienza infantile in un codice globale. «Vanity Fair» riporta la sua definizione, che è insieme manifesto e incantesimo: “Red is life, passion, love… the remedy against sadness”, e poi quell’immagine da romanzo popolare di qualità: la donna in rosso come eroina in mezzo alla folla. El País aggiunge la matrice biografica, quel pezzo di infanzia a Barcellona che torna come scintilla, e quindi il rosso come memoria privata diventata logo pubblico. Io, più che al romanticismo, penso alla sua efficacia politica: il rosso Valentino diventa un segnale stradale del desiderio, un semaforo che non ti dice “stop” ma “guarda”, e guardare, in una società dello spettacolo, è già obbedire. Guy Debord, con la ferocia elegante di chi non perdona niente all’immagine, scrive che “all that once was directly lived has become mere representation”, e cioè che ciò che era vissuto direttamente si trasforma in rappresentazione: Valentino ha preso quella trasformazione e l’ha resa seducente: ha fatto cioè della rappresentazione una forma di felicità socialmente accettabile, un rito condiviso.
E qui entra in scena la domanda che mi fai, quella apparentemente da bar e invece molto seria: era di destra? Non si sa, e forse è proprio questa la sua mossa più moderna. Valentino è stato politicamente utile senza schierarsi. In un’intervista al «Corriere della sera», quando lo incalzano perfino sulla politica cittadina di Roma, lui taglia corto: “Non ne so abbastanza”, e in quella frase c’è una scelta, non solo un limite.
E però la sua ideologia era la forma, e la forma, come ci insegna Bourdieu, non è mai neutra: “Taste classifies, and it classifies the classifier”. ‘Il gusto classifica, e classifica chi classifica’. Valentino non vendeva soltanto abiti, vendeva un sistema di classificazione globale, una gerarchia indossabile. In America, paese costruito sul mito dell’uguaglianza e praticato spesso come competizione permanente, quella gerarchia era irresistibile perché permetteva di sentirsi aristocratici senza doverlo ammettere, come con un peccato commesso in guanti di capretto. E infatti la sua clientela americana, dagli anni Sessanta in avanti, è una mappa del potere sociale: first ladies, attrici, eredi, principesse importate e starlette esportate.
Quando arrivo a Nancy Reagan, devo prendermi una piccola pausa, perché lì la moda smette di essere solo abito e diventa coreografia del potere. L’era Reagan è il trionfo di una morale economica che si traveste da ottimismo, e l’ottimismo, si sa, ama i lustrini: il glamour non è un accessorio, è un linguaggio politico, un modo di dire “siamo tornati a comandare e ci piace pure”.
«Vanity Fair», scrivendo della vita di Valentino, insiste proprio su quella bellezza totale che permeava ogni gesto, non solo le passerelle ma le cene, le case, i fiori, il modo di stare al mondo. E un articolo italiano recente lo riassume con una definizione che sembra nata oltreoceano: “Mr. Chic”, non solo perché vestiva, ma perché dispensava gusto come un oracolo privato; e lì compare l’aneddoto che tu vuoi, riportato con la stessa naturalezza con cui si racconta un miracolo mondano: Nancy Reagan che lo chiama alla Casa Bianca per chiedere consiglio su come apparecchiare la tavola per le cene di Stato. Io non lo tratto come un fatto notarile, lo tratto come una verità sociologica: anche se fosse leggenda, è una leggenda coerente, e le leggende coerenti sono il cemento del soft power.
È accertato, del resto, che Nancy Reagan indossava Valentino, e questo è documentato perfino nel racconto museale della sua immagine pubblica, dove il nome di Valentino compare tra i designer associati al suo guardaroba. In altre parole, la telefonata è il dettaglio più teatrale, ma il rapporto tra first lady e couturier è vero nella sostanza: lo Stato che si fa vedere, e per farsi vedere chiede aiuto a chi sa vedere meglio e prima di tutti.
E qui entra il tavolo, che sembra una sciocchezza e invece è politica allo stato puro. Perché il tavolo è il luogo dove il potere si siede e si specchia, dove l’alleanza prende forma tra un bicchiere e un protocollo, dove l’estetica diventa diplomazia domestica. Valentino lo sa, e lo scrive: “Laying a table is a voluptuous exercise”, dice, e si definisce anche “an incurable obsessive”, cioè ‘un ossessivo incurabile’, uno che non concepisce la bellezza come ispirazione bensì come controllo gioioso.
“Valentino era un dispositivo di politica estera in abito da sera, un consolato portatile cucito a mano, un ambasciatore senza valigetta che invece del comunicato stampa usava una piega”.
Il suo libro Valentino: At the Emperor’s Table, introdotto da André Leon Talley, è più che un manuale di ricevimento: è una teoria del prestigio tradotta in porcellana, un piccolo trattato di soft power in forma di centrotavola. Talley, che aveva la voce di un’epica e il gusto di un re, capiva benissimo che quell’apparato non era capriccio, semmai era infrastruttura del mito. E a quel punto mi viene naturale chiamare in causa Veblen, che non era uno da paillettes ma capiva il teatro sociale meglio di molti stylist contemporanei: “Conspicuous consumption of valuable goods is a means of reputability to the gentleman of leisure.” Il consumo vistoso di beni preziosi è un mezzo di rispettabilità. Valentino e Giammetti hanno costruito, per decenni, una macchina di rispettabilità estetica che non chiedeva scusa a nessuno, e proprio per questo risultava così americanamente efficace: perché l’America, quando vuole, sa essere puritana nei principi e barocca nelle forme, basta che le forme sembrino “meritate”.
Hollywood, poi, è il capitolo della sua vita in cui Valentino diventa quasi inevitabile. «Vanity Fair» ricorda una serata del 1988 negli studi della Twentieth Century Fox, a Hollywood, organizzata per celebrare il suo legame con il cinema: se non fosse documentato, sembrerebbe un’invenzione di Fitzgerald con la carta di credito. La sua vita è piena di queste scene in cui la moda si comporta come cinema e il cinema come corte: feste faraoniche, carriere celebrate come imperi, residenze trasformate in set permanenti, dal palazzo romano al castello francese di Wideville, fino alle case e agli yacht che «Vanity Fair» elenca con gusto per i cataloghi quasi da epica o romanzo d’avventura.
E qui la società americana, dagli anni Cinquanta in poi, ha un punto cieco meraviglioso: pretende di essere pragmatica, ma in realtà adora i riti e la liturgia. Valentino gliela fornisce. Vestendo Sophia Loren ed Elizabeth Taylor, entrando nei guardaroba delle dive, firmando abiti che poi diventano fotogrammi di memoria collettiva, come quello di Julia Roberts agli Oscar del 2001, citato come esempio definitivo di red carpet elevato a mito. Persino la cultura pop lo registra: appare in Il diavolo veste Prada, come a dire che Valentino non è soltanto un creatore, è una parola che basta pronunciare per far scattare obbedienza.
Ora, se devo essere filosofico senza diventare pedante, devo ammettere una cosa che mi fa sorridere: Valentino era l’opposto dell’avanguardia, eppure è stato un radicale. Il suo radicalismo consisteva nel rifiutare la sciatteria come destino, nel trattare l’apparenza con la serietà che si deve a ciò che è etica quotidiana.
Roland Barthes, parlando di moda, scrive che “Every new Fashion is a refusal to inherit”, ‘ogni nuova moda è un rifiuto di ereditare’: Valentino, invece, faceva il contrario e proprio per questo spaccava il mondo. Lui ereditava, selezionava, raffinava, e poi rimetteva in circolo l’eredità come se fosse nuova.
Questa è la sua politica culturale: prendere l’immaginario hollywoodiano del glamour classico, quello delle donne scolpite dalla luce e dai costumi, e restituirlo all’America in forma di couture italiana, cioè con la precisione artigiana e la sensualità controllata che l’industria cinematografica aveva certo sognato ma non poteva fabbricare in serie. In quel gesto c’è una lezione per chiunque parli oggi di reputazione nazionale: l’Italia non conquista con l’hard power, ma seduce con la forma, e la forma diventa credibile quando è impeccabile. Oxford Academic, ragionando proprio sul soft power italiano, mette dentro allo stesso paniere arte, cinema, gastronomia e anche moda, come dimensioni strutturali di quell’influenza. Valentino è la dimostrazione vivente di quel capitolo, solo che non lo scrive in un saggio, lo scrive in un orlo.
E le donne, sì, le donne. Qui bisogna avere coraggio, perché la frase lasciata là, “amava le donne”, può essere zucchero o può essere problema: dipende da come la guardi. Valentino le amava in un modo che oggi appare insieme affascinante e sospetto: le voleva magnifiche, le voleva eroiche, le voleva protagoniste del proprio quadro. La sua frase sul rosso, riportata da «Vanity Fair», è esplicita: la donna in rosso, soprattutto la sera, è “the perfect image of the heroine”. È una visione che incanta e stringe, perché trasforma la femminilità in narrazione obbligatoria. Eppure, è anche vero che, nel secondo Novecento americano, la femminilità è stata spesso il luogo dove la politica si è resa visibile: dai tailleur come disciplina pubblica alle serate di gala come diplomazia. Valentino, in questo senso, non inventa la gabbia, inventa l’armatura. Georg Simmel, all’inizio del secolo, aveva descritto la moda come imitazione e allo stesso tempo differenziazione, una macchina che equalizza e separa: “Fashion is a form of imitation and so of social equalization”, e in quel paradosso c’è tutta la modernità. Valentino rende quel paradosso glamour: ti invita a imitare, ma ti fa desiderare di essere irripetibile. È l’America in versione couture, la democrazia che sogna di essere aristocrazia senza confessarlo.
E allora il documentario Valentino: The Last Emperor, quello del 2008, non è solo un film biografico: è la radiografia di un regime dell’immagine prima che il regime cambiasse pelle e diventasse algoritmo. Già il titolo, “l’ultimo imperatore”, è un colpo di genio: ti dice che stai guardando un potere antico, personale, fatto di mani e di carattere, e che quel potere sta per essere sostituito da un potere più freddo, aziendale, replicabile. Reuters ricorda che oggi la casa Valentino continua e cambia direzione, e che la morte di Garavani ha scatenato tributi trasversali, dalla moda alla politica, compresa la premier italiana: segno che il suo ruolo era diventato simbolico, cioè un bene pubblico emotivo. Anche qui, America: perché l’America è il paese dove i simboli sono sempre stati materia prima, e Valentino era un simbolo che funzionava a livello globale.
C’è poi un punto che rende ridicola qualsiasi domanda binaria sul suo orientamento politico: la sua stessa vita privata è stata, volente o nolente, una politica. Reuters riporta che una parte della comunità LGBT+ italiana lo ha ricordato per aver vissuto alla luce del sole la relazione con Giammetti e per aver rotto, già solo con la visibilità, barriere che un tempo erano silenzio obbligatorio. E qui l’ironia è perfetta: l’uomo percepito come guardiano di un’idea classica di eleganza è stato anche, nella sostanza, un agente di modernità sociale. Non è di destra o di sinistra, è un’altra cosa: è un aristocratico dell’estetica che, proprio perché prendeva sul serio la bellezza, ha finito per prendere sul serio anche la libertà di vivere come voleva.
“Valentino, italiano fino al midollo e insieme cosmopolita fino alla sfacciataggine, ha restituito agli americani l’eleganza hollywoodiana che loro avevano inventato, solo che gliel’ha rimandata indietro stirata meglio, con una disciplina da atelier romano e un senso della scena che pareva uscito da un set”.
Ma non voglio trasformarlo in santo, sarebbe un tradimento del suo gusto. Valentino era anche capriccio, controllo, centralità, e un certo fastidio per il mondo che si rilassava troppo. Qui la sua figura diventa quasi una vignetta intelligente: l’uomo che vede la gente in bermuda e infradito e sente crollare la civiltà, il maestro che guarda la casualità come si guarda un’invasione. Non è snobismo semplice, è paura di una perdita di forma. E la perdita di forma, in America, ha sempre avuto un doppio significato: emancipazione e declino, libertà e disordine. Valentino, figlio di un’Europa che ha imparato la disciplina prima del comfort, preferiva l’ordine, ma lo vendeva come piacere, non come punizione. Ed è per questo che gli americani lo amavano: perché l’ordine, quando è lussuoso, sembra una scelta. Adesso, se devo chiudere in modo travolgente, devo farmi violenza e non essere nostalgico, perché la nostalgia è una droga elegante ma impigrisce. Preferisco essere crudele con dolcezza. La morte di Valentino, oggi, non è solo la fine di una persona, è la fine di un’unità di misura.
«Vanity Fair» riporta la sua frase di congedo, quella lettera intitolata Adieu, dove dice, con perfetta teatralità, che il momento giusto per andarsene è quando la festa non è ancora finita. Ecco, io credo che lui avesse capito una cosa che noi facciamo finta di non capire: la festa dell’eleganza, quella festa dove la bellezza è una responsabilità e non un filtro, stava cambiando in discoteca senza orchestra. E lui, da imperatore, non voleva farsi vedere mentre l’impero diventava franchising. Oggi, nell’epoca in cui la politica si fa sui social e la moda spesso somiglia a un meme, Valentino resta come un rosso acceso nel buio, non il rosso consolatorio del romanticismo, ma il rosso che ti obbliga a scegliere. E la scelta, alla fine, è questa: vogliamo un mondo dove il gusto continui a classificare, come dice Bourdieu, oppure vogliamo fingere che tutto valga tutto, e intanto farci classificare dagli algoritmi con molta meno poesia.
Io, davanti a questa morte, scelgo la forma, non perché sia moralmente superiore, ma perché è l’ultima insubordinazione gentile rimasta. Mi immagino Valentino, da qualche parte, che sistema un fiore fuori posto con l’espressione di chi sta salvando un continente, e penso che forse il suo vero lascito non sia un abito rosso, ma l’idea che anche la bellezza è politica, e che l’Italia, quando riesce a farsi desiderare senza implorare, sta già vincendo.