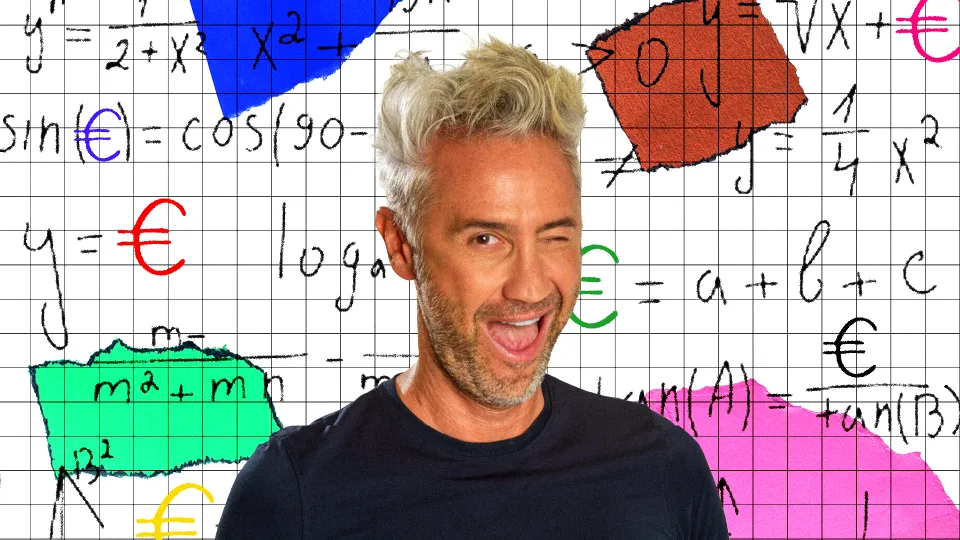Vuoi fare carriera? Presto rischi di essere l’unico. Come sta cambiando il nostro rapporto con il lavoro a partire dalle Grandi dimissioni.
1
“Io non voglio fare carriera. Voglio stare seduta in veranda”. Un paio di anni fa questo tweet di Beks è diventato virale. A giudicare dai commenti, aveva toccato un nervo scoperto. “Mai un tweet mi ha trafitto il cuore così profondamente”, diceva uno di questi. “È vero”, continuava un altro: “non siamo fatti per questa vita febbrile. Voglio nuotare nell’oceano e giocare con le bacche”. Mi sono chiesta a lungo cosa avesse sedotto anche me, di quel tweet. Da un lato c’era la parola carriera, con il suo portato di linearità, sacrificio e abnegazione. E dall’altro la veranda, lo spazio della pausa. Il luogo in cui la nostra vita si sottrae alle richieste di efficienza che puntellano la vita quotidiana e si indugia nel non fare.
“In una situazione in cui ogni momento di veglia è diventato il tempo in cui ci guadagniamo da vivere”, scrive Jenny Odell nel suo Come non fare niente (Hoepli, 2021), e anche il tempo libero si carica della responsabilità di restituire un senso alla vita, la veranda è lo spazio del tempo senza scopo. Il luogo in cui le ambizioni compensative e gli obiettivi specifici della nostra vita attiva sono sospesi. In quella pausa, non ci sono aspettative.
La veranda è il luogo del temporeggiamento, nel quale la nostra usuale predisposizione a dare un fine a ogni cosa si dissolve tra il colore del cielo e il profumo dell’erba. La veranda esautora il tempo dell’efficienza e restituisce sovranità a quel pezzo di mondo che, con la propria vita, celebra una temporalità ostinatamente indifferente alla nostra: il tempo delle fioriture o quello della vendemmia. Sarà per questo che la veranda ha un tale potere evocativo. In un’epoca in cui tutto il tempo ha uno scopo, la veranda è il luogo in cui, per qualche istante, è lecito perdere tempo. È lecito non avere alcun obiettivo e tornare a essere pezzi di vita seduti sulla crosta della terra, distratti dalle lucciole e da rumore dei grilli.
Negli ultimi mesi si è parlato molto di Grandi dimissioni – il fenomeno che, in due anni, ha portato circa cento milioni di persone a lasciare il proprio lavoro nei soli Stati Uniti. Meno è stato detto degli immaginari che questo ha liberato, lì, o in altri paesi al mondo. In effetti, è difficile analizzare i processi mentre questi accadono. Possiamo, al massimo, cogliere dei segni e servirci di un metodo indiziario basato sugli “scarti, sui dati marginali, considerati come rivelatori”, come scriveva Carlo Ginzburg (1979), per provare a disegnare i contorni di un’epoca di transizione. Se ci atteniamo a questo metodo, il tempo della veranda è il simbolo di questi mesi. Ricorda quelli che Christine Beckman e Melissa Mazmanian definivano “the dreams of the overworked”, i sogni di chi lavora così tanto che a fine giornata ha un solo desiderio: avere tempo.
2
Di fatto, l’immaginario delle grandi dimissioni torna spesso allo stesso tema: il tempo per vivere. Spostandoci dall’altro lato del mondo rispetto agli Stati Uniti, è interessante guardare cosa accade in Cina, dove la critica al lavoro si è espressa con un movimento di protesta detto Tang ping (躺平, «sdraiarsi»), che nasce come una forma di resistenza culturale al 996, un sistema che richiede di lavorare dalle nove alle ventuno per sei giorni alla settimana. Il Tang ping è nato nell’aprile 2021 quando un post di Luo Huazhong è diventato virale. Luo Huazhong era un operaio della provincia cinese Sichuan, che, dopo anni in fabbrica, nel 2021 si è dimesso ed è andato in bicicletta dalla provincia di Sichuan al Tibet, percorrendo circa milletrecento chilometri e mantenendosi con lavori saltuari. “Dopo aver lavorato così a lungo, mi sentivo intorpidito, come una macchina”, ha scritto. “E così mi sono dimesso”.
“Non lavoro da due anni e non ci vedo nulla di male. La pressione [a lavorare] proviene principalmente dalle persone che ti circondano e che sono in competizione con te, ma anche dai valori della vecchia generazione. Siamo costretti a gestire ogni sorta di pressione. […] Ma non deve essere così. Posso dormire al sole come Diogene, o vivere in una caverna come Eraclito e pensare al logos. E dato che questa terra non ha mai avuto una scuola di pensiero che esalti la soggettività umana, posso svilupparne una mia. Stare sdraiati è il mio movimento. Solo sdraiati, gli esseri umani possono essere all’altezza delle situazioni”.
Luo Huazhong si è dimesso e ha preso in mano la bicicletta.

Per quanto la sua storia possa sembrare eccentrica, ci dice qualche cosa di significativo sul presente. Dice che il lavoro si è mangiato la nostra esistenza, al punto che c’è chi è costretto a lasciare la propria fonte di reddito per fare cose che un tempo erano compatibili con il lavoro, come riposare o banalmente vivere. Ivan Franceschini, ricercatore dell’Australian National University che da anni si occupa di lavoro in Cina, spiega che l’espressione tang ping descrive “una sorta di resistenza passiva ai ritmi sfrenati della vita lavorativa in Cina, vissuta soprattutto dai giovani lavoratori delle aziende tecnologiche o legate alla nuova economia”. Dietro questa protesta c’è un modello produttivo fondato sul superlavoro, in cui lo stesso 996 sottende spesso turni di circa quindici o sedici ore al giorno, al punto che non è raro leggere di casi di suicidio causati dal troppo lavoro o parlare di morte da troppo lavoro: un fenomeno che in Cina si chiama guolaosi e uccide circa seicentomila (sei-cento-mila) individui ogni anno.
Per decenni, la popolazione ha tollerato tutto questo nella speranza che il loro sacrificio consentisse di migliorare il proprio futuro, ha scritto la giornalista e autrice Jianan Qian in un articolo sul New York Times. Oggi, questa sofferenza ha perso senso. Un tempo, il lavoro consentiva di migliorare la propria posizione sociale e di avere una casa. Oggi è una “inutile ruota del criceto” che intrappola i partecipanti in un “ciclo infinito di autoflagellazione”, ha scritto Xiang Biao. Per Biao, oggi le persone lavorano sempre ma non hanno alcun tipo di mobilità, come una persona che corre sempre ma resta ferma nello stesso punto e giorno dopo giorno deve trovare una nuova motivazione per andare avanti, come una Sisifo costretta a spingere un masso verso la cima del monte per l’eternità.
Per molti versi, per comprendere le grandi dimissioni bisogna partire da qui: dalla posizione impossibile in cui troppo spesso viene messo chi lavora, costretto a dover scegliere tra rovinarsi la salute per lavorare come una macchina o dimettersi per stare meglio anche se questo significa non avere i soldi per vivere.
3
Tempo fa, lo psicanalista Josh Cohen ha raccontato sull’«Economist» la storia di Steve, giovane cresciuto come figlio unico di una famiglia facoltosa. I voti alti, la squadra di baseball e la borsa di studio lo avevano preparato alla vita a cui era stato destinato. “Non era tanto come se stessi facendo tutte queste cose fantastiche, quanto piuttosto come se mi stessi inserendo nel ruolo che avevano già scritto per me”. Steve aveva vissuto la sua intera esistenza in quel ruolo, finché, un bel mattino, quando la sua sveglia suona alle 5.40 per andare a lavoro, lui la spegne, si gira dall’altra parte e al lavoro non si presenta più. “I suoi desideri erano come un muscolo negletto”, scrive lo psicanalista Josh Cohen nel raccontare la vicenda di Steve. Nel libro intitolato Not working. Why we need to stop (Granta Books, 2018), Cohen rivela cosa avviene nel suo studio quando persone come Steve cercano il suo aiuto. In molti casi, i suoi pazienti sono persone in burnout che per lungo tempo hanno delegato le proprie decisioni a una specie di pilota automatico. In questi casi, non c’è una ragione singola per la quale le persone mollano, né queste ragioni sono, spesso, equiparabili. In ogni caso, però, il corpo d’improvviso riprende controllo della propria esistenza. Josh Cohen, non a caso, dice che tutte queste “storie di reclusione” vengono interrotte da una condizione simile: un irrefrenabile e sovversivo impulso di vivere.
Da questo punto di vista, questi scampoli di immaginario dicono molto del nostro tempo. Dicono, ad esempio, che il bisogno di riposare, di perdere tempo, di sdraiarsi, di sedere in veranda: l’arte dell’indugiare, come la chiama Byung-Chul Han, sono la nemesi del presente. Detto altrimenti, l’urgenza di proteggere il proprio tempo libero, oggi, non nasce dal fatto che gli attribuiamo un valore diverso rispetto a quanto accadeva in passato, come viene spesso detto. Nasce dal fatto che oggi, spesso, il tempo libero non esiste più. Rispetto a quanto accadeva una generazione fa, quando un lavoro da quaranta ore a settimana spesso consentiva a una sola persona di mantenere un intero nucleo famigliare, oggi il lavoro rende meno e chiede di più. In questo senso, il tempo della veranda parla dell’urgenza di riequilibrare un modello organizzativo che ha sequestrato l’esistenza infilandola in una griglia di Doodle e file Excel, senza lasciarle scampo.
4
“Spero che questa e-mail non ti trovi. Spero che tu sia fuggito, che tu sia libero“. In questo contesto, il lavoro è al centro di una diffusa disaffezione. Dopo anni in cui il mondo ha cantato le virtù dell’etica del lavoro, dell’efficienza e della competizione, suggerendoci di rendere produttivo ogni istante della nostra vita, oggi emerge in erba una produzione culturale indipendente che sostiene l’importanza spirituale del non fare nulla. Il personaggio di fantasia Self-Help Singh interpretato dal comico indiano Masood Boomgaard, ne è l’epitome. Self-Help Singh è un “de-motivatore professionale” il cui fine e stimolare le persone a non fare niente.
“Sveglia alle cinque del mattino? Pessima idea. Sveglia alle undici del mattino? Un’idea assai migliore. Smettila di fare le cose che non vuoi fare. Trova delle scuse, scrivi un libro di scuse e tieni sempre una scusa pronta. Nike dice Just do it. Self-Help Singh dice Do nothing, “non fare nulla”.
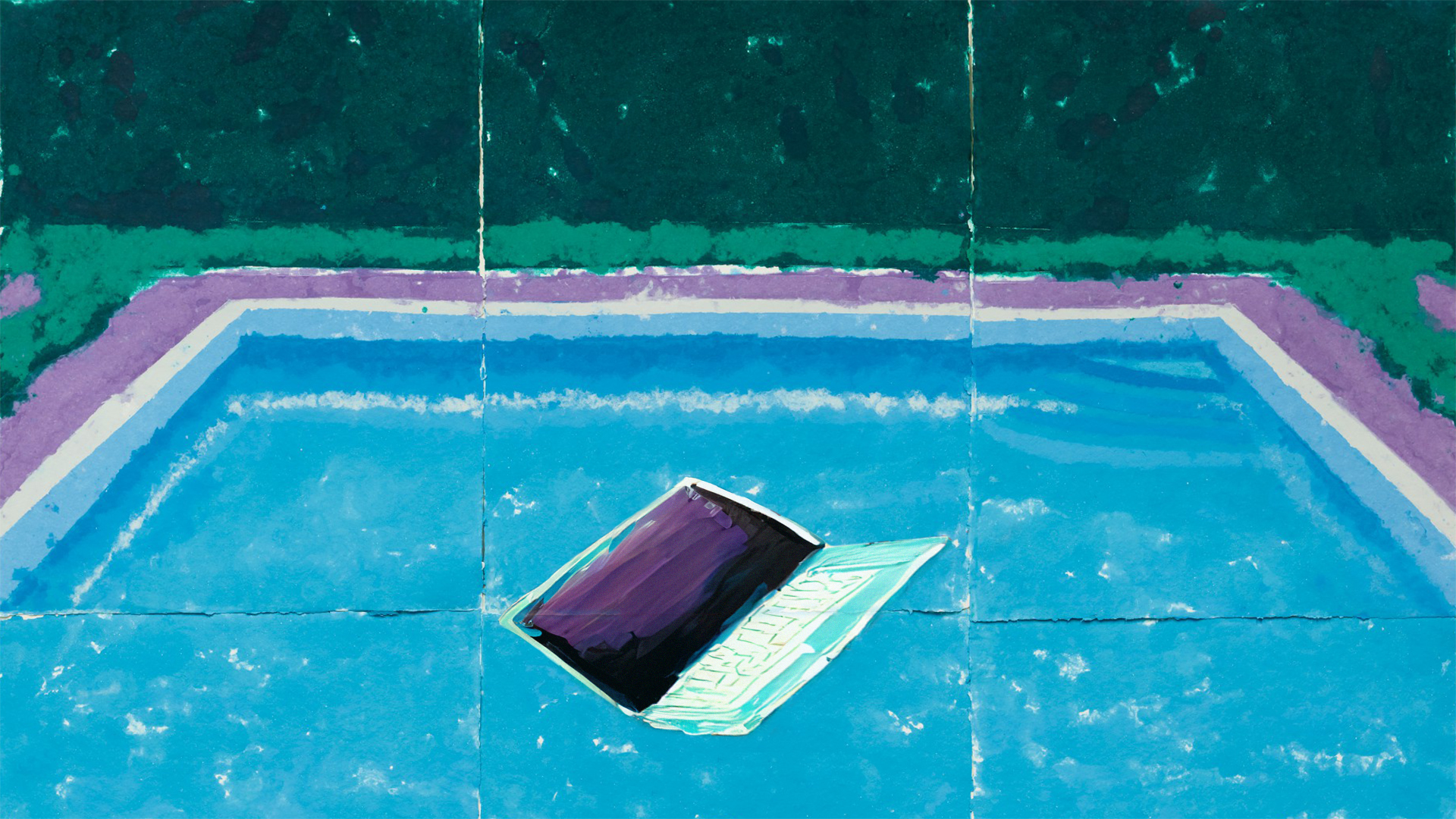
Controcanti come quello di Self-Help Singh spaziano dalle piazze francesi a opere come After Work di Erik Gandini, il regista che canta un futuro senza lavoro. Passando per il libro dallo stesso titolo di Helen Hester e Nick Srnicek; dal pezzo di Omar Chilena Malattia (“Oggi e domani / malattia / todos los dias / malattia / non voglio lavorare / malattia / mi sono rotto il cazzo devo fare malattia): sino a Io non lavoro più, del comico Frank Gramuglia (Io non lavoro più / questa è una schiavitù / sono anni che mi sbatto / mi fate uscire pazzo / adesso fallo tu / io non faccio un caxxo), o a Snoopy, del gruppo napoletano Addolorata (e allora basta, adesso mi licenzio / anzi no mi faccio licenziare / cosi è lo stato che mi dovrà pagare / tutta l’estate sulla sdraio al mare). Questi testi ironici sono spesso l’altra faccia di una situazione tragica, in cui il desiderio di non fare nulla è la chimera a cui si aggrappa per sopravvivere chi vive una condizione di burnout permanente da lavoro povero. Per uscirne, bisogna cambiare un modello produttivo fondato su organici ridotti all’osso, salari bassi, part-time involontari, pratiche antisindacali, lavoro gratuito e il dumping contrattuale.
O decidere che da domani ce ne stiamo tutti seduti in veranda.
Progetto grafico realizzato tramite AI a partire dai lavori di David Hockney.