Ogni discussione sul clima sta diventando una discussione sul capitalismo. Lo scontro è tra chi chiede un cambiamento radicale e chi è convinto che basti una riforma del mercato. Nel frattempo la crisi avanza. Come se ne esce?
C’è una domanda politica ormai emersa come decisiva dentro la lotta ai cambiamenti climatici: sarà il capitalismo a risolvere un collasso che il capitalismo ha creato, o dobbiamo iniziare a parlare davvero di un superamento del modello? Oppure sarà la crisi climatica a presentare il conto al capitalismo?
I troll sono i termometri più accurati per queste cose, infatti la sintesi del dibattito sta in un meme pubblicato da Elon Musk che riprende una famosa scena del documentario sulla vita di David Beckham sostituendo il volto di Victoria Adams con quello dell’attivista per il clima Clover Hogan.
Clover Hogan dice: “Voglio combattere il cambiamento climatico”.
David: “Sii onesta”.
“Sono onesta!”.
“Dai”.
“Okay, voglio il comunismo”.
Musk la butta in caciara: la sua è la “versione materialismo dialettico” della reductio ad hitlerum, quando dai a caso del nazista a qualcuno in una discussione in cui non riesci a prevalere in altro modo.
Ma è un segnale anche questo: ogni discussione sul clima sta diventando una discussione sul capitalismo. A questo punto sarebbe bello poter scrivere questo articolo senza citare la massima del critico letterario Fredric Jameson, spesso attribuita al filosofo Mark Fisher: “È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo”.
Invece siamo ancora lì, anzi, quel concetto oggi torna ancora più utile, perché finalmente ha compiuto il suo viaggio da paradosso a parabola. Quando è stata formulata, la frase era un modo per verbalizzare la difficoltà di superare il capitalismo, paragonandone la fine a qualcosa di impensabile, come l’apocalisse. Oggi è un modo per chiedersi: siamo quindi disposti ad accettare persino il tracollo delle basi fisiche della civiltà umana pur di salvare il capitalismo?
“Sarà il capitalismo a risolvere un collasso che il capitalismo ha creato, o dobbiamo iniziare a parlare davvero di un superamento del modello?”
Anche se la politica istituzionale sembra del tutto impermeabile, questo è un dibattito ormai spalancato. Nessun (grande) partito occidentale è interessato o capace di mettere in discussione i paradigmi base; sono tutti alla ricerca di un modo per starci più comodi dentro con le loro idee. Il dibattito avviene più in basso, al livello dei movimenti per il clima (che sono tutti a qualche titolo anticapitalisti), sia più in alto, nel mondo dell’accademia e della saggistica. Il capitalismo, dopo trent’anni di lotta non così efficace alla crisi climatica, si trova per la prima volta da decenni ad avere l’onere della prova: è davvero il modo migliore che abbiamo per uscire da questo guaio? Ed è davvero impensabile rivolgersi altrove?
La lotta ai cambiamenti climatici inizia ufficialmente nella prima metà degli anni Novanta, tra il summit di Rio, la nascita della Convenzione quadro dell’ONU sul clima (1992) e la prima conferenza sul clima, la COP1 (1995). Non erano tempi facili per la critica anticapitalista. Perfino le formule con le quali si scelse di verbalizzare il problema riflettevano questa difficoltà. Da quando misuriamo il riscaldamento globale, diciamo che le temperature sono aumentate “rispetto all’era pre-industriale”è una formula neutra ed educata, che sostituisce la tecnologia col sistema che l’ha abilitata. Nessuno, nel 1995, avrebbe osato dire: “temperature più alte rispetto all’inizio del capitalismo”, perché quel sistema economico non era visto come la causa del problema, ma come la soluzione. Era ancora vivo il sogno tecno-ottimista, l’idea che l’interazione di ricerca e capitale avrebbe risolto tutti i nostri problemi senza intaccare lo stile di vita di nessuno, né tantomeno quello americano, che George Bush nel 1992 a Rio definì come “non negoziabile”.
Nel 2024, moltissime COP dopo, le emissioni continuano a correre (il 2023 è stato un anno da record per tutti i gas serra), le temperature pure (undici mesi di fila come i più caldi da quando ci sono le registrazioni. E il capitalismo). La transizione energetica sta avvenendo, ma sta anche seguendo le logiche e i tempi dell’economia, non le richieste del pianeta, o della scienza. Stiamo aggiungendo energia pulita e rinnovabile a quella sporca, senza sostituirne, in un all you can eat energetico in cui non si butta via nulla. Questi sforzi hanno fatto scendere la quota di fonti fossili dall’85 all’82 per cento. Stiamo, insomma, solo allargando la torta. Le tre fonti fossili (carbone, petrolio e gas) continuano a prosperare. Il fatto che questa sia la fine di un’era nella storia dell’energia ha dato all’estrazione di idrocarburi l’euforia dell’ultima settimana che trascorri in una casa che non hai amato prima di trasferirti in un’altra, quando sporchi ancora di più, dando una specie di grande ultima festa, nella certezza che non sarai rintracciato. Da qui al 2030 la produzione di petrolio e gas quadruplicherà.
Quando era CEO di ExxonMobil, Rex Tillerson disse: “Voi ci state chiedendo di scegliere di perdere volontariamente dei soldi”. Tillerson poi sarebbe stato anche segretario di stato di Trump, ma è un’altra storia. Quel giorno aveva detto una cosa intelligente, perché tutto sommato sì, è vero, si chiedeva a ExxonMobil di scegliere di perdere volontariamente dei soldi, perché la finestra di business e quella di stabilizzazione del clima non coincidono. È come una prova di forza, a qualcuno a un certo punto deve cedere.
Da un punto di vista aziendale, nessuno può chiedere a Tillerson, Exxon e agli azionisti di perdere dei soldi, se ci sono ancora profitti da fare (e ce ne sono). Da un punto di vista fisico, organico e planetario, sì, invece. Si può fare questa richiesta. È una richiesta legittima. Perché, a differenza della metafora dell’ultima festa in una casa che si sta lasciando, noi non abbiamo un altro appartamento in cui trasferirci. Lo visualizzò bene una vignetta del «New Yorker», che in fondo diceva le stesse cose di Tillerson: ci sono dei bambini, intorno a un fuocherello, vestiti di stracci, una situazione da post-apocalisse climatica: “Si, è vero, il pianeta è stato distrutto,” dicono “ma per un breve momento nel tempo abbiamo creato valore per gli azionisti ed è stato bellissimo”.
Dal punto di vista editoriale, quella sull’inquietudine climatica anti-capitalista è una produzione ormai ampia. Uno dei libri recenti più interessanti si intitola Quanto vale una balena, di Adrienne Buller (add). Quando l’ho citato a un altro esperto intervistato per questo articolo, Akshat Rathi di Bloomberg – autore di Climate Capitalism –, lui ha reagito con una smorfia. Dicendo: “Ah. Si. Quel libro sulla balena scritto da quella idealista”. Quanto vale una balena ha fatto in effetti arrabbiare molte persone. La domanda del titolo è strettamente finanziaria: quanti soldi vale un grande mammifero acquatico? Secondo una stima del Fondo monetario internazionale: circa due milioni di dollari (solo quelli grandi).
Per lo stock globale esistente si calcolava un forfait di mille miliardi. È una domanda allo stesso tempo pragmatica, inquietante e assurda. È pragmatica: se trovassimo il modo di dimostrare che il cetaceo vale più da vivo che da morto, forse gli avremmo salvato la vita, non tanto dalle minacce dei libri di Melville, quanto da inquinamento, acidificazione, perdita di habitat, collisioni. È inquietante: e se avessimo scoperto, o scoprissimo, che da viva la balena vale di meno che da morta, questo sarebbe un via libera a fregarcene? Ed è assurda: viviamo in un paradigma così consolidato che ormai, implicitamente o meno, chiediamo agli animali (così come alle foreste, all’atmosfera, agli oceani) di mettersi sul mercato e dimostrare il loro valore economico, perché da qui passa la loro sopravvivenza.

La domanda da cui parte Buller sulla balena è una metonimia politica per introdurre il capitalismo verde, le sue illusioni e i suoi malfunzionamenti. Da lì, segue un elenco lungo e sconfortante. Nel 2006 il rapporto dell’economista Nicholas Stern sul cambiamento climatico lo definiva come “il più grande fallimento di mercato della storia”. All’epoca fu accolto da qualcuno come oggi reagiamo a una protesta di Ultima generazione (c’è un articolo su La Voce che lo accusa di “inutili allarmismi”).
Oggi Buller lo descrive come il manifesto del realismo capitalista. L’idea di quel rapporto era che si potesse insegnare al mercato e ai suoi operatori a riconoscere i costi ecologici nascosti e che inserirli progressivamente nelle loro valutazioni avrebbe corretto la rotta verso il collasso. Il rapporto Stern tra poco compirà vent’anni e non sembra aver beneficiato granché alla stabilità del clima.
Tutti gli anni più caldi nella storia del capitalismo sono arrivati dopo questo riconoscimento, periodo nel quale le emissioni hanno continuato a crescere. La policy principale proposta da questa lettura del capitalismo climatico, fissare un prezzo alle emissioni di carbonio, si è rivelata secondo Buller una chimera. I mercati dei capitali non sono in grado di reagire ai rischi climatici, perché pensano al rischio come se fosse racchiuso tra le facce di un dado, uno, due, tre, quattro, cinque o al massimo sei. “I mercati sono pensati per gestire il rischio, ma non l’incertezza, speciale quella radicale che caratterizza la biosfera, il clima della Terra e le loro interazioni”. I danni ecologici sono più grandi, gravi ed esistenziali per prendersi qualsiasi ulteriore rischio, escono dalle possibilità racchiuse dalle facce del dado. La gravità degli esiti richiederebbe un principio di precauzione di cui il sistema, secondo Buller, è incapace.
Il punto è che siamo in una situazione di stallo. Gli intellettuali anticapitalisti e quelli capitalisti sembrano avere ragione entrambi. Da un lato, il sistema non sta funzionando, ed è un fatto. Dall’altro, nessuno oggi ha un’alternativa a questo sistema. Quando ho sottoposto la questione a Buller, mi ha risposto così: “Quando il capitalismo è tutto quello che abbiamo sempre conosciuto, è profondamente difficile immaginare, progettare e combattere per delle alternative. Come persona che scrive in modo critico del capitalismo, spesso ricevo risposte che suggeriscono due alternative: o il capitalismo o una specie di caricatura di un regime comunista del ventesimo secolo. Questo per me è un fallimento di immaginazione”. O un meme di Elon Musk.
Filippo Menga è docente di geografia dell’Università di Bergamo e ha affrontato questo problema da un angolo diverso: l’acqua. Ha da poco pubblicato per Ponte alle Grazie Sete, una critica piuttosto radicale del capitalismo idrico. Racconta come stiamo sfornando rimedi su ogni scala (dai dissalatori all’acqua minerale all’agricoltura di precisione), prodotti la cui economia si basa sul fatto che la crisi sia strutturale, permanente, una costante con cui generare profitti e non un problema da curare. Chiedere al capitalismo di farlo è come implorare lo scorpione di non uccidere la rana. “La crisi idrica si sta aggravando nonostante le soluzioni, perché le soluzioni non sono pensate per essere soluzioni”, spiega Menga.
Uno dei pilastri emotivi dell’approccio “capitalismo come soluzione” è una specie di ottimismo statistico fondato su dati in apparenza incontrovertibili. È per esempio quello che ha fatto emergere la voce di Hannah Ritchie, ricercatrice di Oxford, autrice di una seguitissima newsletter (Sustainability by Numbers) e di un libro da poco uscito in Italia per Aboca, Non è la fine del mondo, la cui lettura di fondo è che hey, non ce la stiamo passando così male, perché stiamo installando sempre più rinnovabili, perché ci sono meno persone che muoiono a causa dei disastri, perché siamo stati in grado di chiudere il buco nell’ozono, salvare le balene dalla caccia internazionale, ridurre la deforestazione e abbiamo già abbassato la traiettoria di aumento delle temperature, che prima dell’accordo di Parigi era di oltre +4°C. Molte di queste informazioni possono essere in realtà confutate: le rinnovabili crescono troppo lentamente, l’Amazzonia sta diventando una savana, i dati sulle catastrofi non riescono a conteggiare i morti delle ondate di calore (18mila in Italia nel 2022) e così via.
“Siamo in una situazione di stallo. Gli intellettuali anticapitalisti e quelli capitalisti sembrano avere ragione entrambi. Da un lato, il sistema non sta funzionando, ed è un fatto. Dall’altro, nessuno oggi ha un’alternativa a questo sistema”.
La diversità di queste prospettive, tutte fondate, dimostra che oggi il clima e la transizione, con l’enormità dei dati che producono, rischiano di essere una specie di libro esoterico in cui chiunque può trovare la risposte che cercava in partenza. Nella stessa settimana può uscire un sondaggio del «Guardian» secondo il quale la metà degli scienziati IPCC prevede aumenti di temperatura apocalittici e la ricerca di un rispettato think tank (Ember) che prova a tirarti su dicendo che nel 2023 un terzo dell’elettricità (che non è tutta l’energia, ma un bel pezzo) era da fonti rinnovabili e che il picco è vicino. L’ottimismo è diventato una commodity come un’altra, un prodotto che è più facile accumulare quando se ne dispongono già grandi quantità. Il clima è un effetto delle diseguaglianze che genera ulteriori diseguaglianze, e la posizione da cui si osservano i dati spinge a sceglierli in base alle proprie esigenze politiche o esistenziali, all’umore, alla predisposizione d’animo.
In questo momento l’urgenza della crisi climatica, il fatto che il problema vada affrontato in una finestra di tempo chiusa, è il principale alleato del realismo capitalista. In pochi anni siamo passati da “questo è il migliore dei sistemi possibili” a “tanto non c’è tempo per risolvere il problema climatico e contemporaneamente cercare un nuovo modello economico per riuscirci, quindi tocca fare con quello che abbiamo”.
È, in fondo, questo il punto di partenza di Climate Capitalism, il saggio di Akshat Rathi, il giornalista che considera Adrienne Buller e il suo approccio del tutto idealisti. “Non penso che quello capitalista sia il solo sistema che possa funzionare”, mi dice, “ma è l’unico che può riuscirci nella deadline che hanno fissato gli scienziati. Oggi non esiste un’alternativa, ma solo brandelli di idee che nessuno ha organizzato o reso operative”. Neanche la recente riscoperta del marxismo in chiave ecologica, partita dal Giappone con i saggi di Kohei Sato, è un modello di governo dell’economia o di un mondo in crisi. Per Rathi, esperto giornalista sulle questioni climatiche e sulle sue intersezioni con l’economia, “non esiste il libero mercato in senso assoluto, c’è sempre un sistema che regola la ricerca del profitto, composto dai governi e dalla natura”.
Il suo pensiero è: le regole naturali sono fisse, possiamo però migliorare quelle pubbliche, abbiamo lasciato troppo spazio alla ricerca di profitto non governata. Non ci serve un altro sistema, ci servono regole migliori per quello che abbiamo oggi. Senza intaccare i meccanismi base del gioco come lo abbiamo conosciuto oggi: le aziende trovano soluzioni, offrono prodotti, servizi, energia, guidate dalla ricerca di un profitto. Ogni sistema politico troverà il suo funzionamento ideale. A questo punto della storia, però, questa sembra una visione idealista tanto quanto cercare un valore intrinseco e non monetario della balena, degli ecosistemi o del clima. Oggi è come se fossimo in una relazione tossica con un sistema che più continua a distruggere più ci convinciamo che possa, un giorno, cambiare, e diventare migliore di quello che è. È come se capitalismo e anticapitalismo fossero entrambe soluzioni ideologiche.
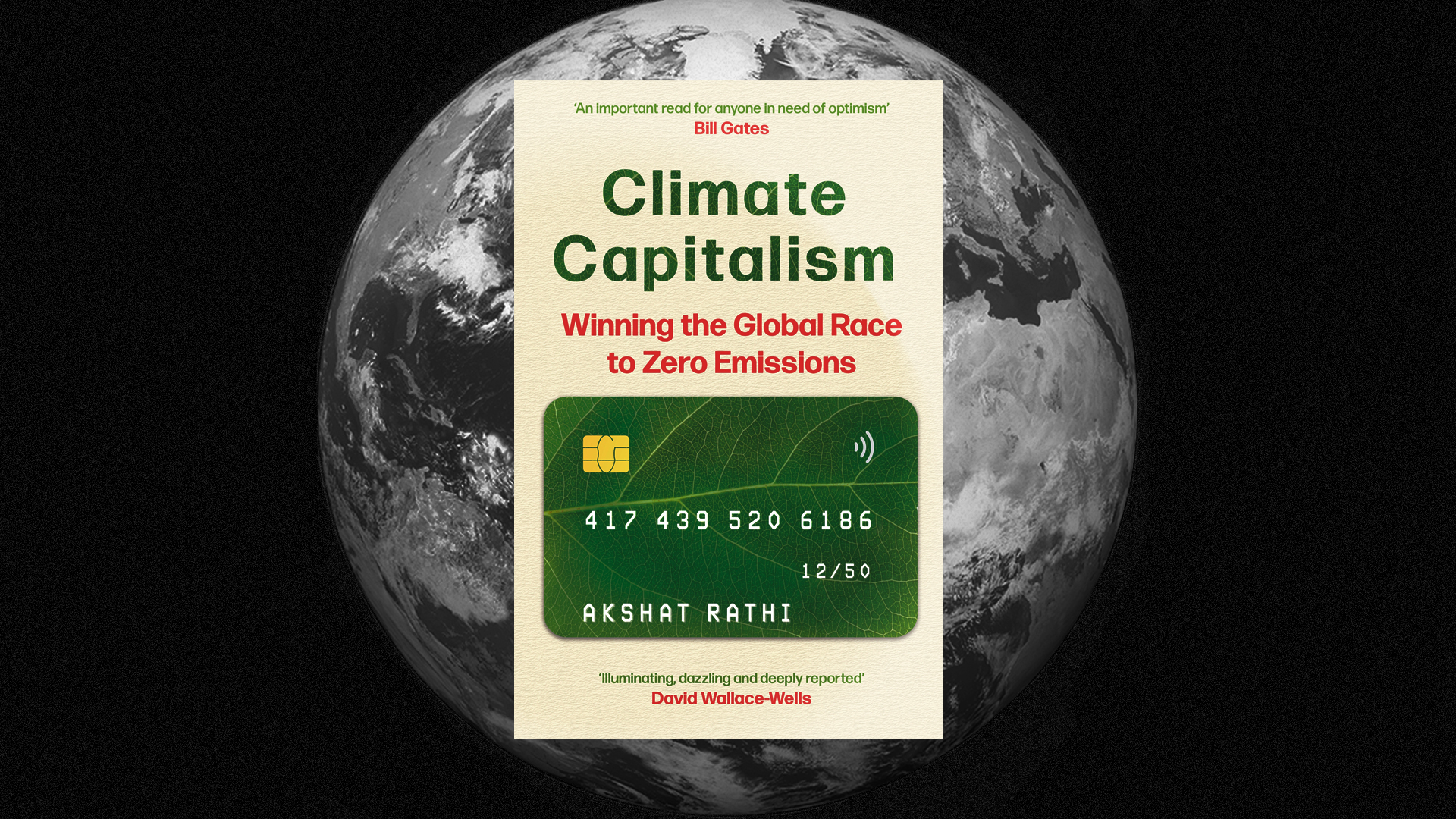
La crisi climatica non avrà esiti binari, non è come una guerra o una partita di calcio in cui sarà chiaro se avremo vinto o perso. Qualunque sarà lo scenario di approdo, che sia un mondo di 2° o 4°C più caldo rispetto all’era pre-industriale (o come la si voglia definire), Akshat Rathi potrà dire: “senza il capitalismo sarebbe stato peggio”, Adrienne Buller dirà “senza il capitalismo sarebbe stato meglio”. Però c’è un’altra verità spietata, e la offre Alessio Terzi, economista di Science Po a Parigi, in uscita in Italia con il libro La crescita verde (Edizioni ambiente). “C’è tutta una letteratura che arriva alla conclusione che siccome il sistema economico ha tutti questi problemi irrisolti di lungo periodo, il sistema va abbattuto. Ma non sta avvenendo nessuna rivoluzione, non c’è proprio il sentore di una rivoluzione nell’aria”. E questo è un fatto, ci saranno anche brandelli di cambiamento, si potrà anche palpitare per il prezioso piano industriale di transizione pubblica dell’ex GKN a Campi Bisenzio, ma non sta avvenendo niente che faccia presagire un cambio di sistema imminente su vasta scala. Terzi però aggiunge. “Il pregio del capitalismo è la sua flessibilità, si possono fare tanti cambiamenti virtuosi dentro il sistema senza bisogno di abbatterlo”.
Secondo Terzi, la lettura classica proposta finora dagli economisti che tutto si risolverà mettendo un prezzo alle emissioni di carbonio è velleitaria quanto l’idea di abbattere il capitalismo nella sua interezza. La trasformazione richiesta è meno meccanica e più complessa. “La prima rivoluzione industriale ha avuto quasi un secolo di tempo per svilupparsi, la seconda è avvenuta in cinquant’anni, questa ha trent’anni, ha poco tempo e quindi ha bisogno di essere guidata da politiche pubbliche e industriali. Il sistema in sé non impone niente, non una agency, una volontà che impone la direzione delle cose, non sarà il sistema a combattere il cambiamento climatico, ma le persone, con le loro motivazioni, industriali, personali e culturali”. Terzi fa l’esempio del capitalista più simbolico e tossico della nostra epoca, che vale anche come parabola perfetta per mostrare come da una stessa vicenda si possano trarre letture opposte: proprio lui, Elon Musk.
Il fondatore di Tesla è l’evoluzione finale del sistema nelle sue forme più predatorie o è l’imprenditore che più ha contribuito all’elettrificazione e alla decarbonizzazione del settore più impattante al mondo, quello dei trasporti? “Per me è l’esempio giusto per dire che non mitigheremo mai la crisi climatica guidati solo da imperativi morali. Sicuramente Musk non ha nessuna bussola morale, è un imprenditore che vede delle opportunità e cerca di coglierle, portando avanti la transizione soppiantando aziende e prodotti inquinanti, creando nuovi modelli e stili di vita che a cascata le persone desiderano e vogliono imitare. Così si produce cambiamento”.
“Oggi è come se fossimo in una relazione tossica con un sistema che più continua a distruggere più ci convinciamo che possa, un giorno, cambiare, e diventare migliore di quello che è”.
La transizione modello Tesla oggi è la ricetta migliore che possa offrire il capitalismo di fronte al dilemma della crisi climatica: decarbonizzazione ed elettrificazione senza offrire un nuovo patto sociale, replicando gli schemi di funzionamento del mondo di prima, probabilmente aggravandone le diseguaglianze. Il modello Tesla è anche la ragione per cui l’ecologia del clima in pochi anni ha visto la sua reputazione passare da progetto rivoluzionario dal basso, con le piazze di milioni di ragazze e ragazzi Fridays for Future, a minaccia elitaria in grado di essere carburante per vecchi e nuovi populismi.
Non a caso, è vero che Musk tecnicamente ha fatto più di chiunque altro per ridurre le emissioni di gas serra, ma nessun movimento per il clima si sognerebbe mai di presentarlo come una bandiera, e non solo per le sue ossessioni, la transfobia o l’antisindacalismo. Elon Musk è la risposta vecchia ai problemi nuovi, è la transizione come veniva immaginata dal rapporto Stern, risolve un fallimento di mercato creando nuovi prodotti a basse emissioni. Può bastare? Dipende se lo chiediamo a un economista o uno scienziato, ma dipende anche se lo chiediamo a una persona povera o una persona ricca, se facciamo questa domanda al nord globale dove si vendono le Tesla o al sud globale dove si estraggono i metalli per le batterie.
La decarbonizzazione guidata dal mercato ci permetterà probabilmente di frenare la crisi in un punto intermedio sopra i 2°C e sotto i 3°C, nel quale le economie più ricche e le classi sociali più attrezzate potranno forse adattarsi, in modi vari che vanno dalla casa in montagna alla barriera contro linnalzamento del livello del mare. E tutti gli altri saranno poveri come lo erano nel mondo fossile, forse anche più poveri, ma dovranno anche affrontare la loro povertà con la variante di un clima impazzito. Il punto è che non c’è nessuna rivoluzione in cantiere, è vero, ma non è detto che non ci saranno sollevazioni, di vario genere, se le diseguaglianze, come previsto dal modello Tesla, diventeranno più gravi, mentre la temperatura salirà, gli eventi estremi aumenteranno. E quindi?

Il paradosso è che sia le voci pro-capitalismo che quelle pro-balena hanno una richiesta in comune, che poi è un dito in un occhio al capitalismo predatorio di vecchia o nuova ortodossia: più politica, più regole, più antidoti, più intervento pubblico. Che sia per mettere un freno alla rapacità del libero mercato senza regole, o instaurare sistemi di gestione dei beni comuni, sembra passata almeno l’idea che senza correzioni l’iniziativa privata come immaginata dal neoliberismo è destinata a mandarci al collasso. Ciascuna con la sua ricetta, ma tutte le grandi economie (UE, Cina, Stati Uniti) si stanno preparando al mondo nuovo rafforzando la presa sul volante del settore pubblico. Cosa deciderà questa mano sul volante nelle autocrazie o nelle dittature come la Cina è difficile prevederlo, ma cosa farà nelle democrazie tocca a noi deciderlo.
È una soluzione noiosamente riformista, ma se non potremo abbattere il capitalismo nell’arco delle nostre vite, almeno potremo avviare una correzione. Adrienne Buller propone una lista di idee che lascio qui a chiusura, perché mi sembra utile: “Fare leva sulla proprietà pubblica e democratica, istituire sistemi di gestione e governo della natura basati sui beni comuni, adottare investimenti pubblici piuttosto che affidarsi a meccanismi finanziari privati estrattivi, affrontare il potere dell’industria dei combustibili fossili e gestirne il declino a un ritmo rapido, trasferimenti di tecnologia su scala, comprendere che affrontare la crisi ecologica richiede un programma redistributivo che riconosca la responsabilità storica di questa crisi”.
Insomma, sfruttare l’unico set di strumenti che abbiamo tutti in dotazione: la partecipazione pubblica e politica.






